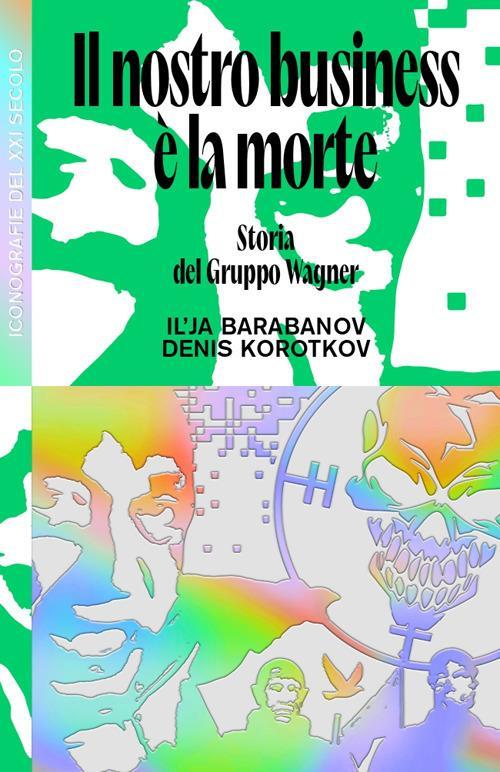Appunti sul meticciato da New York (parte 1)

Tra mescolanze, mosaici e insalatiere
“Non me ne frega un cavolo se sei mulatto o meno”. […] “Io non sono un mulatto, Mr. Crowle. Mia madre era una cuarteron, e mio padre era bianco. Questo fa di me un meticcio”. “Meticcio o mulatto per me è la stessa roba, sempre colorato è…”
Fiume di papaveri, Amitav Gosh
Preludio
New York è una città che irrompe e si inscrive nella propria fantasia per tanti aspetti. Eppure ce n’è uno in particolare che, attraversandola, sgocciola dentro i pensieri lasciando tracce di riflessione che ritornano costantemente in modo ora vivido ora frammentario. Ed è nella luce artificiale dell’underground che queste immagini si cristallizzano. Gli sferraglianti vagono della subway sono infatti il teatro della più ampia rappresentazione dell’eterogeneità umana. E’ in essi che si materializzano sequenze di cangianti paesaggi di passaggio in cui il più disteso spettro del possibile viene a depositarsi per brevi minuti, fra una fermata e l’altra. E’ più facile fotografarli e descriverli, piuttosto che parlarne immaginandoli, in quanto è una realtà che spesso eccede le capacità immaginative. Si determinano vortici di differenze che assorbono l’aria della città. E’ a partire da queste sensazioni che provo a sistematizzare in forma analitica alcune riflessioni su modelli e dinamiche dell’interazione umana.
Cultura e migrazioni a New York
Negli Usa sociologia urbana e delle migrazioni erano discipline indistinguibili alle origini. Anzi: la sociologia americana in generale nasce come sostanziale studio dei processi di formazione metropolitana attraverso le migrazioni da tutto il mondo. Più che altrove pertanto società, metropoli e genti in movimento tendono a formare un tutt’uno informe. Uno strano amalgama portante delle migrazioni alcuni segni caratteristici: l’essere sacrificio e decisione, lacerazione e avventura. Oltre che ovviamente necessità economica sia per chi la subisce sia per chi la sfrutta. D’altra parte gli Stati Uniti sono frutto di popolazioni in movimento: i colonizzatori che attraversano l’oceano; il costante allontanamento degli indigeni dalle loro terre; l’esportazione forzata di schiavi dall’Africa; la cacciata di molti latinos dal Sud; eppoi le costanti e mai fermatesi ondate migratorie che hanno visto affluire persone da tutti i continenti. Un sistema dunque in grado e con la necessità di accogliere ed inserire. Accoglimento ed inserimento le cui forme andremo a guardare nel corso dell’articolo, nelle modalità complesse e articolate di inclusione differenziale, esclusione e gerarchizzazione basate su un principio di inviolabilità delle regole, imposto talvolta anche con estrema ferocia.
Se questo è il contesto generale, restringerò ora il campo analitico a New York, cercando di usarla come angolo visuale. Una scelta sicuramente parziale e criticabile. Da un lato infatti c’è chi considera questa metropoli come emblema degli Stati Uniti, ossia come punta più avanzata delle tendenze in atto in questo paese. Altri invece sostengono che essa sia un’anomalia, la città meno americana degli Usa. Prendiamole entrambe per buone, teniamo aperta questa contrapposizione e facciamola stridere.
Partiamo dunque da un elemento simbolico: Ellis Island. Nello spazio di accesso alle frontiere sud-europee è noto come i tentativi di governo delle migrazioni tendano a disporre confini a forma di imbuto, per far convergere i flussi di persone verso singoli punti. Lampedusa è ormai elemento affermato di questi tentativi di gestione. Tuttavia un’altra isola, Ellis Island appunto, ha svolto questo triste ruolo rispetto ad un altro mare. Questo piccolo lembo di terra sulla foce del fiume Hudson ha rappresentato per circa 60 anni (sino alla sua chiusura nel 1954) il primo approdo per milioni di migranti (si stima che almeno 12 milioni ne siano passati per l’isola). Qui essi venivano controllati e contrassegnati sulla schiena con un gesso per indicarne le condizioni di salute, e coloro con problemi fisici o mentali (o per altri motivi sgraditi) venivano rispediti indietro. Dopo questa selezione le masse in movimento potevano accedere ad un’altra più grande isola, Manhattan, dalla quale iniziava uno spostamento verso altri quartieri o altre zone del paese. Molti tuttavia si stabilivano a New York. Questa è stata la dinamica che ha storicamente costituito il profilo della metropoli attuale, mentre sono altri i meccanismi attraverso i quali le grandi città europee si sono storicamente formate. Scorrendoli velocemente, possiamo tipizzare principalmente tre movimenti del loro generarsi: o fungendo da polo attrattore, conseguentemente all’accentramento di potere politico e di controllo su territori molto ampi (Parigi può essere considerata come paradigmatica al riguardo); o concentrando l’immigrazione dalla campagna seguita a quella che Marx definisce come accumulazione originaria, ossia la cacciata dalle terre d’origine alla quale fa seguito (non in maniera neutra/naturale ma attraverso differenti dispositivi di violento disciplinamento, come ha mostrato Foucault) l’inurbamento con la rivoluzione industriale (ad esempio la Manchester descritta nelle pagine di Engels); oppure funzionando come snodi di una rete globale di commercio (e laddove ciò si è unito anche ad un controllo politico-militare di tipo imperiale, si è dato vita a quella che per lungo tempo è stata la più grossa metropoli del mondo, Londra). New York pone invece una novità rispetto ai precedenti esempi di governo e convivenza di popolazioni disomogenee. Fino al suo determinarsi come Metropoli del XX secolo, gli unici modelli di “multiculturalismo” (tornerò tra poco sul tema) erano infatti di tipo imperiale, intendendo il termine come ordine sovranazionale con una specifica organizzazione politico-economico-militare. A seconda degli approcci si andava dalla concessione di una ampia libertà di lingua, religione, tradizioni, leggi (ciò che oggi definiremmo “cultura”), oppure si disponeva come rigida sottomissione. Invece con la fine della guerra civile americana (1865) e l’apertura della Frontiera del West nasce una tipologia nuova, indistricabilmente legata ad un tipo di migrazione del tutto moderna e peculiare. Se infatti la storia dell’umanità è sempre stata costituita da un incessante spostamento di “comunità” (per fattori vari: dalla ricerca di ambienti più adatti alla sopravvivenza a motivi legati a guerre, invasioni ecc…), con l’avvento del capitalismo si determinano migrazioni degli individui, come fenomeno di massa. Una apparente contraddizione nei termini che tuttavia inaugura una tipologia migratoria sino ad allora sconosciuta. E che negli Usa costruirà un’epopea di libertà e di sottomissione.
Prima di proseguire, è necessario aprire una parentesi su un elemento da poco accennato di sfuggita, quello della cultura (la cui critica potrebbe essere giustapposta anche al termine “comunità”). Non è questo il luogo nel quale elaborare una analisi del cosiddetto cultural turn, affermatosi nelle scienze sociale nel tardo Novecento. Limitiamoci dunque a segnalare alcuni problemi1. Innanzitutto nelle impostazioni analitiche (e politiche) consolidate la cultura è proposta come dato oggettivo e annodato a doppio filo ad una essenzializzazione del dato etnico. Il nazionalismo metodologico, che ne accetta la veste ideologica di cultura come delimitata in confini storico-politici che vengono invece così naturalizzati, viene solo raramente messo in discussione. Ossia: si pluralizza il termine solo quando lo si analizza su uno spettro geografico scandito da confini statuali. Se è invece chiaro come solo una operazione surrettizia ed ipostatizzante possa descrivere le culture come insiemi omogenei, è evidente come anche all’interno di questi confini nazionali esistano differenti culture (di classe o di genere, ad esempio). Dunque è possibile operare molte linee di faglia entro la cultura immaginata come insieme denso ed omogeneo. La cultura oggettivata viene a nascondere quelli che sono i suoi processi di produzione e trasmissione. Un’operazione che tende a neutralizzare la cultura, celando il fatto che essa condensa rapporti di potere sociale. D’ora in avanti teniamo presenti questi elementi quando si usa il termine “cultura”.
Il melting pot
Ben prima che il concetto di cultura divenisse lente analitica privilegiata, l’establishment americano guardava alle masse di persone che con una progressione rapidissima si stabilizzano a New York come portatrici di “culture” subalterne. Che possono essere controllate o guardate con curiosità antropologica, tollerate, ma entro una prospettiva di assimilazione, ossia di adeguamento alla sfera di regole, leggi, lingua ecc… dominanti. E’ in questo contesto che si costruisce l’idea di melting pot, che proprio a New York e su New York viene forgiata. Usualmente con questo lemma si immagina un mescolamento, un miscuglio di differenti provenienze. Ma proviamo ad approfondire la questione. Etimologicamente il termine melting indica l’incrociare e letteralmente il fondersi, ossia il “divenire liquido” attraverso un processo di cottura. Mentre il termine pot significa vaso, contenitore, recipiente, pentola. E su questo secondo lemma si è forse usualmente posta scarsa attenzione. Dunque melting pot indica sì un mescolarsi, ma all’interno di barriere precise e definite (quelle delle regole americane). L’idea è che questo miscuglio di differenti componenti, una volta scosso o meglio cotto nel recipiente che lo contiene, possa essere infine versato fuori di esso come fosse una nuova sostanza uniforme e monocroma, in grado di essere assaporata. Fuor di metafora: in grado di essere governata. Potremmo allora sostenere che l’elaborazione dell’idea di melting pot sia una risposta governamentale alla spinta tendenzialmente indisciplinabile che la pressione migratoria poneva al territorio americano. Una spinta non da bloccare, ma da incanalare attraverso il il meccanismo dell’integrazione, la quale produce la soggettività migrante come ancora non adatta a far parte di uno spazio presupposto come già definito (quello della nazione americana). Dunque il migrante è portatore di un costitutivo deficit che deve colmare. La vecchia logica del “not yet”, del non ancora pronti ad accedere all’ultimo stadio della civiltà, con la quale in passato (e tutt’ora) si sono giustificate guerre e colonizzazioni in nome del portare la fiaccola della civiltà (che a seconda delle epoche poteva essere il cristianesimo, il libero mercato, la tecnologia, la democrazia).
Questo processo di assimilazione/governo ha in qualche modo funzionato per alcuni decenni, anche perché la provenienza culturale degli immigrati non forniva una sorgente identitaria forte. O quantomeno non era presente un’ideologia della propria cultura che potesse fungere anche da strumento di interposizione2. Quand’è dunque che questa idea di melting pot inizia a non funzionare più? Sostanzialmente coi movimenti degli anni ’60. Questi infatti rivendicano un’uguaglianza che si fonda anche sul diritto a non essere assimilati. Da questo punto di vista la figura di Malcom X è paradigmatica di una lotta in cui i neri affermano di battersi non per diventare bianchi, ma per poter essere neri con pari dignità. Dunque una lotta contro il concetto di melting pot. Si apre allora una profonda ambivalenza, forse un’aporia, dove si forgia un’ideologia dell’appartenenza culturale come strumento di resistenza, i cui effetti vediamo tutt’ora in opera. Perché ambivalenza? In quanto questa politica, nei suoi sviluppi, affianca due momenti contraddittori. Da un lato le forme di politicizzazione dell’identità etnico-razziale o popolar-territoriale (ma non solo) consentono la riattivazione di memorie derubate e gettate nell’oblio dalle allegorie nazionali. Questo fornisce strumenti di elaborazione di senso che mostrano i rapporti di potere attraverso i quali sono venutesi strutturando forme di convivenza subalterna, e può condurre dunque all’elaborazione di concrete strategie di resistenza e disarticolazione dei dispositivi di governo. Esempio più recente al riguardo, mutatis mutandis, può essere quello della lotta zapatista. D’altro canto, tuttavia, questa stessa affermazione induce sovente a delineare un’appartenenza di gruppo che dà luogo a prassi reattive, fondate sul mitizzare ipotetiche comunità del passato alle quali fare ritorno. Dunque realizzando chiusure identitarie che spesso risultano assai funzionali ad una auto-subordinazione. Esse si inseriscono infatti appieno entro un piano di differenziazione dello spazio della cittadinanza, elemento assolutamente coerente con la dottrina politica liberale sin dalle sue origini3.
Ad ogni modo questa nuova disposizione ideologica inauguratasi negli anni ’60 informerà molti altri movimenti di rivendicazione, in particolare attorno alle questioni di genere. E qui si apre un nuovo orizzonte: mentre per il movimento nero l’appartenenza territoriale, seppur in forme spesso esclusivamente evocative, funzionava ancora come perno ideologico (il ritorno alla madre Africa ad esempio), l’essere considerati come cultura viene progressivamente sganciandosi da una identificazione col territorio. E’ qui che possiamo collocare l’affermarsi dell’idea di multiculturalismo, che soppianta quella di melting pot. Infatti la cultura può essere infine pensata come traccia mobile, e quindi ad esempio un italiano può essere italiano a New York, e non incanalato verso un processo che lo definisce progressivamente come italo-americano ed infine come americano tout court. Quindi non più miscela di differenze entro rigide regole comuni, quanto agevolazione della separazione dei vari elementi entro un quadro di regole che possono anche differenziarsi per mettere in forma geografie mobili della subalternità. Un segnale emblematico della fine dell’idea di melting pot è rinvenibile girando per la subway, laddove molti dei cartelli con indicazioni sono oggi espressi in una doppia lingua: inglese e spagnolo. Una cosa incompatibile con l’idea di melting pot e con l’America di alcuni decenni fa, in cui l’apprendere la lingua americana era un dato ineludibile. Tanto che oggi diviene molto difficile lo stesso pensarsi al di fuori del paradigma razziale, che fornisce una matrice necessaria se si vuole avere voce nello spazio pubblico, il quale è appunto mediato da affiliazione etnico-nazionali gerarchizzate e presentate come originarie. Questo dunque l’esito attuale del processo di sussunzione sistemica delle istanze agite in termini conflittuali decenni fa4. D’altra parte se gli anni delle Black Panther sono lontani, e l’eco della rivolta di Los Angeles del 1992 pare essersi disperso, non basta certo un presidente nero per celare le enormi diseguaglianze e ingiustizie che tutt’ora si fondano su base razziale… Riprendendo il filo del discorso, risulterà più comprensibile il perché, come conseguenza di quanto appena descritto, nel dibattito pubblico statunitense i conservatori tendano a presentare l’immigrazione come un fallimento, in quanto il mito nazionale dell’assimilazione non sarebbe mai avvenuto. I liberal invece, appoggiandosi all’ideologia multiculturalista, tendono ad affermare che l’americanizzazione come premessa dell’identità americana debba essere interamente ripensata.
Mosaici urbani e rivolte
Nuove metafore sono venute affermandosi per descrivere l’attuale situazione “post-melting pot”. Da un lato è stata proposta quella di “insalatiera”, che si pone in continuità dal punto di vista della metafora culinaria con quella del melting pot. Mentre in questo si immaginava di cuocere assieme le differenze per giungere ad un nuovo composto elaborato, l’idea di insalatiera sottende invece che i diversi ingredienti/culture vengano mischiati, ma mantenendo le loro caratteristiche peculiari. Altra etichetta dal medesimo significato, più raffinata forse, è quella forgiata in Canada di “mosaico”. Un’idea che si adatta in maniera sorprendente alla New York di oggi. La sua composizione urbana in superficie è infatti una distesa in cui si accostano in successione tantissimi pezzi di differenti colori/culture. Attraversando in automobile Brooklyn a partire dal mare (Coney Island), ad esempio, si passa di continuo per una sequenza di tanti mondi: dalla zona russofona con i cartelli dei negozi in cirillico alla zona ebraica, dove per strada si vedono solo ortodossi con i tradizionali abiti neri ed i riccioli di capelli. Risalendo si incontra un quartiere vietnamita e poi una ampia zona ecuadoregna. Si passa per un incrocio di vie abitate da jamaicani, in cui la strada principale è stata ribattezzata “Bob Marley Street” ed in cui si vedono solo neri per strada. Si passa per il quartiere hip dove passeggiano solo giovani bianchi e si svolta per un dedalo di vie con negozi che vendono il Corano e donne velate che entrano ed escono dalle case… E l’elenco potrebbe continuare a lungo e per altri Borough di New York. Questo spaccato urbanistico-sociale ci mostra come agisca concretamente questa nuova logica di governo (o se preferiamo governamentale), che ha scoperto come in fondo sia anche più semplice controllare una settorializzazione della popolazione, portando al parossismo quell’accavallarsi di linea di classe e del colore così caratteristico degli Stati Uniti.
Abbiamo sinora percorso in maniera estremamente veloce e sintetica alcuni dei prevalenti approcci al tema delle migrazioni, cercando di mostrarli calati sui contesti urbani e sulle forme societarie. Il melting pot è stato presentato come anomalia storica e come sorta di via intermedia tra i due modelli precedenti: quello dell’integrazione/assimilazionismo (storicamente legato alla Francia, i cui prodotti urbanistici in Algeria sono straordinariamente descritti nelle prime pagine de “I dannati della terra” di Fanon nei termini di una netta divisione tra città dei coloni e città dei colonizzati); quello del multiculturalismo, sorto sostanzialmente con l’Impero britannico. Possiamo affermare come tutti e tre questi modelli siano stati messi in crisi in maniera quasi simultanea dai movimenti anticoloniali (comprendendo in questa categoria anche quelli contro la segregazione interna agli Usa). Tuttavia all’oggi l’impronta della storia non può che mostrare ancora il suo peso. Non è dunque casuale che proprio Francia e Inghilterra siano stati il teatro in questi primi Duemila di due dei più consistenti fenomeni di rivolta che hanno visto un protagonismo della soggettività immigrata. L’insurrezione delle banlieu del 2005, probabilmente non ancora sufficientemente approfondita come momento di snodo per la storia dell’Europa, portava impresso il lascito storico di cui stiamo parlando. La banlieu manifesta infatti in termini urbani una relazione di colonialismo interno tramite la evidente separazione lungo la linea centro-periferia. L’integrazione subalterna nel modello francese ha spinto masse migranti chilometri lontano dai centri cittadini, e in qualche modo le figure della subalternità protagoniste di quegli avvenimenti avevano per lo più mantenuto fra loro una forma di reciproca indifferenza, se non di esplicita ostilità. Sei anni dopo sarà il turno dell’Inghilterra essere attraversata, seppur con minor durata, dall’esplosione di una rivolta urbana. Qui le zone della subalternità non sono disposte in termini definiti centro-periferia, ma in modo più variegato. E la composizione dei rivoltosi dell’agosto 2011 scompone radicalmente le linee di gerarchizzazione culturale (etnico-religiosa), spesso introiettata fin entro le cosiddette sottoculture. Dunque è venuto configurandosi un melting pot del riot che ha intrecciato generi, generazioni e appartenenze culturali.
Questa affermazione potrebbe apparire contraddittoria per quanto detto sinora, ma non lo è. Abbiamo infatti visto come il modello francese e quello inglese siano figli di impostazioni colonialistico-imperiali. E come invece il melting pot, come forma altra e nuovo rispetto a questi due, contenesse inevitabilmente in sé quel pezzo di storia degli Stati Uniti che con l’apertura della frontiera a Ovest ha segnato un passaggio estremamente contraddittorio ma fatto anche di grandi storie di libertà, di fuga dalle catene del rapporto di capitale. Quindi il melting pot si presentava come tentativo di governo, ma al contempo era anche un’imposizione segnata dai movimenti di classe su scala globale. Laddove da un lato si tentava di cucinare l’amalgama di genti che arrivavano sul continente in un’ottica governamentale, dall’altro il mettere a fuoco una miscela sconosciuta può dare esito ad inaspettati risultati esplosivi… In qualche modo quindi, mentre integrazione e multiculturalismo sono progetti espressione di volontà di dominio, il melting pot contiene in sé anche un tratto di classe. Laddove i primi due giocano con la formazione di identità culturali predefinite come strumenti di governo, il melting pot, pur dandole come base di partenza, tende a scardinarle. E da questo punto di vista risulta indicativo come la più grande mobilitazione migrante degli ultimi anni negli USA, quella del “Si se puede” del 2006, agisse consapevolmente una spinta all’inclusione nei meccanismi della cittadinanza, sventolando bandiere statunitensi negli oceanici cortei. Un “anche noi siamo americani” che risuonava anche nel non volersi sentire “cittadini di serie B” delle banlieu. Vediamo dunque come in questi ultimi anni il movimento di rivendicazione politica sia sostanzialmente invertito rispetto agli anni ’60: mentre allora ci si muoveva verso forme secessive rispetto ad una cittadinanza asfittica e gerarchizzata che voleva includere/assimilare, oggi pare manifestarsi una pulsione che punta ad appropriarsi della cittadinanza5, rispetto alla quale si è esclusi (o inclusi in maniera differenziale/gerarchizzata). Un tema appena sfiorato ma di grande importanza, che merita ben altri approfondimenti rispetto a ciò che si può fare qui.
NC
1Una critica poco conosciuta della Cultura è stata sviluppata da Alquati, che ne mostrava le ambivalenti sfaccettature, il suo presentarsi come merce, evidenziandone il funzionare come corpo ostile all’interno degli individui ecc…
2Ci tornerò tra poco, ma è solo con i processi di globalizzazione che viene contemporaneamente innestandosi, paradossi della storia, il cosiddetto regionalismo, ossia un’ideologia della cultura come legata ad un territorio. Di fatto rompendo con la tradizione illuminista che costruendo valori universali (pur con i limiti che questa impostazione comporta) aveva rotto con “la terra ed il sangue” quali elementi di costituzione politica dell’umanità. Negli Stati Uniti chiaramente il territorio non poteva funzionare come ideologia di partenza, in quanto era “aperto” all’arrivo di nuove persone. Il destino degli indiani, guardati come storia di resistenza all’assimilazione ed antitesi al disegno di colonizzazione, è al riguardo un sufficiente monito.
3Infatti la logica sopra accennata del “not yet” ha storicamente agito anche all’interno dei singoli spazi nazionali, ad esempio nei confronti della donna, a lungo considerata come “non ancora” in grado di poter accedere ai diritti.
4Régis Debray, in una famosa intervista, criticò le basi del cosiddetto terzomondismo affermando come gli oggetti si stiano oggi globalizzando, mentre i soggetti sono in via di tribalizzazione. E tuttavia oggi anche molti processi sociali diventano “oggetti” in via di globalizzazione, spoliticizzando le istanze entro cui erano andati formandosi. E la storia della tendenziale sussunzione delle istanze di genere, ambientaliste ecc.. può essere un esempio.
5Dove per cittadinanza non bisogna immaginare esclusivamente uno spazio nazionale. Laddove infatti spesso la simbologia o il terreno rivendicativo si riferisce a questa scala geografica, in realtà ciò è a mio avviso dovuto soprattutto ad una molto concreta scarsa disponibilità di simbologie o linguaggi alternativi entro i quali poter esprimere le istanze politiche. Esistono infatti esperienze che indicano come laddove si formino possibilità alternative al linguaggio nazionale, queste vengono messe in campo: a partire dallo strutturarsi di identità transnazionali (di cui un esempio interessante si rintraccia negli studi etnografici sviluppati sulle gang del nord ovest italiano, laddove l’idea dell’appartenenza ad una latinità transnazionale coinvolge indifferentemente migranti ecuadoregni così come filippini), o anche nell’usare simbologie nazionali in contesti che tuttavia ne trasfigurano il senso.
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.