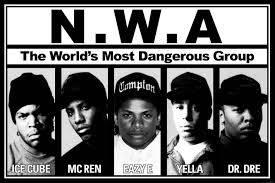Il rap, il razzismo, Sanremo e noi

Qualche mese fa il rapper nigeriano-italiano Tommy Kuti ha rilasciato, senza troppa eco mediatica, un’intervista per Noisey in cui veniva affrontato il tema del razzismo nel rap italiano. Il centro del discorso ruotava attorno al tema dell’appropriazione culturale subita dalla cultura hip hop in Italia, senza una sufficiente elaborazione delle sue matrici razziali e sociali. Un’appropriazione che non sarebbe stata fatta in maniera rispettosa, secondo Tommy Kuti, e che sta lasciando emergere una certa superficialità nel dibattito interno alla “scena”, soprattutto tra quegli esponenti più giovani che « si auto-proclamano ne*ri, ma che se poi alle conferenze stampa vengono sollecitati a parlare della situazione politica italiana attuale, preferiscono non commentare, perché fanno i rapper, mica i politici ».
L’intervista non ha suscitato che qualche tiepida reazione, per lo più tramite social (tra gli esponenti “di spicco” uno dei pochi a esporsi è stato Guè Pequeno), facendo cadere apparentemente nel vuoto le parole del rapper afroitaliano (come lo stesso Tommy Kuti si è definito in un pezzo del 2017). Nel frattempo il mercato discografico ha proseguito senza indugi nella piena fagocitazione della musica (t)rap, senza lasciare molto spazio a una – anche minima – possibilità di alfabetizzazione dei codici culturali dell’hip hop per il grande pubblico, preferendo cavalcare l’onda lunga del successo del genere.
Il risultato, insospettabile fino a pochi anni fa, è quello di una vera e propria egemonia della urban music nelle radio e nelle classifiche, con un apprezzabile svecchiamento, non solo anagrafico ma anche lirico e melodico, e un (forse) definitivo accantonamento del tripode sole-cuore-amore su cui si è sorretta, per decenni, l’intera impalcatura dell’intrattenimento musicale made in Italy. Ciononostante, delle riflessioni di Tommy Kuti sembrava non essersene accorto quasi nessuno, se non a sprazzi (fa eccezione il “razzisti che ascoltano hip hop? Qualcosa non torna” di Salmo) o comunque in ambienti ben lontani dalle vette delle chart di Spotify.
Poi, qualche giorno fa, il rapper veronese (ma di madre iraniana) Jamil, dopo una breve parentesi di botta e risposta via Instagram, ha attaccato frontalmente il duo romano Gallagher e Traffic con un dissing dal titolo inequivocabile: “No racism”. Tenendo fede alla sua nomea di Most hated (dal titolo del suo ultimo disco), Jamil ha contestato duramente i due giovani “trapper” ridicolizzandone le pose più gangsta e mettendo in scena un videoclip in cui l’appartenenza razziale viene rivendicata apertamente da tutti i membri della sua crew (Baida Army) e, soprattutto, dove si allude all’utilizzo della “parola con la N”.
Jamil è un paraculo, d’accordo. Il ricordo della sua faida con Noyz Narcos divide ancora i fan di mezza Italia, e alcune voci sul suo conto non sono tra le più onorevoli, ma poco importa. Al momento Jamil è il primo rapper italiano bianco (anche se nemmeno lui si definisce tale in virtù delle sue origini “persiane”) a contestare l’utilizzo della N-word nei testi delle canzoni. Implicitamente accoglie l’invito di Tommy Kuti, quando durante l’intervista per Noisey lui, nero, dichiarava che l’Italia è un paese dove “è la normalità spiegare alle persone perché mi dà fastidio se tu dici ne*ro”.
È sempre più necessario, infatti, contestualizzare l’appropriazione della black culture in un paese che non sa fare i conti con un razzismo strutturale che si ripercuote, senza apparenti mediazioni, anche in ambito culturale e musicale. Esiste, in questo senso, un’assunzione indebita di termini, atteggiamenti e – per usare una terminologia hip hop – “attitudini” dell’identità degli african-american e degli africano-italiani senza riuscire a contestualizzarle in termini di razzializzazione.
Esiste, insomma, una sorta di colonialismo culturale del quale, fino a qualche anno fa, non si poteva forse nemmeno accusare la “scena”, che aveva sviluppato e rivendicato dei codici di riconoscibilità piuttosto distanti dalla tradizione hip hop americana o francese (dove la consapevolezza razziale ha sempre giocato un ruolo predominante). Oggi che questo confine sembra essersi attenuato e che, al contrario, tanti stilemi e ritualità del rap game hanno fatto breccia nell’immaginario delle nuove generazioni, auto-appropriarsi della N-word e rivendicarne l’utilizzo senza un riflessione (auto)critica non può essere accettato.
Anche la Dark Polo Gang, agli inizi della sua parabola ascendente, si scontrò con questo problema quando Tony diede del “ne*ro di merda” a Bello Figo e il gruppo fu costretto a giocarsi la carta del black-washing, obbligando l’unico membro non-bianco della gang (Pyrex) a dichiarare in diretta social che no, i suoi amici non erano razzisti.
Ben venga quindi l’attacco di Jamil a Gallagher e Traffik (che sulla ripetizione della N-word nei testi avevano costruito, di fatto, la riconoscibilità del loro stile pur essendo bianchi), anche se fatto per motivi strumentali e autocelebrativi e non solamente “antirazzisti” (anche questo, però, fa parte del gioco).
Meno di una settimana dopo il rilascio di “No racism”, un cantante italiano con origini egiziane (da parte di padre) ha vinto la più importante kermesse musicale d’Italia, scatenando il fuoco incrociato bipartisan dei media e della politica.
Mahmood ha vinto il festival di Sanremo con una canzone composta dal più importante produttore della scena trap (Charlie Charles), il cui testo racconta di periferia e di legami familiari deteriorati, ma anche, e soprattutto, di Soldi. Ha vinto con (e grazie alle) sonorità urban di moda negli ultimi anni, grazie allo sdoganamento dell’hip hop nel mainstream e riproducendo una tipologia di canzone che solo in Italia può ancora sembrare una “novità” frutto del “miscuglio di culture”.
La verità è che Mahmood ha portato un pezzo che può essere definito “coraggioso” per gli standard di Sanremo, ma di certo non lo è per lo stato dell’arte della musica italiana. Il fatto che la sua vittoria abbia immediatamente riportato in auge una narrazione tossica che contrappone la legittimità del (tele)voto popolare alla scelta delle élite (le giurie del festival) si rivela controproducente per una serie di motivi.
Ad un primo livello è chiara la strumentalità con cui la politica ha rivendicato la mancata consacrazione della volontà popolare, con lo staff di Matteo Salvini che, a poco minuti dalla proclamazione del vincitore, indicava in Ultimo – il più votato dagli spettatori – la scelta del “capitano”. Da questa presa di posizione ne deriva immediatamente un’altra, più funzionale ad alimentare la retorica razzista-sovranista, secondo cui uno con un nome del genere (Mahmood) non può certo rappresentare “la migliore canzone italiana”. Da più parti è stato fatto notare come un discorso simile non sia stato fatto in occasione della vittoria di Ermal Meta lo scorso anno; il cantante, albanese emigrato in Italia, si presentava infatti con la più rassicurante presenza di Fabrizio Moro al suo fianco, pur non avendo mai nascosto o ridimensionato le proprie origini. Il problema, semmai, è che, per quanto la rappresentazione di un cantante sia mediata e costruita socialmente in funzione della sua presenza scenica (e quindi della sua “commerciabilità”) è innegabile che Mahmood con un orecchino dorato che parla di SOLDI in arabo crei una frattura nell’immaginario benpensante decisamente più profonda di un bianco (seppur albanese) che canta della paura provocata dal terrorismo (Non mi avete fatto niente).
In secondo piano c’è poi la vulgata antirazzista e benpensante rivendicata a reti unificate dal “partito di Repubblica” e dai media progressisti, che hanno ben pensato di focalizzare la propria attenzione sull’aspetto meno interessante dell’artista-Mahmood (il suo cognome). Lui, immediatamente dopo la vittoria, ha rivendicato – in maniera forse un po’ goffa – la propria “italianità” dichiarando di non volere essere, giustamente, coinvolto in diatribe strumentali sul tema del razzismo. Ma perché è giusto che Mahmood non pensi immediatamente al proprio fenotipo e perché, semmai, è incredibile che come prima cosa abbia dovuto estrarre, metaforicamente, la propria carta d’identità invece di parlare, per esempio, della sua musica e delle sue capacità canore?
Perché, come ha detto in un lungo post su facebook la cantante Djarah Kan, essere definiti solo in base alla rivendicazione di una condizione subalterna, o in base alla gradualità di “meticciato” che si esprime con la propria musica non è nient’altro che un altro modo di riprodurre la segregazione razziale. Si tratta di un antirazzismo sociale non supportato da una riflessione che rivendichi la crescita di una soggettività politica dei “razzalizati” (e quindi non bianchi) senza definire, per forza, questi ultimi sulla base della loro capacità di descriversi come soggetti deboli, sottomessi o segregati. Si tratta di una narrazione nociva e controproducente dell’antirazzismo, che crea a sua volta una disparità razziale costruita in primo luogo grazie al dominio culturale delle élite bianche progressiste, le quali riversano sul/sulla ner* di turno le proprie convinzioni stereotipate senza lasciare loro spazio all’autonomia e all’autodeterminazione. Riprendendo le parole di Djarah Kan: «esistiamo e non parleremo solo di razzismo e di “integrazione”. Parleremo di soldi, di amore, di rabbia, di cieli e schiaffi in faccia dati per non andare in galera».
Infine, la scelta di Mahmood ha provocato uno strascico piuttosto consistente nel dibattito pubblico per quanto riguarda la già citata contrapposizione tra scelta del popolo/decisione delle élite. Da un lato, questa alzata di scudi contro i “benpensanti” di sinistra che governano la Rai può avere un fondo di verosimiglianza: il partito di Repubblica allunga i suoi tentacoli anche in televisione, nulla vieta di pensare a una decisione “orientata” per fare vincere un volto meno noto che, guarda caso, risponda anche alle esigenze di un “antirazzismo di facciata”, come quello descritto sopra. Niente a che vedere, però, con un tentativo di “rivincita” dell’establishment nei confronti delle passate elezioni, come sostenuto da alcune agili penne nell’internet.
Si può senz’altro rivendicare una maggiore trasparenza nelle votazioni di quello che, volente o nolente, rappresenta uno dei più importanti fenomeni culturali e di costume del paese, e si può anche criticare una certa malizia nell’aver scelto il candidato più alternativo per la vittoria del Festival, ma a costo di fare i conti con altre questioni aperte. La prima delle quali è legata al fatto che il vero “campione del popolo” è stato per diversi giorni (e lo sarà per le settimane a venire, a vedere i numeri) uno solo: Achille Lauro. Irrappresentabile, incondivisibile e, in buona sintesi, incompatibile con lo spirito del tempio della musica leggera, è stato lui a subire l’ostracismo più netto perché accusato prima di plagio e poi di incitamento all’uso di stupefacenti.
Archiviata – o forse meglio censurata – la parentesi Achille Lauro, che comunque prevedeva un indice di rottura con lo status quo non esagerato (parliamo comunque di Sanremo), la scelta del pubblico si è incanalata verso il più mite Ultimo, già vincitore dei giovani 2018 e quest’anno in gara con una scialba ballata d’amore. Piaccia o meno, è lui il più apprezzato musicalmente, e il ribaltone di Mahmood contro una vittoria già data per scontata da tutti è senz’altro un buon coup de théâtre grazie al quale il Festival sta riuscendo a far parlare di sé ben oltre le fisiologiche necessità.
Ma se la polemica sul televoto lascia il tempo che trova per la forma grottesca e incomprensibile che ha assunto, purtroppo non la si può più slegare dalla polemica sulla nazionalità di Mahmood. Di tutti i dispositivi messi in atto dai giornali e dalla politica per screditare il vincitore del Festival quello della razzializzazione si è rivelato senz’altro il più efficace, e servono al più presto degli strumenti per disinnescarlo. Lo stesso Ultimo che si riferisce a Mahmood chiamandolo “ragazzo” per sminuirne la vittoria riporta alla mente modalità sottili e codificate di legittimare il discorso razziale, che certo non possono essere rimosse facendo la morale a un ventiduenne deluso per la perdita di un concorso.
La scena hip hop, seppur in minima parte, si sta esprimendo su un tema sempre più presente nelle nostre vite, questo è un dato non trascurabile. E, soprattutto dopo che un rapper nero ha esternato la necessità di situare un punto di vista sulla questione razziale, non si può più fare finta di niente. L’esempio è virtuoso perché sperimenta una modalità di confronto dialettico per certi versi inedito nella cultura italiana, che passa attraverso lo scontro diretto (il dissing) e non tramite gli esercizi di retorica demagoga da social network a cui siamo assuefatti. Può essere un esperimento fruttuoso o può rivelarsi uno strumento fine a se stesso nelle mani di una sottocultura espropriata della propria “politicità”. Di certo la battaglia è appena iniziata.
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.