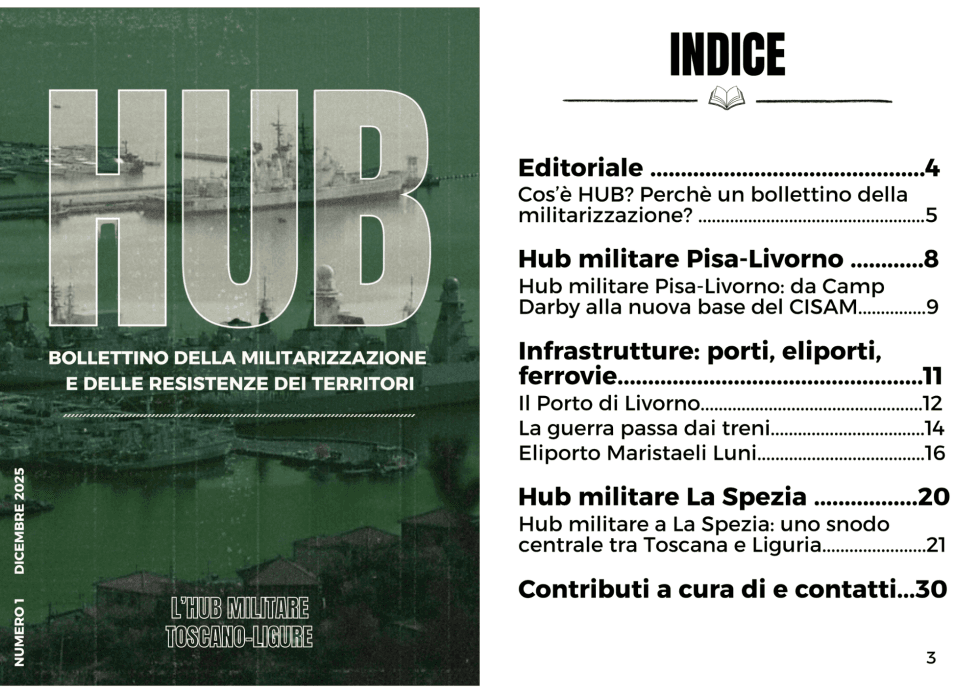Sarete i nostri occhi: dentro e contro il rapporto di accoglienza

Conversazione con IAM Firenze sulla lotta dei rifugiati dell’ex Aiazzone, Giugno 2017. Quest’intervista è stato il materiale introduttivo a un workshop su migrazioni e lotte sul sistema dell’accoglienza al seminario di Chianocco il 15 luglio 2017.
A febbraio un rogo divampa nel capannone occupato dai rifugiati somali. Ali Muse, uno di loro, rientra nello stabile tra le fiamme per recuperare i documenti utili al ricongiungimento familiare e muore. Scatta una dura resistenza contro l’immissione degli sfollati nel sistema dell’accoglienza.Qual è stato il ruolo dei compagni? In che misura questa lotta è stata importante per sottrarsi a un ruolo di mediazione attribuito di prassi alle dimensioni militanti e come questa sottrazione ha permesso di costruire una lotta all’attacco per il miglioramento delle condizioni di vita?
Partiamo dal principio, qual è la storia dell’occupazione dell’ex Aiazzone?
L.: L’occupazione dell’ex Aiazzone veniva da una serie di occupazioni che hanno praticamente coinvolto più o meno lo stesso gruppo che poi viveva dentro l’ex-Aiazzone negli ultimi quindici anni. Quindi un gruppo di rifugiati politici a cui è stato riconosciuto il diritto di asilo che dall’inizio degli anni 2000 hanno attraversato i percorsi della Lotta per la casa di Firenze, in particolare l’ultima esperienza precedente, quella di via Slataper (occupazione in cui ha vissuto buona parte del gruppo di ex Aiazzone dal 2011 al 2014) che si era conclusa con l’inserimento di tutti gli occupanti in dei progetti temporanei di accoglienza per cui alla scadenza erano per l’ennesima volta erano stati re-inseriti e re-espulsi, secondo una differenziazione interna in termini di prima accoglienza, di progetti specifici e di emergenza abitativa. Sono quindi poi arrivati a quest’occupazione dell’ex-Aiazzone. Diciamo che si parla di un gruppo più o meno definito aggregato intorno alla lotta per casa che ha negli anni sempre vissuto insieme in diverse occupazioni. Diciamo che l’ex-aiazzone in questo contesto è stato il picco più alto delle condizioni comunque di marginalizzazione anche all’interno della stessa pratica di occupazione. L’Aiazzone era un mobilificio quindi le condizioni di vita non erano semplici, non erano adatte.
E.: Nonostante dei passaggi in cui le istanze di riconoscimento dei rifugiati sono state poste alle contro-parti, il problema dei rifugiati si è trasformato sia negli sgomberi sia nelle occupazioni precedenti in delle situazioni ambigue tra quella che è una lotta contro, per la casa, per condizioni di vita migliori e quella di una sistemazione che in qualche modo ci deve essere con un costante abbassamento della pretesa di vita fino ad arrivare al livello dell’Aiazzone. In questo matura quindi una certa estraneità da posizioni di lotta che c’erano state anche solo sei anni fa, in una battaglia col Comune che aveva portato tra l’altro all’occupazione precedente ma che era poi andata scemando e nel tempo restava solo il “ci deve essere una sistemazione per queste persone”
L: Diciamo che abbiamo come gruppo di compagni il primo vero contatto con questa situazione esattamente un anno prima l’incendio, nel gennaio del 2016. Quando dico gruppo di compagni intendo IAM. Avemmo questo primo contatto quando ci fu questo tentativo di distacco della luce, ce n’erano stati altri ma questo fu più convinto ci fu il tentativo di sradicare con una ruspa i cavi che portavano la fornitura elettrica nell’edificio. Si produsse una forte resistenza, con prima una sassaiola da parte degli occupanti e poi una dinamica di blocco dei mezzi dell’ENEL e della polizia che erano venuti per il distacco. È importante questo episodio non solo per capire che caratteristiche avevano quelle soggettività che poi sono state protagoniste di quel piccolo ciclo di lotta che è iniziato dopo l’incendio e la morte di Ali Muse, ma anche perché è da quell’episodio che, come compagni, abbiamo iniziato a farci dei ragionamenti. La prima cosa, come discorso auto-critico che poi è stato fondamentale per affrontare la fase del post-Aiazzone, è stata quella del rendersi conto, dentro quel momento di conflitto intenso, che nel passato avevamo anche noi operato un po’ una confusione, anche noi, all’interno dei percorsi di Lotta per la casa, verso quella parte che riguardava i rifugiati politici. Da militanti di lotta per la casa.
Rimaniamo sorpresi da quello che si esprime in quella giornata, e questo perchè avevamo in qualche modo confuso ciò che negli anni i “percorsi dei rifugiati” avevano espresso, con limiti peculiari di quella composizione lì. Quel giorno emerge invece chiara una cosa, prima di tutto una soggettività giovane, disposta a mettersi in gioco per rifiutare una posizione di pesante marginalizzazione sia sull’aspetto abitativo che lavorativo sia su quello proprio delle relazioni sociali oltre che il forte disciplinamento che passa attraverso il sistema dell’accoglienza, una forte carica antagonista che si nutre anche della consapevolezza di un rapporto coloniale che continua.
Fino a quel momento il movimento aveva sempre cercato di rappresentare in qualche modo gli interessi di quella composizione lì, mettendo sempre al centro diciamo un discorso di critica all’insufficienza del sistema di accoglienza. Ma senza mai mettere al centro, senza mai dare spazio di espressione di approfondimento a una nemicità, a un’ostilità, anche di una politicità abbastanza esplicita per certi versi che quelle soggettività hanno, molto legata alla storia coloniale con lo stato italiano e il movimento quindi aveva sempre in qualche modo, sebbene con punti partenza diversi, riprodotto un meccanismo di assistenza e di riproduzione, anche a livello discorsivo, del rifugiato politico come “il soggetto debole”, più da tutelare, più da tutelare addirittura dei senza casa, quello che è addirittura più debole del senza casa.
E: Dentro una distanza reciproca per il fatto che anche da parte della composizione della Lotta per casa la composizione dei rifugiati è sempre stata percepita come estremamente marginale e viceversa per i rifugiati la dimensione di “lotta per la casa” come limitante: la marginalità delle condizioni di vita, non solo abitativa ma anche i problemi economici, lo sfruttamento sul lavoro, la mancanza dei documenti fanno parte dello stesso tipo di problema e il fatto di avere un tetto viene anche visto come estremamente parziale. Meglio di niente ma non all’altezza della rabbia e dell’insofferenza verso quindici anni di vita in cui, al di là della casa occupata, su tutto il resto non è mai cambiato niente e questa cosa dal punto di vista del Movimento di lotta per la casa noi la leggevamo soltanto in termini di non partecipazione alla vertenza sulla casa ma che in realtà è dovuta una politicità maggiore, non minore, rispetto alle composizioni degli altri occupanti.
L: Non solo. Ci rendiamo conto che dentro questi percorsi, negli anni, si era affermata una certa identificazione degli attivisti in cui questi non venivano identificati come qualcuno che poteva essere una risposta ad un bisogno di lotta, anche più complessivo. Questo perchè aveva prevalso un approccio che più che altro ricercava un continuare a qualificarsi come all’altezza di un “essere soluzione”, piuttosto che come all’altezza di una contrapposizione inevitabile per conquistare migliori condizioni di vita e rompere una realmente la marginalizzazione.
Il giorno del distacco questa cosa emerge e arriva forte da subito, perché arriviamo lì e, al di là della radicalità di cosa è successo, che per Firenze resta comunque tuttora una dinamica di risposta eccezionale, straordinaria diciamo, si capisce subito che al livello soggettivo i ragazzi che sono li non stanno combattendo una battaglia per la fornitura elettrica, nel senso che c’era poco da difendere di quella casa li, spesso in quella mattinata la cosa che veniva più urlata era legata ai permessi di soggiorno e ai titoli di viaggio per lasciare l’Italia, e anche la recriminazione coloniale usciva fuori nei momenti di agitazione. Noi quindi in qualche modo l’abbiamo un po’ riflettuta cosi: non è una questione di intensità del conflitto, che comunque è stato dignitoso – e straordinario per questa città – ma la dimensione soggettiva era una dimensione di rivolta. Non era semplicemente un’azione di blocco finalizzata ad avere un risultato, era una sfida a delle istituzioni che complessivamente venivano riconosciute come nemiche e che avevano oltrepassato un livello di tollerabilità. Per cui in quel caso li, si tradusse, (la tradussero loro) nella pretesa, nella rigidità, di non lasciare andare via gli operai dell’ENEL e la polizia finché non avessero “rimesso a posto” ciò che avevano fatto. Per cui quasi una sfida di potere, riaffermare un proprio potere decisionale e proprio sfidare queste istituzioni qui. Sebbene nessuno fosse legato all’idea di difendere l’ex-Aiazzone, d’altronde era difficile immaginare che qualcuno potesse volerlo perché erano delle condizioni inaccettabili. Quindi è stato importante per questo ed è stato importante anche da un altro punto di vista vedere come la controparte cercava disperatamente un’inziativa dei compagni, dei militanti, per di fatto rimettere in ordine la situazione.
Arriviamo quindi al momento del rogo…
L: Sì ci arriviamo quindi con una discussione già avviata da parte del collettivo di IAM, che era appena iniziato a esistere. Un confronto importante sul quale costruimmo un ragionamento, un’analisi molto auto-critica anche rispetto a quale era stata la lente con cui avevamo visto quella composizione lì fino a quel momento e costruimmo anche una serie di immaginazioni pratiche, diciamo, non di progettualità ma di immaginarsi come in una situazione del genere avremmo potuto lavorare in senso antagonista su quella composizione lì, tenendo al centro il punto del costruire una proposta che poteva essere all’altezza di una pretesa che fino a quel momento era stata negata. Molto avevamo ragionato anche sul modo problematico, che poi è quello che ci ha relegato sempre in una certa timidezza del provare delle ipotesi prima del rogo dell’ex-Aiazzone, di come superare un fraintendimento di ruoli che ereditavamo. Come facevamo a essere neanche gli organizzatori ma dei militanti politici a disposizione di un’organizzazione antagonista di alcune istanze e non altro? Non degli assistenti, non dei mediatori, non un tramite tra i barbari e la società civile, qualcuno che faccia da ponte tra l’istituzione e l’escluso. E questo era un nodo irrisolto. E forse non l’avremmo mai risolto a freddo, non avremmo avuto la capacità se non nella pratica della situazione che si è determinata a seguito del rogo.
E: Quindi Gennaio 2017, succede che una sera il palazzo dell’ex-Aiazzone ha preso fuoco, per un cortocircuito probabilmente, essendo un magazzino costruito tutto in legno è divampato tutto. Siamo arrivati li che erano usciti tutti tranne una persona che dopo essere uscita è rientrata a prendere i documenti del ricongiungimento familiare, Ali Muse. Una persona che non è più riuscita, che è stata tirata fuori solo dopo molto tempo ed è morto in ospedale poco dopo. La situazione che ci siamo trovati davanti era più di cento persone a cui aveva preso fuoco la casa con un loro compagno morto in questo incendio. Fin da subito, alla luce di tutto quello che dicevamo finora, quindi del ragionamento che ci eravamo fatti su questa cosa, l’istanza che abbiamo condiviso con loro che è che questo fatto fosse la goccia che non si poteva sopportare, quella situazione non doveva riprodursi di nuovo. Lui è morto, non si può morire così, non si può vivere così, serve altro.
L: Nel 2013 c’era stato già un altro morto in questa micro-comunità di somali, durante l’occupazione precedente, sulla fine dell’occupazione di un somalo che non aveva avuto risposta per titolo di viaggio dalla questura e si suicidò. Ci fu anche in quel caso una tensione interna grossa, noi partecipammo e c’era una tensione interna che però si ricompose nelle forme della manifestazione.
E: Fin da subito c’è la tensione del pretendere dalle istituzioni una sussistenza immediata ma anche nel quadro più generale della pretesa di non vivere più nelle stesse condizioni e del “non si può morire per dei documenti!”. Quindi un’esplosione di rabbia rispetto a tutta la situazione che poi si è determinata dopo questa tragedia. E fin da subito, dalla sera stessa, di avere delle soluzioni immediate dalle istituzioni ci ha portato a mobilitare prima il comune di Sesto e poi fin da subito di portare a chi governa la città la pretesa di un miglioramento complessivo delle condizioni di vita.
L: non so se può essere utile ma provo a raccontarlo nei passaggi più piccoli di quella stessa sera. È stata una fase emotivamente complicata, per loro, per noi, per tanti compagni, tutti eravamo presenti lì. E da subito si iniziò a cogliere nei brusii quello che veniva detto era: “ora lo Stato ci deve dare una soluzione, deve intervenire”. E noi questa cosa ci abbiamo fatto attenzione perché eravamo un po’ più pronti, perché avevamo ragionato su invece quanto poco si era provato a dare una forma di organizzazione e di iniziativa a queste tensioni. E lì c’era un bivio di fatto. Sarebbe potuto finire [tutto] con l’ emergenza scaricata sul movimento, o con la co-gestione al ribasso dell’emergenza. Era la soluzione ricercata dalle controparti – in quel momento la protezione civile, i pompieri, la digos e il sindaco di Sesto. Per cui: “ora cosa fate? Ci pensate voi? Cosa facciamo?”. Emerge però per prima cosa la pretesa, e poi l’insubordinazione verso un certo tipo di comando sulla vita, che in quel momento li si concretizza nel fatto che arrivano più carabinieri e cercano subito di mettere ordine nella situazione, per cui iniziano a dire al gruppo di spostarsi più lontano dal palazzo e di aspettare un pullman su cui poi salire in maniera ordinata. Per cui subito questa roba fa scattare una leva che è quella: noi non andiamo da nessuna parte, tu non mi puoi trattare come una bestia! E poi l’ostilità che che da subito emerge quella sera lì alla sola parola cooperative: noi le cooperative no, non ritorniamo con le cooperative! Lo Stato deve trovare le soluzioni.
Bisogna capire che tutte le persone sono qui da almeno cinque anni, tranne una minoranza sporadica di passaggio, c’è anche chi è qui da 10 o 15 anni e che ha sempre fatto un ciclo tra occupazioni e accoglienza, anche non per rifugiati – spesso nell’emergenza abitativa gestita da cooperative. Anche il ragazzo che è morto, Ali Muse, due o tre giorni prima era stato espulso per l’ennesima volta dall’albergo popolare che è una struttura per uomini singoli gestita da cooperative.
E: E anche un elemento che fin da subito è potente è quello della non divisione. Dieci alla volta, spostarsi solo alcuni era inaccettabile nella misura in cui non ci fosse una soluzione per tutti. È stata una rigidità molto chiara fin da questo rifiuto di spostarsi da davanti al palazzo bruciato che poi è stata portata avanti anche nei giorni successivi.
L: Poi questo pullman non è mai arrivato, perché tra parentesi non c’è mai stata una gestione istituzionale di questa situazione. Il pullman non arriva però la rigidità dello stare tutti insieme e del pretendere che lo Stato risolva la situazione rimane. Questo fatto si iscrive in una storia lunga, è il secondo morto che si pagava. Quello che si manifesta subito – questo ci ha dato coraggio da subito anche in quel momento difficile di esporci con una proposta (quella di andare sotto la prefettura) – è stata questa istanza di rifiuto di rientrare in un meccanismo, quello gestito dalle cooperative, e la consapevolezza che sono i rapporti di forza che fanno la differenza e quel rapporto c’è quando si sta insieme. Contiamo e possiamo fare qualcosa finché siamo tutti insieme. Tutto questo ci dà il coraggio di elaborare questa proposta di andare in prefettura. Non si va però quella sera stessa perché in quel momento qualcosa si smuove, viene organizzata la tendopoli davanti al palazzo incendiato.
Come si è potuta portare questa proposta? Avevate già dei canali, dei contatti? Perché vi riconoscevano?
L: è stato tutto costruito sul riconoscimento delle persone con erano con loro il giorno del distacco dell’elettricità. Lì si era costruito quel rapporto e quindi c’è stato il riconoscimento di compagni di lotta. Perché ci fu anche il fatto che avevano visto bene da parte nostra il rifiuto di giocare quel ruolo di mediazione a ribasso, ma invece di giocare quello di organizzazione e di consiglio… tattico. Solo tattico, in quel momento non c’era bisogna di altro. Per cui questo ci ha permesso di avanzare questa proposta…
Quindi in prefettura non si va quella sera ma la mattina dopo. Si va decidendo di mettere in chiaro che quella morte è una morte politica, che ha una responsabilità politica e nel fare questo avere l’attenzione al fatto che questo momento rappresentasse un passaggio interno più che altro. Come compagni da subito e per tutto questo periodo di lotta abbiamo lavorato pochissimo sulla solidarietà umanitaria o anti-razzista o anche radicale.
Rifiutare una condizione e forse un ruolo no? Quella di essere degli assistiti dentro il meccanismo dell’accoglienza
L: si c’è stato la negazione del ruolo che gli viene costruito addosso: in quel momento i rifugiati pretendono diritti e rifiutano l’assistenza. Per noi si pone infatti il problema di come trasformiamo questa volontà in una piattaforma rivendicativa, come diamo espressione a un certo tipo di pretesa in una piattaforma che possa essere uno strumento su cui si sviluppa un conflitto che metta al centro la soggettività. Non un discorso di critica né un discorso di soluzione ma neanche un’irraggiungibilità che avrebbe relegato tutto alla dimensione della “critica”, perché serviva una piattaforma che aprisse comunque delle contraddizioni. E allo stesso tempo individuiamo la questione fondamentale nel “tornare a contare qualcosa”, quindi non essere più trattati come oggetti passivi da spostare o inserire in un progetto a scadenza. Quella roba si concretizza nel fatto di puntare dritto sul Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che vedrà tre manifestazioni durante le sue riunioni, ogni volta che si riunisce per decidere sulle sorti dei rifugiati dell’ex-aiazzone, sulla pretesa di essere a quel tavolo. Il che ovviamente riveniva a negarlo quel tavolo, perché il Comitato per l’ordine e la sicurezza non è uno spazio di mediazione politica ma è esattamente la rappresentazione della volontà di trattare la questione invece come un problema di ordine pubblico. Quel Comitato era in quel momento il livello più alto di decisione e di comando sulle loro vite. Questo è stato il motore di quella settimana lì. Tornare a contare, la nostra voce deve esserci quando si decide delle nostre vite, a partire da una rigidità: quella forma di accoglienza dev’essere superata. È chiaro che c’è una parte di spontaneità, quello che noi però abbiamo provato a fare e di provare a tradurre una critica che stesse su un livello politico ma non troppo alto. Da una parte ri-tradurla nella critica al sistema di accoglienza. Che invece dal punto di vista soggettivo loro stava sempre in un’ambiguità tra il rifiuto totale – che ha anche un corollario di auto-marginalizzazione nella propria comunità chiusa – e una possibilità di sopravvivenza che garantiva quel sistema. Dall’altra costruire un discorso, una tensione che costruisse un aspetto vertenziale ma che tenesse dentro una tensione più politica rispetto alla nemicità delle istituzioni e anche – lo ripeto tante volte perché è stato importante e vero – del rifiuto del rapporto coloniale. Quindi la nemicità con l’istituzione italiana. Per esempio durante la seconda manifestazione sotto la prefettura è quello che è stato urlato in faccia agli sbirri per un’ora e mezza, in quanto rappresentanti della mano armata dello Stato italiano: voi avete ucciso mio nonno, siete voi!
Quindi com’è andato questo primo momento alla prefettura? C’è stato questo passaggio all’interno di cui parlavate?
E: Dopo questa notte allucinante in tendopoli andiamo in corteo alla Prefettura di Firenze dove non c’è nessuno, solo la polizia che ci carica e da lì poi di nuovo corteo fino a palazzo Strozzi dove occupiamo la mostra di Ai WeiWei [artista cinese che aveva fatto dei lavori sui migranti a Idomeni]. La situazione di quel giorno è rabbia e voglia di farsi sentire, nella prima fase si arriva in corteo alla prefettura ci si avvicina alle porte tutti insieme premendo sulla polizia che impedisce l’accesso, si blocca il traffico e viene vissuta male la prospettiva di andarsene da li senza aver ottenuto niente. Questa insoddisfazione si concretizza nell’irruzione alla mostra in uno spazio sia nella determinazione a continuare la protesta che nella volontà di presa di parola. L’occupazione della mostra attira l’attenzione sulla vicenda, arriva la stampa e da parte dei rifugiati c’è la presa di parola pubblica sulla situazione specifica ma sulla vita in generale, in particolare sul lavoro e sui documenti. Ciò determina anche una situazione di fiducia, perché in vent’anni mai c’era stata la possibilità di una presa di parola sulle loro istanze perché c’era proprio l’abitudine (che fosse dai movimenti, dalle cooperative o dalla controparte) di essere parlati e non prendere parola. In questo senso si crea la determinazione di rimanere lì a oltranza questo fa sì che venga convocata la prima riunione del Comitato per la sicurezza, convocato di urgenza dentro questa situazione, da cui emerge la disponibilità all’ospitalità nel palasport a Sesto per la totalità delle persone fino alla riunione successiva del Comitato della sicurezza. Quella giornata di conclude con l’ottenimento di un posto dove stare effettivamente tutti insieme e anche la chiarezza del fatto che le istituzioni dovevano prendere in carico la questione.
L: è utile ragionare su una cosa. A livello politico nella città di Firenze, a livello di opinione pubblica, la questione rifugiati somali è sempre stata presente e forte. Il suicidio di cui abbiamo parlato aveva avuto un effetto come gli sgomberi, che avevano anche incontrato un’altra sensibilità – si parla comunque di altri anni. Questa volta invece succede una cosa completamente diversa perché quello spazio viene conquistato dai somali. Non è uno spazio di solidarietà. Quello spazio però è fortissimo e di conseguenza ha anche una qualità diversa perché non solo loro conquistano uno spazio mediatico che gestisce poi l’ organizzazione politica ma si conquistano proprio la presa di parola diretta. Il giorno dopo allora succede che si apre una questione rifugiati non dal punto di vista della risposta da dare a un problema ma si apre la questione del “questi non vogliono più lavorare per due euro l’ora, non vogliono più il ricatto del permesso di soggiorno”. Grosse interviste sulle loro condizioni, le loro condizioni di lavoro etc. L’occupazione della mostra ha questo aspetto qui, supera anche le proporzioni che immaginavamo diventando una cosa quasi internazionale almeno a livello di informazioni, fa un tweet anche l’artista, Ai Weiwei, in sostegno. Crea internamente un senso di rivalsa, di una rivalsa che si sta conquistando. #00:49:10.0# Si prende a partire da quel giorno un gusto a determinare una situazione politica, nel contare, nell’avere un peso. Per cui è in questo contesto che inizia la fase del palazzetto dello sport.
La controparte, vedendo i comportamenti, il protagonismo che si era imposto… con chi parlava?
L: con nessuno
E: sì, con nessuno
L: La controparte rimane fortemente spiazzata da quello che succede. Non poteva trovare qualcuno che garantisse una mediazione a ribasso, una gestione di soggettività disposte alla rottura a alla contrapposizione. Inizia lì al palazzetto la riorganizzazione in vista del secondo Comitato di sicurezza, che deve trovare le soluzioni di accoglienza. Viene elaborata un primo piano che di fatto prevede il solito: accoglienza in emergenza freddo per tutti quanti, otto persone negli SPRAR e strutture sociosanitarie per i malati. Faccio una parentesi su questa cosa dei malati. Ce n’erano diversi e si trattava di malati mentali. Che, a quanto ci dicevano i ragazzi, sono tutti ex-capi di comunità, i saggi. Una cosa che tornava nelle assemblee era: noi non finiremo come loro, loro erano i più intelligenti e li hanno fatti impazzire, sono tutti diventati alcolizzati o pazzi. I saggi negli anni sono impazziti a fare questa vita. Quindi proprio una consapevolezza su quanto quella condizione di vita potesse farti del male.
Nessuna, insomma, delle condizioni poste (stare insieme e avere soluzioni definitive) viene rispettata in questo piano del Comitato…
L: sì, e infatti la prima cosa che viene organizzata al palazzetto è il rifiuto politico di questo piano di accoglienza. Che si concretizza in questo sabato in cui arriva la mandria di assistenti sociali, educatori che viene con l’intenzione di fare dei colloqui individuali con tutte le persone censite per poi indirizzarle nelle diverse strutture. Il rifiuto si concretizza plasticamente con lo stare tutti sulle gradinate e la nomina di cinque delegati che dovevano rappresentare tutti. Rifiutare quindi il meccanismo d’individualizzazione dei colloqui. La nostra assenza, in quel momento, segna un forte discontinuità con il passato, l’indisponibilità a farsi tramite e mediazione. Tramite nell’accettare o nel rifiutare, soprattutto nel rifiutare, che diventa però il tuo rifiuto, e quindi anche il tuo assumerti la “soluzione alternativa”. Le istituzioni sono abituate a parlare da banchi a bianchi, ed era l’ora invece che fossero messi a rapporto crudo con l’autonomia e le rigidità costruite nella lotta dai rifugiati stessi. E così, guardando a questo utilizzo a tutto uso della controparte, stavolta noi veniamo per certe vie cercati perché questa folla di assistenti sociali ha paura anche solo ad avvicinarsi. Noi ci sottraiamo e quindi finisce così senza nessun contatto, prendono e se ne vanno.
E: Gli assistenti sociali rifiutano di relazionarsi con i rappresentanti, con la voce politica dei somali.
L: sì perché non vogliono riconoscere, di fatto, una potenza, e quindi non gli parlano. Questo è il punto. C’è una conferenza stampa dei rappresentanti fuori dal palazzetto in cui i rifugiati spiegano le ragioni del rifiuto del piano di accoglienza e la giornata finisce così. Il Comitato per la sicurezza si riconvoca e deve fare i conti col fatto che il loro piano è stato rifiutato e il palazzetto deve chiudere.
Noi ci ponevamo questo problema, che era quello su cui ci sentivamo più deboli: affermare un nostro ruolo che non fosse svilente della loro autonomia. Questa volta ciò si produce grazie ai momenti di conflitto in cui si afferma il fatto che i militanti sono quelli che stanno con te, che si prendono le botte con te, fanno le cose con te. A un certo punto durante un’assemblea al palazzetto, me lo ricordo bene, mentre prendevamo la decisione di come muoverci rispetto alla convocazione di un nuovo Comitato sull’ordine e la sicurezza, uno di loro disse: noi vogliamo andare in fondo, non c’interessa occupare, voi siete i nostri occhi. Quella roba li ha segnato per noi il “ce l’abbiamo fatta”. Essere stati riconosciuti come quelli capaci di dare un indirizzo strategico e tattico, di sguardo su un’indicazione politica data da loro. All’inizio, fuori all’ex-Aiazzone in fiamme, per esempio questa cosa di andare in Prefettura non era presente. Ci interrogammo anche in quel momento su questa cosa. La prima sera dopo l’incendio la cosa era “noi non ci muoviamo da qua!”. Una cosa che ci aveva lasciato abbastanza spiazzati! Solo dopo capimmo che quel dire “rimaniamo qua” era una mancanza di prospettiva, volevano dire “vogliamo dargli fastidio”. Dovevamo solo tradurre con uno sguardo intelligente quell’indicazione. Rimaniamo a Sesto tra le macerie non gliene frega niente a nessuno, se vogliamo farci vedere e contare dobbiamo andare sotto la Prefettura.
È bella questa cosa no? L’indicazione politica che viene dalla composizione e tu sei solo il traduttore. Spesso invece facciamo il contrario, tu militante dai l’indicazione e poi lasci alla composizione la scelta sui mezzi più idonei per raggiungerla…
E: Infatti su questo emerge quindi un ruolo nostro completamente diverso da quello di chi ti dà una mano, ossia il volto buono del colonialismo. Il missionario che arriva insieme al soldato. È un assunto che tu devi mettere in questione come militante. E di fatto si è messo in discussione solo nel momento della conflittualità, con un passaggio anche bello rispetto a quei nostri compagni che i rifugiati neanche conoscevano, nel riconoscimento collettivo di tutti quelli che c’erano sotto la prefettura, nell’essere dalla stessa parte nel momento della rottura. Non a parole, non nei discorsi ma nei fatti. E questo è diventato il siete i nostri occhi, lo sguardo tattico-strategico: non siete quelli che ci danno una mano… siete dalla nostra parte! Si è creato uno scarto di quel genere lì. Anche rispetto ai nostri stessi tentativi fatti nei mesi precedenti di relazionarci con loro, abbiamo visto questo riconoscimento incredibile per loro del fatto che ci siano dei bianchi dalla loro parte. Non che li vogliono aiutare o intortare o venire contro. Qualcosa invece che non è né l’assistenzialismo né la repressione. È la presenza di rapporto diverso che ha reso possibile il riconoscimento di un ruolo diverso. Costruito anche sulla fiducia di dirsi come stanno davvero le cose, del confrontarsi sulla realtà dei passaggi tattici che è stato una vera conquista anche viste le corazze che avevano costruito nel rapporto assistenziale. Un rapporto molto chiaro che loro avevano con il mondo dell’associazionismo e che non si concretizza in un rifiuto in quanto rifiuto dell’aiuto, perché l’aiuto serve, ma nel “ti considero alla stregua dello sbirro perché sei comunque contro di me. Ti sfrutto finché posso e basta”. Un rapporto lucido da parte loro, da cui è derivata anche una facilità della condivisone delle necessità strategiche e della conflittualità.
Una cosa che ci ha sorpreso, nonostante l’avessimo visto nella pratica è che non c’è solo la rabbia ma la consapevolezza nella lettura di una situazione molto maggiore di quella del perdere la testa e incazzarsi sul momento ma una rabbia, un’insofferenza data dalla consapevolezza di una situazione, del fatto che in quella situazione s’impazzisce, del ruolo delle istituzioni nella loro veste più amichevole come nella loro veste più violenta.
Sarete i nostri occhi è un po’ come dire “siete del mondo del nemico ma non gli appartenete”
L: esatto, esatto è proprio questo. Volevo incrociare questo discorso che stiamo facendo sugli occhi con quello che accennavamo prima sulle controparti. In quei giorni sia su il Corriere che su La Repubblica uscivano due editoriali che dicevano sostanzialmente entrambi la stessa cosa: Ma questi somali, ma chi cazzo glielo ha detto? Chi gli sta dando questa intelligenza politica? Il discorso era insolito. Non era quello classico del “sono gli antagonisti che li stanno manipolando”. Perché era un discorso intenibile, già dalle immagini si capiva che erano loro stessi che conducevano questa battaglia. Erano i somali. Questo in realtà questo era solo mettere un nero su bianco quello di cui loro hanno paura: ossia il protagonismo della soggettività accompagnato da un’intelligenza politica che non può, per i suoi strumenti, avere. Ed effettivamente abbiamo scommesso sulla fiducia su un nostro ruolo di “traduttori”.
Torniamo quindi alla seconda manifestazione in Prefettura
L: si c’è stato questo momento alto dello scontro in prefettura. Un momento fondamentale perché ha espresso quella volontà ragionata della rottura. È stata molto lineare nel suo aver funzionato. Corteo partito dalla stazione di soli somali. Nonostante fosse pubblico ma ci fu una sottrazione di tutti, nessuno ha partecipato, nessuna compagine organizzata. Il corteo si ferma a venti metri dalla prefettura, leggono le loro richieste, sul fatto che non si decidessero di piani di accoglienza che non facessero i loro interessi, e poi c’è un momento di scontro per provare a entrare, due volte, infine una lunga permanenza sotto la prefettura. Con la digos che cercava come al solito il rapporto umano con le persone per calmare le acque e loro invece che gli scaricano addosso le responsabilità coloniali. Un momento molto significativo. Tutti poi aspettavano la conferenza stampa da parte del Comitato di sicurezza sulle decisioni prese. Ormai eravamo li da sei ore (da notare che tutti le iniziative di lotta sono durati tra le sei e le dieci ore, una cosa allucinante!). E queste conferenza stampa viene annullata, senza che lo sapessero manco i giornalisti. La Digos viene e gli dice “non vi diciamo cosa è stato deciso se non tornate a Sesto”. Quindi poi tutti seduti per terra. Un altro momento di rigidità, che si esaurisce dopo un tempo però comunque sintomo di una politicità forte. Poi, di fronte alla chiusura totale da parte delle istituzioni, inizia sia da parte nostra che da parte loro questa consapevolezza che dovevamo chiuderla, mettendo un punto e coltivando le possibilità di un rilancio. Cioè chiuderla per non chiuderla. Inizia quindi una fase complessa. Andare ad occupare per loro era una sconfitta fin dall’inizio. E anche per noi. Però a quel punto li era maturata una chiarezza, e una fiducia: non si trattatava di un passo indietro, di un ritorno alla marginalità, sarebbe stato un passaggio in un percorso più lungo in cui continuare a lottare e quindi anche rifiutare la stessa condizione di occupanti. L’occupazione questa volta nasce in un clima di riscatto, e non di disperazione… per continuare a giocarsi una partita più grande…
E: Comunque la questione dell’occupare è stata anche affrontata in maniera diversa. Molto esplicitamente il discorso era: non ci piazzerete di nuovo nell’Aiazzone di turno. Noi questo non lo vogliamo. Si gioca una partita più grossa quindi non vogliamo occupare in quei termini lì. Il che ha reso evidente una comunanza d’intenti tra noi e loro sul fatto che l’occupazione non fosse la fine della questione ma un passaggio anche a partire dall’affermazione di andare ad occupare non nascosti, non nel posto raccattato. Andare a occupare nel posto centrale, visibile, dignitoso, bello che fosse anche in discontinuità con le occupazioni come loro le avevano vissute fino a quel momento. Come elemento pratico che rispondesse a queste necessità.

C’è questo nodo politico grosso rispetto alla composizione migrante, di un’insufficienza della nostra azione politica su questo fronte anche rispetto a una crescente inimicizia coltivata scientemente tra immigranti e italiani. Il nostro discorso e la nostra prospettiva militante non si discosta è sempre appiattita sulla stessa dimensione di solidarietà che alla fine è quella dei preti o dell’arcobaleno di sinistra. In questa lotta si configura invece anche una lotta di rifiuto dell’accoglienza, di rifugiati contro l’accoglienza. Che poi è proprio questo il punto di frizione più grosso, il fastidio dell’italiano è meno sul migrante in sé che sul sistema delle cooperative e il meccanismo dell’accoglienza. Questa dimensione di rifiuto dell’accoglienza è stata potente, il rifiuto di un ruolo che gli viene cucito addosso. Potete sviluppare questo nodo: il rifiuto del rapporto di accoglienza?
L: Faccio un attimo un passo indietro. Come abbiamo potuto essere riconosciuti come questa possibilità [di rottura] da parte dei rifugiati? Sicuramente – e non è scontato – riconoscere esplicitamente quel mondo lì [dell’accoglienza] come nemico è stato fondamentale. Farlo esplicitamente. Ciò passa anche proprio dal modo di relazionarsi a questi del terzo settore, di parlare di loro. Anche con la polizia è stato fondamentale: far capire che c’era un’ostilità. E vale sia come riconoscimento dei militanti politici tra i rifugiati e vale anche per il riconoscimento dei rifugiati politici da parte di altre composizioni sociali. Quella roba lì ha esplicitato comunque un rapporto di inimicizia, di ostilità tra i rifugiati e quel supposto sistema che li accoglie, li tutela e li “favorisce”, li “privilegia” rispetto al cittadino italiano. E quello sicuramente è una traiettoria, una direzione. Noi abbiamo provato avere molto lo sguardo in quei giorni li stando su quegli strumenti che avevamo a disposizione, molto i sociali network e le reazioni delle composizioni dei quartieri popolari che conosciamo, materiale molto grezzo… molto superficiale diciamo. Però noi delle cose ce l’abbiamo viste, abbastanza almeno per estrarre delle ipotesi. Noi abbiamo visto che quando ci fu il rogo e la morte di Ali Muse il livello di empatia per questa cosa non c’era, non c’era nessuna sensibilità semmai il contrario. Perché il primo trattamento mediatico riproduceva sempre l’immagine del rifugiato come vittima, che andava compianta. E su questo non s’intercetta nulla. L’immagine invece dei rifugiati sotto la prefettura, a scontrarsi con la polizia, a urlare contro le cooperative… è un’immagine che hanno condiviso – che è stata condivisa – sulle bacheche dei peggiori razzisti che entrano in contatto coi nostri percorsi di lotta. Perché in qualche modo loro hanno negato quel ruolo lì e hanno affermato intanto una loro umanità, attraverso la lotta sono ridiventati degli esseri umani con dei bisogni e dei problemi etc. ma hanno anche messo in crisi lo sguardo con cui una fetta dei proletari li guarda o in ogni caso a un supposto sistema che muove le cose intorno a loro. E quindi guardando alle traduzioni di questo passaggio qui abbiamo assistito nella migliore delle ipotesi a un riconoscimento di essere quelli che stanno avendo il coraggio di battersi contro delle istituzioni che sono nemiche, le stesse che sono nemiche a tutti, nella peggiore un “dovremmo fare noi come fanno loro”. Però comunque un piano che ristabilisce, ridefinisce una gerarchia di nemicità: il rifugiato non sta insieme alla cooperativa o la prefettura. Non fa parte della mia parte, però in questa scala è l’ultimo. Ovviamente non è quello a cui dobbiamo mirare però [è già un passaggio importante]. Quei giorni sono stati molto intensi quindi non abbiamo mai avuto il tempo di fermarci e tematizzare le cose di cui stiamo parlando, ma spesso in corso d’opera alcuni compagni hanno posto la questione del consenso: stiamo facendo ‘sta roba, ci stiamo rovinando! C’era questa paura, me la ricordo, da parte di alcuni compagni, ma forse ce l’avevamo tutti, alcuni la esprimevano altri no ma ce l’avevamo. La città ci odierà, andiamo a rompere le palle con il nemico pubblico numero 1, la nostra stessa gente non ci capirà per questa cosa. E secondo me è stato importante invece scommettere su questa cosa, liberarci di quella paura. Questa cosa che tematizziamo col senno di poi, ci abbiamo scommesso un po’ più al buio di quello che si può pensare… però ha funzionato secondo me, anche verso quel piccolo frammento di composizione proletaria italiana dei quartieri popolari, quella che è più affascinata da questi discorsi razzisti, oggi quando loro parlano di questi rifugiati parlano di un percorso di lotta. Parlano di istanze di pretese, di sogni e quindi l’immaginario è stato completamente ridefinito. Attenzione non vuol dire che ciò è vero per “i rifugiati”, quelli che sbarcano continuano a “essere un problema”, però si è incrinata quella rappresentazione. Ciò riflette un po’ una discussione che avemmo lì alle case popolari delle Minime, una di quelle discussioni in cui saremo capitati tutti, sui 35 euro, le cooperative etc. uno di questi delle Minime ci diceva “sì però ci stanno bene loro lì dentro, si è vero che le cooperative ci mangiano, non gli danno un cazzo ci ho lavorato e lo so, però loro ci stanno bene, non fanno un cazzo, quindi vuol dire che gli va bene se gli portano un paio di scarpe ogni sei mesi che stanno lì e non devono lavorare non devono fare un cazzo”. Invece la non accettazione di quella cosa… forse faccio un po’ confusione, però mi fece riflettere sul fatto che dobbiamo magari distinguere un po’ alcune pulsioni… per esempio questo discorso che faceva quest’uomo delle Minime potrebbe essere paragonato in un certo senso a quello sulla disponibilità al lavoro sotto-pagato e super-sfruttato: “tu porco dio però ci lavori per 2 euro l’ora, e allora mi stai sul cazzo!”.
Nel momento in cui c’è la sottrazione dal ruolo dell’essere “il rifugiato” e l’emergenza di un soggetto sociale. Questa cosa andrebbe approfondita. Le storie di queste persone. Per esempio anche di Ali Muse… Lui lavorava no?
L: sì lui lavorava, questo lo urlava cugina la sera stessa quando è arrivata la notizia del decesso. Urlava agli sbirri: “lo avete sfruttato per dieci anni, lavorava nei campi per 3 euro l’ora, volantinava per 2 euro l’ora!”. Noi non sappiamo quali sono i canali ma fanno tutti questi due lavori: volantinano e lavorano nei campi.
Comunque emerge la potenza della negazione di un ruolo: la donna che si nega nel riempire il ruolo in una certa riproduzione sociale, neghi il il tuo ruolo di attore. È lì che comincia la lotta rivoluzionaria. È la stessa cosa dell’auto-negazione proletaria. Tocca anche la questione del valore dell’agire umano, quella roba lì nel sistema di accoglienza è annichilita. Stanno lì ad aspettare, prendono i soldi, le scarpe ma “non fanno un cazzo”. O Anche “sbarcano e ci parassitano”. E invece nella lotta c’è una valorizzazione alta dell’agire, è un iniziare ad agire. E questa cosa può essere vera anche per la controparte. L’ingiunzione al lavoro gratuito e volontario è una declinazione di questa consapevolezza è come la controparte agisce questo ragionamento qua.
Io aggiungerei ora anche un discorso generale sugli ambiti sociali che sono “ai margini” oggi e che spesso organizziamo nelle nostre lotte. Che ruolo giocano queste lotte? Dicevate prima che l’occupazione è una tappa di un ciclo che è governato: SPRAR-cooperativa-occupazione e poi da capo. Qui c’è stata la capacità di rompere quel ciclo a partire dalla soggettività militante. Il militante che rifiuta di essere il mediatore, quello che risolve il problema, che prende la decisione di non risolvere un bisogno immediato per andare a coglierne uno più profondo.
E: sì il fatto di essere soggetto e non oggetto passa anche dal potersi esprimere. Qualcosa che è venuta fuori nel percorso di lotta e non prima, questa maggiore complessità delle istanze può emergere solo dalla rottura di quella ciclicità di cui parlavi e quindi della rottura della compartecipazione dei movimenti e degli attivisti in quel ciclo lì, del riprodurre la condizione di vita marginale, il “ti devi accontentare” che è quello dell’assistenzialismo in tutte le sue forme più o meno consapevoli. Questo è tuttora un problema. Anche ora su come continuare a partire dell’occupazione, vedere anche il rischio sgombero come una possibilità di affermare qualcosa in un contesto in cui si viene da dieci anni in cui la voglia di contare è stata repressa il che genera anche uno sfiducia nella possibilità che ciò che possa succedere. È qualcosa con cui ci scontriamo tuttora, una rassegnazione all’impossibilità che i bianchi, l’Italia possano anche solo comprendere le loro istanze. L’impatto invece positivo di questa lotta – si parlava prima dei quartieri popolari ma si può generalizzare a tutta la dimensione della presa di parola pubblica, anche attraverso i giornali – è che è stata una cosa eccezionale il fatto che si sente parlare di profughi ma si sentono parlare “i profughi”. Questa cosa ha rotto quel meccanismo che si riproduce anche in altri contesti, quello dei profughi è quello più estremo, ma il fatto di essere parlati, oggetto di discussione e mai soggetto di niente, non avere mai la possibilità di dire la propria si riproduce su tutte le forme di vita proletaria e su tutti i contesti: essere oggetto della discussione politica, ma mai parte in causa della stessa. In questo senso è stato un passaggio che ha rotto questo meccanismo anche su scala più ampia. Prendiamo la stessa critica ai 35 euro… i rifugiati dell’ex-aiazzone fanno lo stesso discorso dell’italiano razzista su questo “quei soldi ce li rubano!”. Un discorso che non esce mai fuori.
L: Ritorno sul punto che affrontavamo prima: come farci riconoscere per ciò che siamo. Secondo me questo passa, deve passare, da un sottrarsi violento da alcune cose.
Quali?
L: Intanto dalla gestione, da ogni tipo di aspetto gestionale e dalla dimensione dell’ “aiuto”. Ad esempio al palazzetto dello sport, dove c’era una quotidianità gestita dalla protezione civile, dalla Misericordia – dei nemici – e noi, a parte in un episodio, è stato fondamentale sottrarci da ogni pretesa del metterci noi a dire a loro che non devono fare così. Ossia giocare la nostra funzione di mediazione e di peso per migliorare le loro condizioni di vita materiali li dentro. Questo è stato fondamentale, non andare a pretendere niente dalla protezione civile, non andare a dire loro che il cibo faceva schifo ecc. Noi ci siamo sottratti violentemente a questa cosa qui. È stato faticoso. Avevamo delle cose davanti agli occhi che, come compagni, ci facevano incazzare. Però è stato importante sottrarci: innanzitutto per lsciare gli spazi di un protagonismo loro ad agire in questo senso ma soprattutto perché loro non devono poter fraintendere che tu sei il tramite tra quei due mondi, quello dell’assistenza e i rifugiati, invece che quello che è dalla loro parte. Ciò che voglio dire è che ci sono delle cose a cui bisogna sottrarsi in assoluto, come la gestionalità pura, poi ce ne sono altre in cui ci sarebbero degli spazi di organizzazione di una pretesa sulle condizioni di vita, come per esempio ce n’erano al palazzetto dello sport. Però secondo me è stato fondamentale concentrarsi solo sulla pretesa complessiva, anche limitare delle possibilità, però concentrarsi su alcune. Sul politico. Non dare spazio a fraintendimenti, a storture rispetto a quale era il nostro ruolo lì. Quando noi andavamo lì loro sapevano che era il momento in cui si organizzava la loro lotta, in cui arrivavano i loro occhi per capire qual era il prossimo passaggio. Non per il “Come stai? Il cibo com’è? Ma la coperta te l’hanno data?”. No.
Non so se è corretto ma si parla anche della difficoltà, per esempio nel contesto dell’accoglienza temporanea durante l’emergenza abitativa in strutture temporanee, là dentro è difficile costruirsi una lotta. Non puoi costruire la pretesa su una condizione che è già un’imposizione di un comando.
L: sì esatto. Questo aprirebbe un capitolo lungo. Ma è ovvio che sono studiate in questo senso queste strutture di prima accoglienza. Sono studiate per impedire che si possa sviluppare una pretesa. La condizione di vita lì dentro è indifendibile ed irriformabile. C’è un comando così grosso sugli orari, una sottrazione di autonomia per cui non puoi cucinarti, non puoi decidere a che ora tornare a casa che lì dentro consente non solo d’impedire ogni forma di rivendicazione ma anche di gestire in maniera molto semplice il mandare via la gente: semplicemente le persone se ne vanno via volentieri.
Ti disumanizza talmente tanto che non vedi l’opportunità di lottare per essere un pochettino più umano
L: per dare un’idea, su Firenze sono 1’000 posti per l’emergenza abitativa e non dura quasi nessuno più di tre/sei mesi. Gli episodi di resistenza di famiglie che vogliono rimanere lì, si contano sulle dita di una mano.
È come il carcere o ti ammazzi o se esci devi ritornarci.
E: un passaggio che è interessante su questo, sull’invivibilità di queste situazioni è che alcuni dei rifugiati in lotta [che erano con un piede in queste strutture di accoglienza temporanea] sono stati buttati fuori. Ci raccontavano che durante la lotta le cooperative e le strutture rifiutavano i somali in quanto tali, nel dubbio che ci potesse essere qualcuno di quelli che lottavano.
È che noi usiamo un po’ a caso questo termine “migrante”, per descrivere una situazione molto stratificata ed eterogenea. Cosa c’entra il migrante che è in occupazione tra trent’anni ed è sicuro più italiano di me con i ragazzi di Ventimiglia che vogliono solo andare in Francia? Questo termine è inadeguato perché non rende conto della stratificazione di quella composizione anche rispetto alle sue attese e pretese, quindi possibilità di spazi di lotta.
L: chiaro, sull’ex-Aiazzone parliamo proprio di gente che immagina la sua vita qui. Anche su questo abbiamo ragionato. Il movimento li ha sempre trattati come fossero “i migranti”, come fossero di passaggio quindi in qualche modo non c’è da organizzare la pretesa di migliori condizioni di vita ma solo la loro sopravvivenza in vista di… niente, di fatto. Quello che è particolare tra questi rifugiati dell’ex-aiazzone è il co-esistere di un’aspettativa e una pretesa abbastanza alta di quello che loro chiamano “una vita normale”. Tra di loro ci sono anche iscritti all’università, per dire. L’aspettativa di una vita normale e una completa disillusione che si possa raggiungere. È una caratteristica sedimentata dagli anni che hanno passato in Italia, sono stati fondamentali questi anni per produrla. Non è data. Per le esperienze che abbiamo, quando i migranti sono appena arrivati si aspettano che qualcosa lo raggiungeranno e quindi c’è anche paura a sottrarsi a certi meccanismi, devono starci comunque dentro perché qualcosa si aspettano che arrivi. Loro no. C’è anche un grande cinismo su questo, anche nell’informalità è uscito fuori. Rimasi molto colpito. Gli chiedi: come va? Loro: 5 anni di merda, 10 anni di merda qui in Italia, tempo buttato. Però mantengono l’idea di essere qui per un obiettivo. Non per essere tossici e alcolizzati.
E: Secondo me c’è anche un enorme particolarità dei richiedenti asilo rispetto alle condizioni di partenza. Anche questo ci ha stupiti all’inizio ma se ci si pensa è ovvio che le persone che arrivano qua sono quelli che avevano una vita più agiata nel paese di provenienza, altrimenti semplicemente il viaggio non lo fai. Quindi esiste una complessità enorme sui concetti di migrazione economica e fuga dalla guerra, perché la maggior parte delle persone dopo il rogo della casa non è che mettevano la propria situazione a raffronto con delle aspettative ma anche delle condizioni di vita pregresse. Io sono rimasta esterrefatta ad sentire non da una ma da più persone “qui si muore di fame, si muore di freddo, si muore bruciati… in guerra si muore quando ti sparano altrimenti se sopravvivi mangi e hai la casa”. Perché sono persone che avevano nei paesi di provenienza delle condizioni medio-alte, perché sennò non sarebbero potuti venire in Europa.
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.
FirenzemigrantirifugiatiSEMINARIO AUTONOMIA CONTROPOTERE 2017