
Ancora catene da spezzare – Appunti su pratiche di libertà e ed autodifesa
Un contributo da Associazione a Resistere – Pisa
Originariamente pubblicato su Libreria Popolare Paulo Freire
Negli ultimi anni, all’interno dei movimenti transfemministi italiani ed europei, si è manifestata una dinamica preoccupante: l’uso di linguaggi e strumenti nati per la liberazione come dispositivi di delegittimazione e controllo. Questa non è una questione marginale o accidentale, ma la manifestazione di processi che le teoriche femministe radicali, nere, postcoloniali e transnazionali hanno analizzato per decenni.
Quando assemblee transfemministe vengono attaccate dopo grandi mobilitazioni, quando la contestazione al potere viene ribaltata in ”aggressione”, quando l’autodifesa viene narrata come ”violenza”, non assistiamo semplicemente a conflitti interni. Assistiamo al funzionamento di quella che Nancy Fraser chiamerebbe la cattura neoliberale del femminismo, un processo attraverso cui linguaggi e pratiche liberatorie vengono riconvertiti in dispositivi di neutralizzazione politica.
Nel documento che segue, nato come contributo di Associazione a resistere – Pisa anche a partire dalle suggestioni e riflessioni sviluppate in questi anni di percorsi, iniziative e letture della Libreria, si trovano delle prime riflessioni sulla manipolazione con cui il femminismo liberale agisce nelle lotte. Nominarla e riconoscerla, rintracciando al contempo una genealogia della resistenza ad essa che da sempre ha animato la ribellione delle donne e delle soggettività dissidenti, è un’occasione per noi fondamentale. Il testo che ne viene fuori è uno strumento che mettiamo a disposizione delle lotte, per fare in modo che sempre meglio si riesca a organizzareci per difenderle, grazie a una comprensione politica e profonda del fenomeno.
Chi può permettersi di sentirsi “a disagio”
Bell hooks denuncia nel suo testo fondamentale che il femminismo dominante è diventato un progetto costruito per donne che già avevano potere. Questa osservazione ci costringe a una domanda scomoda: chi può permettersi di descrivere come ”violenza” il conflitto politico? Chi e perché qualcunə si sente ”aggredita” quando vengono contestate figure istituzionali?
Questa domanda abbiamo provato a porcela più volte in questi anni e la risposta non è semplice, ma è strutturale: chi non è abituata a mettere in discussione il proprio posizionamento di classe, chi non ha mai dovuto praticare autodifesa collettiva, chi può contare su reti di protezione istituzionali che includono accesso ai media, mobilità geografica, capitale sociale.
Questo non significa che tutte le emozioni di disagio siano false o non vadano prese sul serio, ma che vanno politicizzate: da dove viene questo disagio? Cosa protegge? Quali dinamiche di potere vorrebbe lasciare intatte?
Hooks ci insegna che esiste un femminismo che si concentra sulla ricerca di ”comfort” solo per alcune categorie di persone, che per semplificare diremo ”privilegiate”, e che questo è un femminismo che ha tradito il proprio mandato trasformativo. Quando il femminismo diventa richiesta di sentirsi a proprio agio senza mai interrogare chi deve sentirsi a proprio agio e a spese di chi, siamo già dentro la logica che hooks denuncia: un femminismo che serve chi ha già accesso al potere.
«Frequentemente, donne istruite che avevano frequentato l’Università (anche quelle che venivano da background poveri e della working class) erano svalutate perché considerate mere imitatrici. La nostra presenza nelle attività dei movimenti non contava, dal momento che le donne bianche erano convinte che la ”reale nerezza” significasse parlare i gerghi della gente nera povera, non istruita, di strada e molti altri stereotipi. Se osavamo criticare il movimento o assumerci la responsabilità di ”riformare” il femminismo e introdurre nuove idee, le nostre voci venivano spente, ignorate, silenziate».
Bell hooks, Feminist Theory: From Margin to Centre, Routledge, New York 1984.
Ci si aspettano tante cose dalle donne cosiddette ”razzializzate”: ci si aspetta, in primo luogo, di avere a che fare con soggetti deboli, in gran parte sprovvisti del potere di autonarrarsi, con cui è difficile parlare ”da pari a pari”.
Chi può permettersi di chiedere che uno spazio politico sia ”sicuro” nel senso di emotivamente confortevole? Chi non deve preoccuparsi della sicurezza materiale, di pagare l’affitto, di non essere deportata, di non rimanere senza luce e gas. La richiesta di ”safety” emotiva diventa così un privilegio che maschera l’assenza di sicurezza materiale per chi è più marginale.
Gli spazi veramente trasformativi non possono essere ”sicuri” nel senso di confortevoli: affrontare i propri privilegi è scomodo, mettere in discussione dinamiche di potere interne è scomodo, praticare autodifesa collettiva contro chi agisce violenza è scomodo. Se la priorità diventa evitare qualsiasi disagio, diventa impossibile fare politica trasformativa.
La cancellazione della resistenza come forma di potere?
Angela Davis mostra come, nella storia del movimento delle donne, le esperienze di resistenza delle donne nere e lavoratrici siano state sistematicamente invisibilizzate, soprattutto da quel femminismo bianco e borghese che ha assunto la propria esperienza come misura universale. Davis ricorda che le donne nere non sono mai state soggetti passivi: ”Le donne schiave erano almeno tanto combattive quanto gli uomini”.
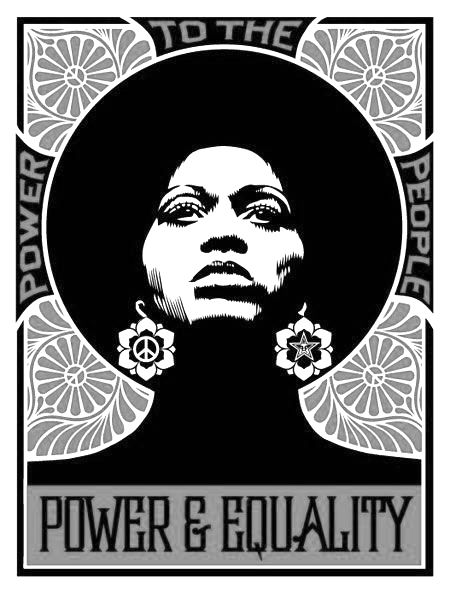
Questa affermazione demolisce l’immagine dominante che ha voluto rappresentare le donne nere come vittime senza agency, negando il ruolo centrale che la loro resistenza ha avuto nelle lotte contro la schiavitù. Davis insiste che la loro lotta è stata quotidiana, radicale, e profondamente radicata nel rifiuto dell’oppressione.
Tuttavia la narrazione femminista egemonica — costruita da donne bianche di classe media — ha spesso escluso o marginalizzato queste esperienze. Non si è trattato di un errore innocente: questa esclusione è una forma di potere. Invisibilizzare la resistenza delle donne nere e working class significa neutralizzarne la potenza politica: ciò che non viene riconosciuto come resistenza non può rivendicare legittimità, memoria, centralità nelle lotte.
L’omissione apre lo spazio per narrazioni più compatibili, innocue e annacquate con i privilegi delle classi dominanti, che possono così presentarsi come il centro naturale del movimento femminista.
L’invisibilizzazione è dunque una tecnica politica: rimuove le soggettività che lottano, riduce la storia delle donne a quella delle donne privilegiate e produce un femminismo che parla “a nome di tutte” mentre cancella le più combattive. Come ci ricorda Davis, ciò che viene reso invisibile può essere controllato, ridefinito, e soprattutto depotenziato.
Questa dinamica non è relegata al passato, si riproduce ogni volta che contestare figure istituzionali viene descritto come aggressione, riprendere spazi sottratti viene narrato come prevaricazione, allontanare persone che agiscono violenza diventa bullismo, reagire a sopraffazioni viene trasformato in comportamento tossico.
Sono tutti atti di autodifesa che vengono sistematicamente ribaltati e presentati come violenza primaria. Chi detiene potere istituzionale può permettersi di descrivere la contestazione come violenza. Chi non ha quel potere, quando si difende, viene criminalizzata. La violenza ascendente, dal basso verso l’alto, viene resa ipervisibile; la violenza discendente, quella del potere, viene naturalizzata fino a diventare invisibile. E così sentiamo ripetere a cantilena ”Ma e’ sempre stato così”.
Rendere invisibile la violenza strutturale e ipervisibile la resistenza. Le istituzioni che tagliano fondi, esternalizzano lavoro, militarizzano spazi non vengono descritte come violente. Ma chi grida contro di esse lo diventa. Non è questione di simmetria. Esiste una differenza fondamentale tra la violenza del potere e la resistenza dellǝ oppressǝ. Confondere le due cose non è un errore analitico, è una scelta politica che sta sempre a vantaggio del potere.
Espropriazione della voce
Chandra Talpade Mohanty ha mostrato come la costruzione occidentale della «donna del Terzo Mondo» funzioni come un dispositivo che riduce esperienze complesse e divergenti a un’unica figura omogenea, passiva e bisognosa di tutela. Non si tratta di un semplice errore rappresentativo: è un meccanismo che consente a chi detiene maggiore potere discorsivo di parlare al posto di altrǝ, sostituendo le loro analisi, le loro priorità politiche, la loro capacità di nominare ciò che accade. La figura della donna «silenziata» diventa così una risorsa narrativa che legittima interventi dall’esterno: più viene rappresentata come vittima inconsapevole, più diventa plausibile che qualcun altro si arroghi il diritto — e la missione — di darle voce.
Mohanty mette in luce come questo processo abbia conseguenze materiali: definire un gruppo come incapace di autodeterminarsi produce spazio politico per chi vuole inserirsi come mediatore, garante, gestore o interprete autorizzato (magari anche a scopo di lucro).
La produzione di sapere diventa, in questo senso, produzione di subordinazione.
Patricia Hill Collins approfondisce questo meccanismo analizzando ciò che chiama controlling images: immagini sociali che non descrivono semplicemente un gruppo oppresso, ma lo rendono intellegibile solo secondo categorie che giustificano e rafforzano la sua subordinazione. Queste immagini funzionano come griglie percettive che filtrano ciò che le donne nere — o qualsiasi gruppo marginalizzato — possono dire e come possono essere ascoltate. L’espropriazione della voce, in questo senso, non consiste solo nel parlare per qualcun altro: consiste nel costruire condizioni culturali tali per cui la parola di quel gruppo venga percepita come non credibile, non autorevole, non politica.
Gayatri Spivak porta questo ragionamento a un livello ancora più radicale: l’atto di «parlare per» è anche l’atto di costruire il subalterno come qualcuno che, per definizione, non può parlare. Non è che il subalterno non abbia voce; è che la struttura discorsiva in cui vive non prevede che quella voce sia riconoscibile come parola politica.
La rappresentazione coloniale della ”donna del Sud globale” come vittima per natura funziona esattamente così: rende inimmaginabile che quella stessa donna possa essere analista della propria condizione, o stratega delle proprie lotte.
In questa stessa linea, Audre Lorde ci ricorda che il silenzio non è un dato di fatto, ma un prodotto sociale: «Your silence will not protect you». Il silenzio imposto, quello che deriva dall’essere sovrascritte da narrazioni dominanti, non protegge mai chi lo subisce; protegge chi lo produce. È un dispositivo di potere che trasforma l’autodeterminazione in un’assenza apparente, permettendo ad altri di occupare quello spazio con discorsi che ricostruiscono la realtà secondo la propria prospettiva.
Quando pratiche femministe adottano, anche inconsapevolmente, queste logiche, si riproduce la stessa struttura coloniale che Mohanty ha smontato: narrazioni che sostituiscono l’esperienza concreta di chi lotta con una storia più funzionale a chi ha maggiore visibilità pubblica. Chi vive precarietà, razzializzazione, marginalità linguistica, chi combina lavoro, cura e lotta quotidiana, si trova allora rappresentata non come soggetto attivo ma come terreno su cui altri possono esercitare il proprio potere interpretativo. L’espropriazione della voce diventa così un mezzo per riorganizzare le gerarchie interne, rafforzando chi già dispone di capitale simbolico e indebolendo ulteriormente chi, nonostante tutto, continua a resistere.
Dal conflitto strutturale al “problema comportamentale”
Nancy Fraser ha mostrato come il femminismo possa essere catturato dalle logiche del neoliberismo, trasformando questioni di giustizia strutturale in problemi di comportamento individuale. Ciò significa che conflitti legati a disuguaglianze di classe, dinamiche patriarcali o sistemi che producono precarietà non vengono affrontati come strutturali, ma ridotti a questioni di atteggiamento, tono o modalità comunicativa di chi contesta.
Quando la contestazione di figure istituzionali che incarnano sistemi oppressivi viene interpretata come ”aggressività” o ”eccesso personale” di chi protesta, assistiamo a questa operazione. Allo stesso modo, quando la necessità di difendersi collettivamente da comportamenti violenti viene ricondotta al presunto abuso o prevaricazione di chi interviene per autodifesa, il conflitto strutturale viene svuotato e spostato sul piano individuale.
Fraser osserva che questo meccanismo sposta la responsabilità dal sistema alle singole, depoliticizzando il conflitto e gestendo la crisi invece di trasformarla. Strumenti come il call-out, concepiti per rendere visibili violenze sistemiche laddove non esistono altre vie, possono così diventare dispositivi punitivi contro chi dissente politicamente.
La forma rimane, il linguaggio della denuncia e della responsabilità persiste, ma la sostanza si inverte: non si denuncia più chi esercita oppressione, ma chi lotta contro di essa; non si interrogano più le strutture di potere, ma si puniscono singole persone che disturbano l’ordine costituito.
Sarah Schulman, inConflict Is Not Abuse, critica la tendenza a leggere come ”abuso” ogni conflitto, ogni attrito e ogni messa in discussione di relazioni di potere interne, interpretando reazioni collettive o individuali come aggressioni morali o patologizzazioni. Questa lettura tende a trasformare la tensione politica in problema privato, a cancellare la dimensione strutturale del conflitto, a smorzare ogni funzione trasformativa della dissidenza.
Quando si applica questa logica, il dissenso, la critica, la rivendicazione di diritti o spazi non diventano occasione di trasformazione, ma fattori di ”disagio” da ricondurre a responsabilità individuali; i conflitti vengono interpretati come fallimenti personali, squilibri emotivi, atti di ”abuso” non strutturale. In questo modo, la possibilità stessa di sollevare questioni politiche, di mettere in discussione privilegi, di opporsi a dinamiche oppressive, viene resa problematica: chi contesta diventa ”colpevole”, chi chiede giustizia viene stigmatizzato
Interpretare il conflitto come abuso significa disarmare la resistenza, privatizzare il dissenso, depoliticizzare la critica.
Il conflitto è condizione inevitabile di ogni lotta per la trasformazione.
In un contesto transfemminista, antirazzista e di lotta contro le disuguaglianze, adottare questo pensiero significa difendere la possibilità di una trasformazione reale. Significa distinguere tra prevaricazione reale e conflitto politico; significa proteggere la capacità di dissentire collettivamente; significa riconoscere la legittimità della rabbia, del rifiuto, dell’autodifesa come elementi centrali di ogni lotta di liberazione.
Dal vittimismo al potere collettivo
Yasmine Nair, intellettuale e attivista queer, ha sviluppato una delle critiche più radicali alla trasformazione della politica progressista in gestione del dolore individuale, a come essa abbia sostituito l’organizzazione collettiva con forme di attivismo centrate sulla vulnerabilità individuale piuttosto che sul potere collettivo.
Chi ha sofferto di più, chi può esibire il trauma più profondo, acquisisce autorità morale. Ma questa dinamica, lungi dal costruire potere collettivo, frammenta i movimenti in competizioni tra vittime, dove l’energia viene spesa nel misurare e validare il dolore individuale invece che nell’attaccare le strutture che lo producono.
Questa narrazione è perfettamente funzionale al neoliberismo: trasforma questioni strutturali in esperienze personali, sostituisce la richiesta di trasformazione materiale con la richiesta di riconoscimento emotivo, e soprattutto paralizza l’azione collettiva sostituendola con infinite richieste di cura individuale. La celebrazione e cristallizzazione delle vulnerabilità può diventare una trappola: invece di essere ciò che vogliamo superare collettivamente, diventa qualcosa che dobbiamo continuamente dimostrare per mantenere la nostra voce.
Vogliamo proporre invece una politica che parta dalla forza, senza negare che veniamo ferite dal patriarcato, dal capitalismo, dal razzismo. Ma riconoscere che ci organizziamo non perché siamo vittime impotenti che chiedono protezione, ma perché siamo soggetti potenti che vogliono trasformare il mondo.
Non stiamo negando che la lotta nasca da condizioni di oppressione, ma sosteniamo che la risposta a quell’oppressione non sia il lamento ma l’azione trasformativa. Stiamo dicendo che ci organizziamo non per essere riconosciute come vittime, ma per essere soggetti di cambiamento.
Questa distinzione è cruciale per capire gli attacchi, anche in forme diverse, fatti ai movimenti dopo una mobilitazione, un’azione, un blocco, uno sciopero. Quando viene descritta come ”violenta”, ”prepotente”, proprio nel momento in cui dimostra la propria forza collettiva, assistiamo precisamente al tentativo di riportarla dentro la politica del trauma. Il messaggio implicito è: dovete tornare a essere vittime che chiedono protezione, non soggetti che costruiscono potere autonomo.
Il femminismo come gestione delle emozioni
In un momento storico in cui la gestione delle emozioni diventa un investimento capitalistico fondamentale — dai social network alle piattaforme digitali — anche le pratiche femministe possono essere assorbite in questa logica. Il controllo e la gestione delle emozioni rappresentano oggi un terreno di guerra e conflitto cruciale, non solo nello spazio sociale ma anche nella special warfare, dove strategie psicologiche e manipolazione dei comportamenti diventano strumenti di dominio, controllo e profitto.
Catherine Rottenberg definisce la forma contemporanea più evidente del femminismo liberale con una formula lapidaria: l’auto-ottimizzazione sostituisce la lotta collettiva.
Invece di costruire spazi collettivi per affrontare strutture di potere, l’obiettivo diventa far sentire tuttǝ a proprio agio, secondo un universalismo astratto. Invece di praticare autodifesa contro chi agisce violenza, ci si concentra sul lavorare sulla propria aggressività percepita.
Chi mette in discussione questa ”felicità”, chi insiste che il problema sia strutturale e non emotivo, viene automaticamente definito come problema stesso.
Rottenberg mostra anche come il neoliberismo privatizzi il trauma. Invece di riconoscere che viviamo in una società patriarcale che produce violenza sistemica, il trauma viene estratto dalla dimensione collettiva e trasformato in prova individuale: si misura se la singola persona ha “diritto” alla propria reazione in base alla quantità di dolore soggettivo. Questo meccanismo non solo è violento per chi è costretta a esporre ripetutamente la propria vulnerabilità, ma depoliticizza completamente la questione: non si tratta più di cambiare le condizioni che producono violenza, ma di stabilire chi è abbastanza traumatizzata da avere giustificazione per reagire.
Questa logica assume una forma ancora più netta in contesti di violenza strutturale e guerra. In particolare, con la guerra in Palestina e l’aggressione contro Gaza, la gestione delle emozioni e la privatizzazione del trauma diventano strumenti di controllo ideologico e mediatico.
Samah Jabr, psichiatra palestinese impegnata da anni nella cura delle ferite psicologiche causate dall’occupazione e dalla guerra, denuncia come le sofferenze collettive vengano trattate come problemi individuali, come ”carico emotivo” da gestire privatamente, piuttosto che come esito di un oppressione sistemica che chiede giustizia. A chi sopravvive, chi resiste, viene chiesto di focalizzarsi su «come sopravvivere psicologicamente» piuttosto che su come far valere diritti, denunciare crimini o organizzare la resistenza. In questo modo la guerra non è solo militare: è anche psicologica, mediatica, e culturale.
Il femminismo neoliberale — assorbendo questa logica — rischia di divenire parte di quell’apparato: non più spazio di ribellione, ma meccanismo di adattamento individuale, in cui la cura delle emozioni sostituisce la trasformazione delle relazioni, la solidarietà viene privatizzata, la resistenza diventa therapy, la rabbia viene normalizzata o stigmatizzata e il conflitto politico si trasforma in questione di ”benessere personale”.
Feminist killijoy : la criminalizzazione di chi nomina il problema.
Sara Ahmed ha analizzato come le istituzioni trasformino chi denuncia violenza o ingiustizia nel vero problema. La feminist killjoy, la ”guastafeste femminista”, è colei che, nominando la violenza, diventa responsabile del malessere che produce. Ahmed formula chiaramente questa dinamica: la killjoy viene incolpata per il problema che espone (Ahmed, 2017, Living a Feminist Life).
Questa dinamica è strutturale alle istituzioni, ma si riproduce anche all’interno dei movimenti. Chi contesta figure di potere diventa il problema, non chi detiene quel potere; chi allontana persone violente diventa il problema, non chi agisce violenza; chi nomina privilegi diventa il problema, non chi li esercita; chi difende spazi di lotta diventa il problema, non chi vuole eliminarli. Questa operazione protegge il patriarcato, spostando il focus dal problema sistemico a chi lo nomina.

Categorie apparentemente descrittive — aggressiva, violenta, prepotente, muscolare — non descrivono semplicemente comportamenti, ma delegittimano chi disturba l’ordine costituito. La donna definita ”aggressiva” non è semplicemente arrabbiata; è una donna che rifiuta il proprio posizionamento subordinato
Quando spazi femministi vengono descritti come ”muscolari” per aver contestato il potere, si costruisce una categoria che rende impensabile la legittimità della contestazione femminista.
La killjoy sceglie consapevolmente di disturbare, accettando le conseguenze della sua decisione politica. Nomina la violenza, sfida il privilegio, denuncia le strutture oppressive: e sa che questa azione la renderà oggetto di stigmatizzazione, mentre il problema reale prova a celarsi, restare invisibile e intatto.
Il transfemminismo come brand: la performance della liberazione
Negli ultimi anni il transfemminismo (ma non solo) sta diventato merce che circola. Questa sussunzione ha conseguenze profonde: la liberazione diventa stile di vita, la lotta si riduce a estetica, la politica a consumo. Nel contesto dei movimenti, questa dinamica si manifesta quando nomi, slogan e linguaggi nati da lotte materiali vengono estratti dal loro contesto e usati come brand per guadagnare visibilità (nel migliore dei casi).
L’uso dei social media, l’esposizione pubblica, la costruzione di narrazioni che cercano approvazione e like mostra perfettamente come funzioni il transfemminismo-brand: ciò che conta non è la trasformazione delle condizioni materiali ma la performance pubblica.
L’attenzione si sposta dall’autodifesa collettiva, dalla cura, dalla costruzione di spazi di lotta, alla costruzione di immagini, approvazioni, like, visibilità sui social media.
Non importa che le mobilitazioni siano potenti. Non importa che decine di persone costruiscano quotidianamente pratiche trasformative. Ciò che importa è guadagnare capitale simbolico da spendersi individualmente.
Chi decide cosa è “vero femminismo”?
La critica postcoloniale e transnazionale ci insegna che l’universalizzazione è sempre un’operazione di potere. Quando il femminismo decide quali lotte sono legittime e quali no, sta esercitando dominio epistemico.
Le pratiche conflittuali, l’autodifesa esplicita, il radicamento in spazi di lotta materiali vengono dichiarate non-femministe o troppo aggressive perché non corrispondono al modello universale imposto dall’alto, un modello che funziona solo per chi non deve praticare autodifesa quotidianamente per sopravvivere. Le teoriche postcoloniali ci ricordano che ogni lotta è situata in condizioni materiali specifiche e il femminismo e il transfemminismo non possono essere astratti dal contesto in cui operano.
La nemicità tra Donne come Dispositivo Patriarcale
Una delle lezioni più dolorose del femminismo curdo e del transfemminismo radicale è questa: il patriarcato non ha bisogno di agire direttamente quando può far sì che donne e soggettività dissidenti si distruggano tra loro. L’uso del call-out per delegittimare invece che per nominare violenza, l’esposizione pubblica dopo grandi mobilitazioni, la mobilitazione di contatti istituzionali contro spazi autonomi, la delazione mascherata da denuncia, tutto questo non sono semplicemente errori o incomprensioni. Sono la manifestazione di come il patriarcato operi attraverso linguaggi femministi svuotati.
Le compagne curde ci insegnano che l’uccisione del maschio dominante è una sfida che riguarda anche e soprattutto le donne.
Ogni volta che assistiamo a dinamiche di delegittimazione interna ai movimenti, dobbiamo porci una domanda che non possiamo evitare: a chi giova? Non a chi viene esposta pubblicamente. Non agli spazi autonomi messi a rischio. Non al movimento transfemminista Non alle lotte contro precarietà e patriarcato.
Giova alle questure. Giova alle istituzioni. Giova a chi vuole che le mobilitazioni vengano cancellate dalla memoria collettiva. Giova, in definitiva, esattamente a quelle strutture di potere che i movimenti dovrebbero attaccare.
La critica per cambiare, la delazione per delegittimare
La critica e l’autocritica sono strumenti che possono favorire la crescita di un movimento e di un’organizzazione se utilizzati su degli obiettivi e dei valori comuni. La prima cosa di cui essere consapevoli, come compagnə, è che il sistema ha un profondo impatto su di noi e ci plasma da quando siamo natə. Mettersi in discussione, partire da sé, senza avere questo ben chiaro, produce solo individualismi e manipolazioni sempre più sofisticate. Se non siamo consapevoli delle nostre debolezze e se decidiamo di non affrontarle, queste saranno usate contro di noi e contro i contesti in cui viviamo. La nostra relazione di coppia, le nostre relazioni affettive e sessuali, le nostre amicizie, le nostre famiglie, i nostri desideri, i nostri collettivi e sindacati sono dei campi di lotta e trasformazione.
La critica non ha come obiettivo ferire o punire una persona che sbaglia ma fargli notare lo sbaglio e aiutarla ad affrontare il dolore del cambiamento.
L’autocritica non è una vocalizzazione di scuse autoassolutorie ma una sfida alla propria fragilità e alla propria vergogna. La vergogna è comune alle esperienze umane di errore e di contraddizione, nasconderla in false scuse non trasforma nulla.
Quando la vergogna si accompagna allo stigma, diventa un tarlo che rode la fiducia collettiva nella trasformazione. Affrontarla e renderla esempio di forza e trasformazione è l’obiettivo dell’autocritica.
Chi invece usa le fragilità, gli stigmi, i luoghi comuni e le paure per mettere pubblicamente in ridicolo, isolare e delegittimare (spesso con interpretazioni dei fatti frutto della propria cattiva coscienza) sta facendo un bel servizio alla controparte e alle forze reazionarie tutte.
In questa fase storica, senza essere ingenuǝ, qualcunǝ lo fa in maniera incosciente e nichilista, qualcunǝ in maniera cosciente con il chiaro intento di offrire un servizio prezioso a chi vorrebbe annientare le nostre lotte, in un momento delicato per gli equilibri politici globali in cui, come movimenti, potremmo rappresentare un ostacolo al baratro.
Contro il binarismo vittoria/sconfitta
Una delle operazioni più insidiose del liberalismo è l’abitudine all’arretramento presentato come conquista, unita a una visione binaria che riduce la politica a vittorie o sconfitte immediate. Ci viene insegnato a negoziare continuamente al ribasso, ad accettare spazi sempre più ristretti di azione “consentita”, mascherando questa progressiva neutralizzazione come maturità politica. Allo stesso tempo, ci viene imposto un metro di valutazione che riconosce solo risultati immediati e misurabili: o hai vinto o hai perso, senza sfumature.
Il femminismo liberale ha un ruolo fondamentale in questa teorizzazione. Il mantra del ”se stai buona le cose vanno meglio, se ti arrabbi rischi di peggiorarle”, che in ogni contesto permea e prova a distruggere qualsiasi tentativo di insubordinazione, ha negli ambienti del femminismo bianco privilegiato il suo terreno più fertile, se non forse originario. Il ricatto sulla propria ribellione si è costruito, nel caso delle donne, in millenni di dominio patriarcale: per eccellenza, le donne sono quelle che pensano al bene della famiglia, dei figli, a tenere uniti i rapporti, annullando così qualsiasi velleità di autodeterminazione. L’imperativo a stare buone ed essere disponibili e accoglienti ha messo radici all’interno dello stesso movimento femminista: anche qui, più che in qualsiasi altro contesto, donne che hanno tutto, che non rischiano niente, dicono a chi lotta ogni giorno per la propria esistenza ”di stare buonǝ”, che altrimenti le cose vanno solo peggio.
Audre Lorde ci ha insegnato che non si può smantellare la casa del padrone usando i suoi strumenti: se accettiamo acriticamente sia i confini che il potere ci impone, sia i suoi valori e la sua etica nella misurazione di un successo, stiamo perdendo su due fronti.
La libertà che ci viene offerta è quella che Silvia Federici identifica come tipica del capitalismo: una libertà formale che maschera nuove forme di controllo, misurata con parametri che ci tengono sempre dentro il recinto, in cui ti vengono offerte scelte, ma solo quelle compatibili e previste.
Questo impoverisce drammaticamente la nostra capacità di leggere e immaginare, semplificando e frammentando proprio per impedirci di costruire movimenti che durino abbastanza da trasformare veramente le cose.
Ad esempio, l’abolizionismo carcerario rifiuta esplicitamente il binarismo: l’abolizione non è evento ma processo, non si tratta di aspettare il giorno in cui chiuderemo tutte le carceri, ma di costruire quotidianamente le condizioni materiali, sociali e politiche che le rendano progressivamente obsolete. Ogni passo contiene simultaneamente oppressione e resistenza, sconfitta strutturale e vittoria organizzativa, arretramento tattico e costruzione strategica.
Una visione processuale ci libera dalla tirannia del binarismo che produce frustrazione e burn-out. Ci permette di riconoscere che una mobilitazione potente seguita da un attacco feroce non è semplicemente una sconfitta, ma un processo che rivela contraddizioni e costruisce solidarietà. Ci permette di vedere che un movimento che resiste agli attacchi senza ”vincere” nel senso immediato sta costruendo qualcosa di più profondo della vittoria tattica: sta costruendo capacità di resistenza collettiva.
Soprattutto, ci permette di valutare le nostre lotte in ciò che costruiscono nella complessità del reale: lǝ compagnǝ che si radicalizzano, le reti che si formano, le analisi che si approfondiscono, le pratiche che si diffondono, le contraddizioni che si rendono visibili, il moltiplicarsi di resistenze autonome ecc.

Il transfemminismo è la nostra forza
Quando parliamo di transfemminismo spesso usiamo parole e concetti legati al fluire dell’acqua: ondate, movimenti carsici, marea.
L’acqua, fragile in ogni singola goccia, diventa una forza inarrestabile quando scorre unita: è nel legame tra le sue molecole e nella capacità di integrare tutto ciò che incontra, anche ciò che è diverso, che trasforma la delicatezza in potenza, scavando montagne, plasmando il mondo e generando la vita.
Sono aspetti diversi e complementari della forza che da millenni il sistema patriarcale, associato a quello capitalista, razzista ed ecocida, cerca di invisibilizzare ed eliminare.
Nonostante il corpo combattente delle donne abbia faticato a trovare un riconoscimento anche tra le femministe, come ci ricorda anche Alessandra Chiricosta (2019), tuttə noi abbiamo avuto esperienza della forza che esso ha.
”Quando agita da un corpo teoricamente inadatto al suo esercizio, secondo le regole del disciplinamento culturale che sono state fatte emergere nei Movimenti precedenti, la forza combattente viene immediatamente etichettata come violenza e tacciata di emulare la peggior declinazione della virilità. La difficoltà di render conto di una differenza fra forza e violenza e la volontà dei movimenti di liberazione femminile di prendere le distanze dall’esercizio di quest’ultima ha spesso determinato ambiguità nel riconoscimento del valore delle pratiche combattenti femminili”.
Grazie al femminismo abbiamo potuto mettere tutte noi stesse dentro le lotte collettive, imparare a trasformare in forza tutte quelle esperienze che nell’attuale sistema sono punti in cui attaccarci: maternità, non maternità, famiglia, non famiglia, scelte sessuali, identità di genere…
Grazie al femminismo possiamo pensare di contestare i comportamenti svalutanti e umiliati di compagni e amici senza doverci rassegnare alla sopportazione. Abbiamo imparato ad accettare per trasformare. Abbiamo imparato a pensare il tempo in modo diverso, avere meno fretta di ottenere tutto e subito ma costruire in prospettiva.
In una sola parola forse abbiamo imparato che è possibile crescere e abbiamo restituito vita alle nostre lotte. Per questo le difenderemo con ancora più determinazione e sicurezza proprio perché anche l’autodifesa è sempre più uno strumento che vogliono cercare di portarci via.
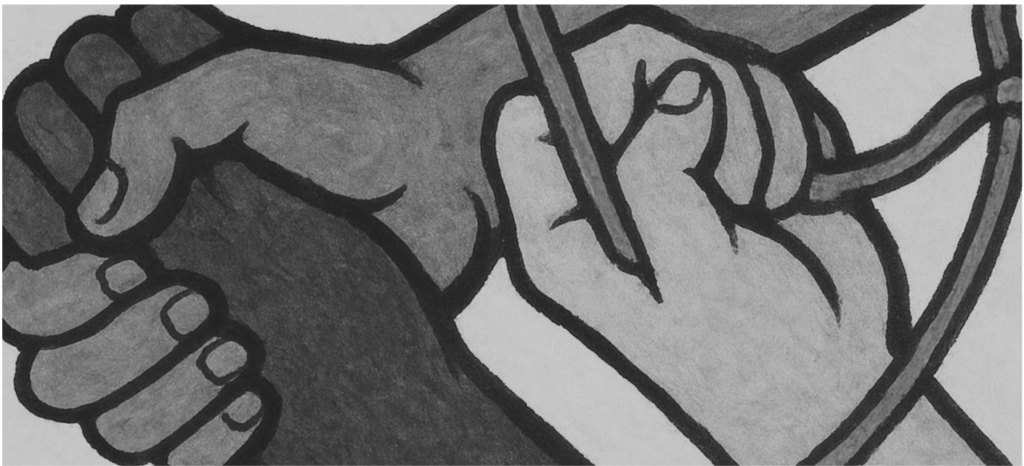
Difendere la possibilità della trasformazione
Forse la posta in gioco è proprio questa: riusciremo a difendere gli spazi dove la trasformazione è possibile? O permetteremo che vengano smantellati uno a uno, usando proprio il linguaggio che dovrebbe proteggerli? Non c’è neutralità possibile.
O stiamo accanto a chi lotta, anche quando disturba, anche quando è scomoda, anche quando non corrisponde al modello pulito del femminismo performativo, o diventiamo complici della neutralizzazione.
Il primo pezzo da far cadere è proprio quella versione di femminismo che protegge le istituzioni, difende chi agisce violenza, delegittima le lotte e si allinea con i poteri costituiti contro gli spazi autonomi. Questo non significa rifiutare ogni critica o trasformare i movimenti in fortezze assediate, ma sviluppare la capacità di distinguere la critica che trasforma dalla delegittimazione che neutralizza.
Questo documento non chiude la riflessione, la apre. Alcune domande restano urgenti e richiedono elaborazione collettiva continua.
Come distinguiamo la critica legittima dalla delegittimazione patriarcale quando entrambe usano linguaggi simili? Come proteggiamo il call-out come strumento di giustizia evitando che diventi arma di controllo sociale?
Come costruiamo spazi dove il conflitto è produttivo senza cadere né nel feticismo del safe space individuale né nella violenza che riproduce il patriarcato?
Come pratichiamo solidarietà tra donne e soggettività dissidenti senza cancellare le differenze di potere, privilegio e posizionamento? Come difendiamo chi viene esposta senza cadere in logiche identitarie che riproducono gerarchie? Come riconosciamo quando stiamo agendo privilegio anche quando ci sentiamo sinceramente nel giusto?
Queste domande non hanno risposte semplici. Ma le esperienze che abbiamo attraversato ci indicano una via: partire dalle condizioni materiali, dai rapporti di potere concreti, dalle lotte situate.
Solo così possiamo sperare di costruire un femminismo che sia davvero trasformativo, non performativo, non mercificato, non cooptato. Un femminismo che ci faccia sentire collettivamente potenti nella lotta, non isolate nella performance della nostra purezza politica. Un transfemminismo che ricordi sempre che la trasformazione è collettiva o non è, che la liberazione passa attraverso il conflitto con le strutture di potere e non attraverso la loro riproduzione mascherata da linguaggio progressista.
BIBLIOGRAFIA
NOTA ALLA BIBLIOGRAFIA. Più volte nel testo facciamo riferimento a femministe nere. Questo perché, prima di chiunque altro, le donne razzializzate e colonizzate si sono trovate a fronteggiare il femminismo bianco e privilegiato come una delle controparti, forse la più insidiosa e letale, da combattere. Davis in ”Donne, razza e classe” racconta in modo chiaro e sorprendente come un femminismo ”meno radicale” non sia soltanto meno efficace rispetto ad altre anime del movimento, ma diventi – come più volte abbiamo scritto nel testo – invisibilizzazione e egemonia su quali lotte sono legittime e come e da chi devono essere condotte. Il conflitto che le donne nere hanno vissuto e che sono state capaci di teorizzare illumina ora la nostra esperienza.
- Ahmed, S. (2017). Living a feminist life. Duke University Press. (trad. it. La vita femminista, Tamu, 2023).
- Chiricosta, A. (2024). Muoversi nello spazio senza chiedere permesso. Autodifesa e autocoscienza combattente femminista. Castelvecchi.
- Collins, P. H. (1990). Black feminist thought: Knowledge, consciousness, and the politics of empowerment. Routledge.
- Davis, A. Y. (1981).Women, race & class. Random House. (trad. it. Donne, razza e classe, Alegre, 2018).
- Federici, S. (2004). Caliban and the witch: Women, the body and primitive accumulation. Autonomedia.
- (trad. it. Calibano e la strega, Mimesis, 2015).
- Fraser, N. (2013). Fortunes of feminism: From state-managed capitalism to neoliberal crisis. Verso.
- hooks, b. (1984). Feminist theory: From margin to center. Routledge.
- hooks, b. (1994). Teaching to transgress: Education as the practice of freedom. Routledge. (trad. it.Insegnare a trasgredire, Meltemi, 2023).
- hooks, b. (2000). Feminism is for everybody: Passionate politics. South End Press. (trad. it. Il femminismo è per tutt , Tamu, 2021).
- Jabr, S. (2024). Il tempo del genocidio: Rendere testimonianza di un anno in Palestina. Sensibili alle Foglie.
- Lorde, A. (1984). Sister outsider: Essays and speeches. Crossing Press.
- Mohanty, C. T. (2003). Feminism without borders: Decolonizing theory, practicing solidarity. Duke University Press.
- Nair, Y. (2017). The trouble with trauma. Current Affairs. (articolo online).
- ottenberg, C. (2018). The rise of neoliberal feminism. Oxford University Press.
- Spivak, G. C. (1988). Can the subaltern speak? In C. Nelson & L. Grossberg (Eds.), Marxism and the interpretation of culture (pp. 271–313). University of Illinois Press.

Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.
autodifesaDISCIPLINAMENTOFEMMINISMO DECOLONIALEtransfemminismo


















