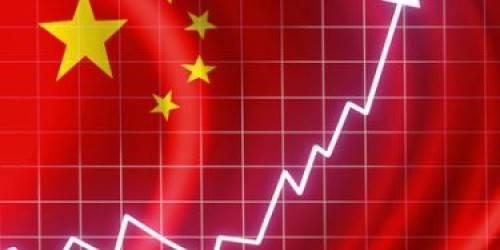
Finanza, lotte, scontri di potere. La Cina e una complicata transizione
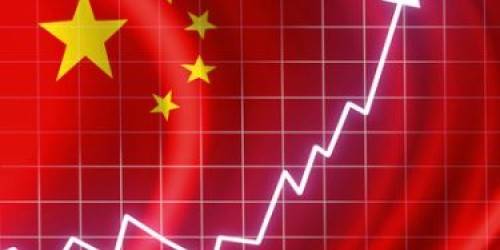
Una serie di domande a cui vogliamo provare a dare una – per quanto breve – risposta nel primo di diversi scritti che vogliono però anche ragionare su come le conseguenze degli immani movimenti migratori interni e le lotte sui luoghi di lavoro abbiano avuto un ruolo nel forzare trasformazioni socioeconomiche che sono necessarie alla Cina proprio per evitare lo scenario che nell’articolo tratto da Internazionale viene già dato per evidente. Apriamo così una serie di riflessioni e di analisi sulla questione cinese alla luce globale, consapevoli dell’importanza che questa vicenda avrà nel determinare le coordinate mondiali del prossimo futuro e quindi anche le coordinate nel quale situare il nostro agire politico.
Indici di borsa in picchiata, panico tra gli investitori, preludi di una nuova devastante crisi economica globale: giornali e analisti si sono scatenati nel raccontare – spesso male informati – quanto sta avvenendo in queste settimane nelle sfere della finanza cinese. Ma siamo davvero sull’orlo della catastrofe? E soprattutto, questa catastrofe sarebbe tale per chi? Uno degli assunti di chi conosce più in profondità la Cina contemporanea è che le turbolenze in atto in ambito finanziario riflettano dei processi di transizione interni all’economia del paese.
Lo spostamento da un modello basato sull’export ad uno incentrato sulla prevalenza dei consumi interni è infatti il grande obiettivo della Cina del XXI secolo aspirante potenza egemone mondiale, un processo pluridecennale che si deve necessariamente accompagnare a delle modifiche strutturali del sistema economico (e forse anche politico..) non facili da effettuare in breve tempo e perciò vittima di possibili turbolenze e difficoltà causate dalle condizioni congiunturali e dai rapporti di forza locali e globali.
Uno dei temi più discussi riguarda la finanza in relazione soprattutto al tema della moneta. Come asserito però da Jurgen Conrad (economista capo per la Cina della Asian Development Bank) nell’intervista raccolta da China Files non è affatto vero che l’obiettivo, o quantomeno che il solo obiettivo, della Cina con questa mossa fosse una svalutazione competitiva per rilanciare il suo export:
“Con la decisione dell’11 agosto di riformare il meccanismo di fissaggio del RMB, l’obiettivo principale della Banca Centrale Cinese (PBoC) è di determinare sempre più il valore della propria valuta attraverso domanda e offerta, non di indebolirla. La Cina vuole che la sua divisa entri nel paniere che costituisce i Diritti Speciali di Prelievo [l’unità di conto utilizzata dal Fondo Monetario Internazionale che è composta dal valore medio tra diverse monete nazionali, ndr di China Files] e le forze di mercato devono svolgere un ruolo sempre maggiore.“
Si tratta quindi di un gioco di potere per detenere le chiavi della finanza globale, sulla stessa via di quelli che hanno portato alla creazione di istituzioni finanziarie internazionali come la AIIB in passato e che sottendono allo scontro tra progetti di integrazione regionale nell’area del Pacifico tra quelli a trazione statunitense e quelli a trazione cinese. La mossa della Banca Centrale Cinese ha colpito al cuore gli USA che stavano per procedere al rialzo dei tassi di interesse per attirare nuovi capitali per finanziare la propria possibilità di deficit. Tra l’altro la fluttuazione più su parametri di mercato dello yuan era richiesta proprio dell’FMI, che di stanza sta a Washington e non certo a Pechino..
Quello che sfugge a chi è sorpreso o vede come clamorosamente problematico il crollo del tasso di crescita cinese non si rende conto di come questo abbassamento sia tutt’altro che una novità per i decisori politici di Pechino. Da tempo ormai il cosiddetto “new normal” (un tasso di crescita intorno al 7%) è lo standard ritenuto adeguato dalla dirigenza di Zhongnanai per valutare la positività della propria economia.
La realizzazione ordinata del nuovo modello di sviluppo ovviamente non è liscia, ma il crollo dei dati dell’esportazione è un dato assolutamente previsto dalla dirigenza cinese, interessata ad uscire, anche per accompagnare le sue pretese egemoniche globali, dalla condizione di paese di esportazione. Il calo della produzione manifatturiera e industriale in generale è derivato più che dalla crisi cinese da una concorrenza soprattutto proveniente dal sud est asiatico e dall’Africa nella produzione manifatturiera che era nota da tempo. Una concorrenza che si è determinata vincente soprattutto a causa delle vittorie dei cicli di lotta che negli ultimi 30 anni hanno accompagnato la crescita cinese ponendo le basi per la sua trasformazione.
La spinta migratoria verso le realtà urbane ha portato con sé prima il miracolo economico delle grandi fabbriche, ma in seguito anche la nascita di una coscienza di sé da parte soprattutto della seconda e della terza generazione di nonmingong (contadini migranti nelle fabbriche delle aree urbane), di un sé orientato ad una vita migliore di quella dei loro padri e caratterizzata da un maggior consumo e un miglior stile di vita che neanche la più dura repressione ha potuto cancellare. Queste volontà di vita migliore si sono realizzate in migliaia e migliaia di “incidenti di massa” (come li chiama il governo cinese) capaci di innalzare vertiginosamente i salari medi rendendo il lavoratore cinese sempre meno appetibile per le grandi aziende multinazionali, in una dinamica che ricalca quanto descritto da Beverly Silver.
In più c’è la questione prettamente politica, che vede uno scontro in atto sempre più forte all’interno del Partito. Questo, istituzione tutt’altro che monolitica ( ma del resto, come potrebbe esserlo un’istituzione di 90 milioni di iscritti?) è composto al suo interno da numerosi correnti e interessi, ha visto sin dalla presa del potere di Xi Jinping un tentativo continuo da parte del nuovo Presidente di accentrare a sé le leve del comando, sia creando nuove istituzioni ad hoc (come la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e le Riforme) sia lanciando campagne (più di tutte quella anti-corruzione) che permettessero di fare fuori gli elementi più ostili ravvivando intanto il sentito populistico della lotta ai “traditori del popolo” di impronta maoista. Sarà proprio la capacità dell’attuale leadership di fare fuori gli impedimenti politici alla propria strategia il nodo da sciogliere secondo diversi commentatori come ad esempio Stephen Roach.
E’ recente la polemica aperta ad esempio dall’editoriale del Quotidiano del Popolo nel quale si mette in guardia alcuni ex esponenti del Partito (qui il riferimento è a Jiang Zemin) dal continuare a voler indirizzare alcune scelte economiche e politiche. In particolare qui il riferimento è alla questione delle imprese di Stato, fiore all’occhiello del periodo maoista-denghista ma ora monoliti che bloccano lo sviluppo della “libera concorrenza” (per quanto questo termine di fatto non abbia senso effettivo nel capitalismo) nel paese. Non è un caso che la Commissione per la Disciplina del Partito, guidata da Wang Qishan, abbia avuto tra le sue più influenti vittime Zhou Yongkang, ex-zar della sicurezza, membro del Politburo e a capo di una fortissima lobby in ambito energetico: la decisione di Xi di spingere ulteriormente verso la strada della liberalizzazione economica sul modello occidentale implica lo scontro per il controllo delle grandi aziende (SOE) che tuttora sono le più importanti nell’economia del paese e questa è anche una delle principali forze che determinano le turbolenze in esame.
Il problema è anche ed essenzialmente di carattere demografico: non a caso in Cina si registra sempre in maniera maggiore una “labour shortage” che è stata tamponata negli ultimi anni soprattutto grazie all’inserimento in maniera massiccia di giovani studenti nel processo produttivo (come descritto ad esempio da Pun Ngai in relazione alla Foxconn. Ma l’inserimento di questi studenti nel processo produttivo non permette ad essi di divenire consumatori, e quindi di fatto inceppa – o quantomeno non trova soluzione – al processo di spostamento verso i consumi di cui sopra.
E’ chiaro che se la struttura non si modifica, le conseguenze sono pesanti. Il calo della domanda globale, dovuto alla crisi passata e ai nuovi venti di questa che si agitano a prescindere dalla situazione cinese (vedi articolo su Usa qui), influisce pesantemente sull’economia cinese. Ma evitare una sua ristrutturazione, che non significa avvicinarla agli interessi delle fasce più deboli ma solo riconvertirla verso nuove strade di accumulazione e privatizzazione della ricchezza, avrebbe portato a rimandare il momento e a creare una crisi potenzialmente ben più devastante di quella dei subprime.
Da altre parti si parla di una Cina che necessariamente avrebbe bisogno di riforme di tipo keynesiano per ripartire. Il punto è che questo tipo di riforme è già iniziato, e la crisi economica se da un lato è senza dubbio un trasferimento di ricchezza dal basso verso l’alto (con conseguente crollo dei tanti piccoli risparmiatori cinesi e conseguente possibilità che questi si possano inalberare contro il governo), dall’altro lato la crisi implica anche una ridefinizione economica che sarà molto più incentrata sul mondo dei servizi, i quali hanno aumentato difatti la loro quota all’interno del PIL negli ultimi tempi: uno dei fattori di squilibrio più importanti dell’economia cinese infatti è l’incapacità di rompere quell’altissima propensione al risparmio che se da un lato ha fatto decollare la borsa dall’altro ha fatto ristagnare i consumi, con la crescita salvata solo dall’export.
In Cina investimenti per migliorare la qualità della vita, per sfruttare le energie rinnovabili, per la sanità, per il sistema pensionistico e dell’istruzione stanno già venendo portati avanti rappresentando non certo un’illuminazione del governo, bensì la comprensione che questi possono essere forieri di enormi opportunità di business. Shen Lan e Stephen Green hanno sottolineato che a beneficiare di un’ipotetica riforma dell’hukou potrebbero essere ad esempio i gruppi privati impegnati nel campo della sanità e dell’istruzione che potrebbero avere nuovi clienti. Ma se notate la resistenza e la difficoltà, i rischi di portare avanti queste riforme in paesi di 60 milioni di persone come il nostro, immaginatevi cosa voglia dire una riforma pensionistica per un paese di oltre un miliardo e duecento milioni con circa 20 regioni amministrative dalle differenziate tradizioni e modellazioni giuridiche…la transizione cinese sarà dunque un processo sicuramente difficile, duro, con turbolenze necessarie e dove il ruolo dei soggetti sociali potrà sempre più avere un ruolo per determinarne, anche in minima parte, la traiettoria. Ma al momento di una transizione si tratta, e non certo di un crollo verticale in arrivo..
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.




















