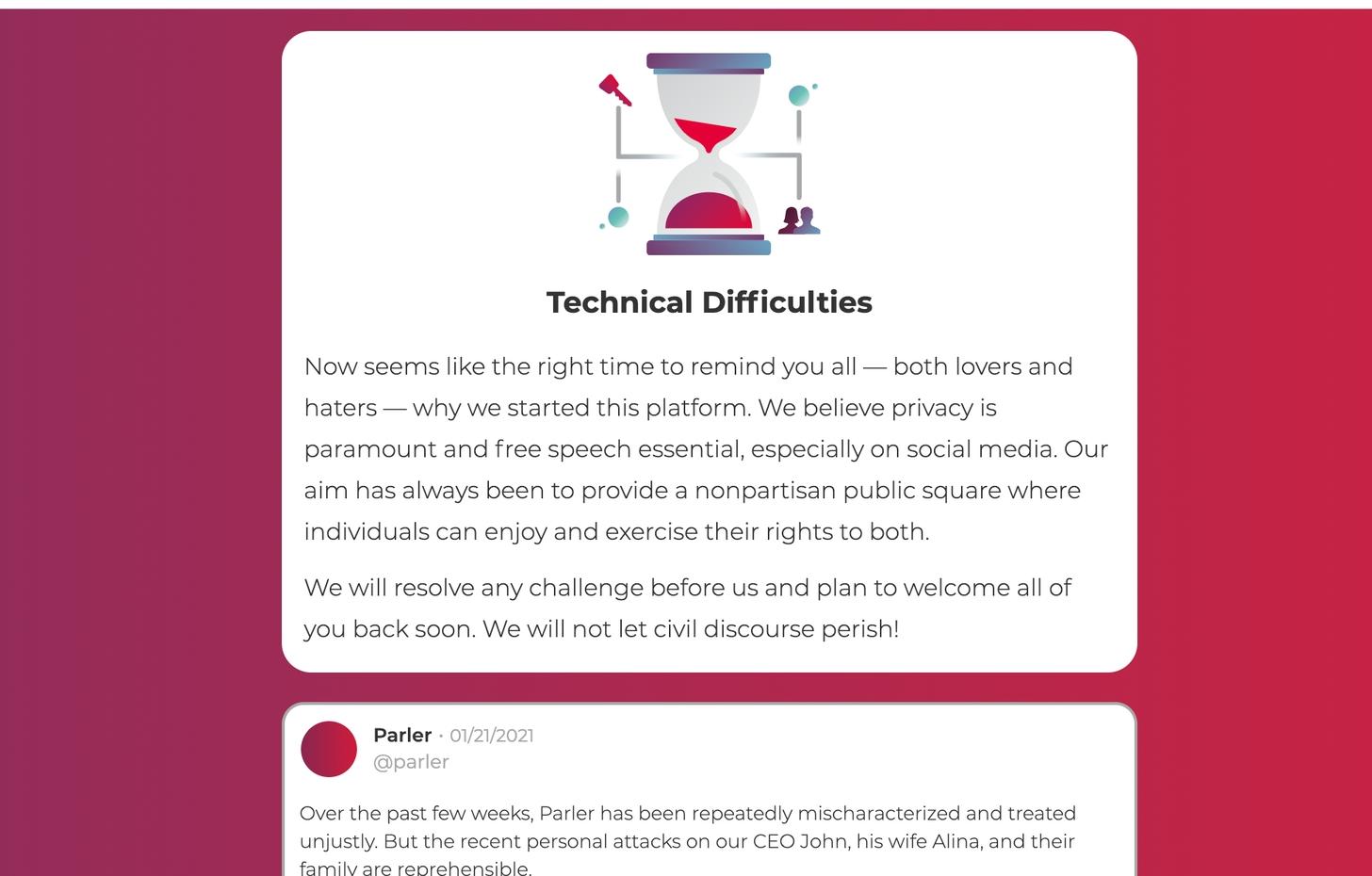Ad un anno dall’assalto di Capitol Hill pt 4. Di che materia era fatto il trumpismo?

Le puntate precedenti: parte 1 | parte 2 | parte 3
Ad otto anni dalla crisi del 2007 la scomposizione del quadro politico sembrava tutt’altro che rientrata. Alle primarie per le elezioni del 2016 i due grandi partiti si presentavano come estremamente frammentati. In campo democratico ad emergere erano principalmente due candidati: da un lato quello dell’establishment Hillary Clinton, appena uscita dall’esperienza da Segretaria di Stato sotto l’amministrazione Obama, dall’altro Bernie Sanders, democratico socialista, con un passato nei movimenti della New Left e Senatore del Vermont. Nel Partito Repubblicano la battaglia si giocava tra Ted Cruz, Senatore texano ed espressione del Tea Party e Donald Trump, magnate ed outsider.
Sia la campagna di Trump che quella di Sanders riceveranno un successo inatteso dalla maggior parte dei commentatori ed entrambi verranno definiti come leaders populisti.
Trump infine riuscirà a conquistare la candidatura repubblicana, mentre Sanders verrà sconfitto da Hillary Clinton.
Il populismo ha una lunga tradizione negli Stati Uniti. Mentre in Europa si tende a rintracciare le radici storiche del fenomeno nei narodniki russi di metà Ottocento, negli USA le origini vengono ricondotte al Greenback Party, e poi al Populist Party nato nel 1892. Entrambi questi movimenti erano significativamente strutturati nelle aree rurali, in particolar modo in quelle del sud e presentavano agende ampiamente redistributive, per le otto ore lavorative e contro l’accentramento di capitali nelle corporation.
Come si può notare esistono tanti punti di contatto tra il populismo storico ed il “trumpismo” quante discrasie evidenti (a partire dall’agenda politica). Eppure la definizione di “neopopulismo” per quanto riguarda la serie di fenomeni nel cui crogiuolo è nata la coalizione trumpiana pare piuttosto appropriata. Alcuni giornalisti e studiosi tendono a ridurre il fenomeno del populismo (vecchio e nuovo) ad un particolare stile di retorica politica anti-establishment: politicamente scorretta, animata dal mito dell’uomo solo al comando ed apparentemente disintermediata (con il prevalere di uno o più di questi elementi sugli altri a seconda che si tratti di neopopulismo di destra o di sinistra). Questo genere di definizione tende a rimuovere completamente le determinanti storiche che generano il riproporsi ciclico di simili fenomeni.
Il sociologo Wolfgang Streek, d’altra parte, propone un paradigma interpretativo basato su “Il 18 Brumaio di Luigi Bonaparte” di Marx per provare a comprendere l’ascesa (e la tenuta) di Trump. Il bonapartismo “è sorto […] con la classe capitalista troppo divisa, e la working class troppo disorganizzata, per istruire o informare il governo”: allo stesso modo il trumpismo sorge in un contesto di profonda crisi sociale, politica e delle istituzioni vigenti, in cui la borghesia è lacerata da conflitti interni (si pensi al conflitto tra le corporation tradizionali e quelle nuove legate al mondo dell’high tech o della green economy, oppure a quello tra l’agroindustria e le aziende agricole di piccola o media dimensione, o ancora tra le multinazionali e le economie di scala per citare solo alcuni esempi) e la working class è estremamente frammentata tra processi di impoverimento, de-integrazione ed esclusione sociale. “Trump ha vinto le elezioni presidenziali degli Stati Uniti con il sostegno di una classe disorganizzata in declino, i lavoratori industriali della middle America, che sono paragonabili a modo loro ai piccoli contadini di Marx della Francia della metà del diciottesimo secolo.”
Al di là dell’affascinante parallelo sono tre gli elementi di questa ipotesi che paiono particolarmente interessanti: 1 – il populismo, non solo come stile politico, ma anche come dinamica sociale determinata da particolari condizioni storiche, 2 – la relazione tra il sorgere del populismo ed il declino di alcuni settori sociali che rischiano la de-integrazione (o l’impoverimento) a causa della ristrutturazione dei sistema economico, 3 – la ristrutturazione che a sua volta fa sorgere contraddizioni tra gli interessi della borghesia.
Queste particolari condizioni, unite ad altre, permettono la nascita di un’alleanza interclassista. Ancora Streek suggerisce che l’adesione di una parte della working class alla coalizione trumpiana vada interpretata utilizzando la differenza weberiana tra classe e status.
“Le classi sono costituite dal mercato; i gruppi di status da un particolare stile di vita e una specifica pretesa di rispetto sociale. I gruppi di status sono comunità sociali locali; le classi diventano classi solo attraverso l’organizzazione.” Nei gruppi di status la nozione di classe svanisce per essere sostituita da altri cleverages: urbano contro rurale, immigrato contro “nativo” ecc… ecc… Marc Edelman ad esempio ha sottolineato che “come Ta-Nehisi Coates (2017) ha osservato ironicamente che nel 2016 “Trump ha riunito un’ampia coalizione bianca che andava da Joe il lavapiatti a Joe l’idraulico a Joe il banchiere” e — si potrebbe aggiungere, visto che ha ricevuto la maggioranza dei voti delle donne bianche – da Susie la cameriera a Susie il CEO.”
In questa specifica combinazione di elementi, ed in particolare nell’adesione di alcuni settori della working class al progetto trumpiano, sta la novità del ciclo neopopulista rispetto ai precedenti revival conservatori.
Ma quanto è stato determinante il consenso di una parte di working class nell’elezione di Trump? Di quale parte di working class si sta parlando? E, soprattutto, perchè è successo?
Paragrafo 6: Il ruolo della working class bianca nell’elezione di Trump
Stephen L. Morgan e Jiwon Lee nel loro “Trump Voters and The White Working Class” si pongono due domande per indagare il ruolo della working class bianca nell’elezione di Trump:
“1 Gli elettori di Obama nel 2012 erano una parte sostanziale degli elettori di Trump nel 2016 e, in caso affermativo, erano sproporzionatamente bianchi e membri della classe operaia? 2 Nel 2012 i non votanti idonei erano una parte sostanziale degli elettori di Trump nel 2016 e, in tal caso, erano sproporzionatamente bianchi e membri della classe operaia?”
Le conclusioni a cui giungono i due studiosi sono particolarmente interessanti: il 27,2% degli elettori di Obama della working class bianca nel 2016 hanno votato per Trump. In termini più generali il 28% degli elettori di Trump del 2016 erano tra coloro che hanno votato per Obama nel 2012 o, pur essendo idonei, non hanno votato. Allo stesso tempo gli elettori che sono passati da Romney a Clinton nel 2016, o che sono usciti dall’astensione per votare Clinton sono stati solo il 16%. Gli elettori che sono passati da Obama a Trump erano sproporzionalmente bianchi e working class, mentre quelli usciti dall’astensione per votare Trump erano sproporzionalmente bianchi. Inoltre, un’analisi complementare sugli areali geografici del voto mostra come le performance migliori di Trump – rispetto a quelle di Romney nel 2012 – si concentrino in particolare nelle aree in cui chi votava era maggiormente di working class bianca. Questa forte relazione si evidenzia anche nei sei stati che hanno determinato la vittoria di Trump.
Sembra dunque trovare conferma l’ipotesi secondo cui, nonostante l’elettorato trumpiano non sia stato formato in maniera maggioritaria da settori della working class, il comportamento elettorale di questi settori abbia avuto un ruolo determinante nelle elezioni.
Ma alcuni interrogativi rimangono aperti: come spiegare una tale transizione elettorale da Obama a Trump tra la working class bianca?
Per quanto sicuramente abbiano influito, la disillusione nei confronti del presidente afroamericano, così come la sfrenata campagna cripto-razzista contro di lui, non sembrano essere spiegazioni sufficienti per inquadrare questo trend elettorale. Si consideri che tendenzialmente si tratta di elettori che hanno scelto di riconfermare Obama al suo secondo mandato e che la sua popolarità, verso la fine del suo percorso presidenziale, era stimata in ascesa. Più convincente sembra l’ipotesi che la vittoria di Hillary Clinton alle primarie democratiche, considerata a tutti gli effetti come una figura dell’establishment, e la sua campagna elettorale fortemente centrista abbiano alienato ai democratici una parte significativa dell’elettorato working class in alcuni swing states in un continuum di forte polarizzazione. Ancora più importante, le posizioni protezionistiche di Trump – per la ricontrattazione degli accordi commerciali internazionali – il suo isolazionismo e la sua tematizzazione della lotta all’immigrazione come strumento per fare fronte alla competizione sui salari, hanno con tutta probabilità avuto efficacia nell’attirare il consenso di queste composizioni alla ricerca di “sicurezza sociale”, dopo la Grande Recessione del 2008. Malgrado il magnate abbia allo stesso tempo fatto campagna su alcune delle tipiche istanze del Partito Repubblicano (come ad esempio il taglio delle tasse o, quelle più proprie, della Christian Right) le sue argomentazioni contro la globalizzazione, per la re-localization e contro le elites finanziarie gli hanno permesso di rafforzare il consenso della base repubblicana e di unire a questo quello di una parte della working class bianca in sofferenza.
Paragrafo 7: Il “trumpismo” ed il rural – urban divide
Le mappe elettorali del 2016 e del 2020 presentavano persino ad occhio un’indiscutibile peculiarità. Mentre il voto democratico si concentrava nelle contee con una popolazione superiore ai cinquecentomila abitanti, quello ai repubblicani dilagava nelle contee meno abitate. Nel 2016 persino alcune tradizionali roccaforti conservatrici vicine a centri urbani, come l’Orange Country (della cui rilevanza per la nascita del Social Conservatorism si è accennato nel primo capitolo), o alcune importanti città del Texas hanno votato in maniera significativa per Hillary Clinton. “Al di fuori di queste contee urbane, è vero il contrario. Nelle contee con meno di 100.000 abitanti, che costituiscono l’80% delle contee del paese ma contengono solo il 20% circa della popolazione, 9 su 10 hanno votato più repubblicano rispetto al 2004.”
Ma la vittoria di Trump è stata consacrata dalle città e dalle contee rurali di medie dimensioni: gli Stati del Midwest, alcune contee della Rust Belt e dell’Ohio hanno determinato il successo dei repubblicani.
Come spiegare questa inversione?
L’antropologo Marc Eldeman ci propone l’ipotesi di alcune aree rurali degli Stati Uniti come “zone di sacrificio” del capitale. “Molti elettori di Trump erano ricchi suburbani motivati non direttamente dal disagio economico, ma dal razzismo, dall’odio per la regolamentazione del governo e dalla speranza di tagli alle tasse. Un altro importante settore, invece, era costituito da abitanti in mobilità decrescente di zone in cui il capitale ha distrutto le istituzioni che prima consentivano alle persone di appropriarsi della ricchezza che producevano e dove la previdenza sociale e la rete di sicurezza sociale — sempre tenui e dipendenti in modo significativo dal contratto dei lavoratori più abbienti con i datori di lavoro privati, sono sempre più a brandelli.” Eldeman amplia il concetto di “zone di sacrificio”: oltre l’aspetto puramente ambientale, mette in relazione l’estrattivismo con la devastazione sociale che esso genera. Per l’autore queste aree sono delle vere e proprie “colonie interne” dove: “Vengono sfruttate preziose risorse rurali insostituibili, comprese le popolazioni e le culture rurali, non a beneficio delle popolazioni rurali, ma per aumentare la ricchezza degli investitori aziendali.”
L’autore sottolinea inoltre come le “zone di sacrificio” dove il capitalismo scarica le sue esteriorità dannose non sono solo quelle a maggioranza bianca, ma anzi spesso le più brutali riguardano quartieri o territori abitati da minoranze, eppure le zone rurali sono segnate da una certa omogeneità dell’esperienza.
L’analisi di Eldeman ha il merito di interpretare il radicamento del neopopulismo nelle aree rurali non solo sulla base della deindustrializzazione, ma anche dell’attuale rapporto di capitale che vige in queste aree. Non spiega altresì i motivi per cui i settori di working class bianca che hanno aderito al progetto trumpiano si allineino ai claims repubblicani contro il Big Governament e le tasse, invece che pretendere una redistribuzione delle risorse.
Kathy Cramer nel suo “The Politics of Resentment” per provare a spiegare questo fenomeno usa il concetto di “Rural Consciousness”: un certo senso comune, una consapevolezza che è presente tra gli abitanti delle zone rurali. Depauperati da un’ingiustizia nella distribuzione delle risorse, hanno formato un’identità basata sulla contrapposizione con le città, contro le elites finanziarie e cosmopolite e contro quel proletariato urbano razzializzato, inteso come competitor nella distribuzione di queste risorse. Un’identità quindi che non si basa sulle divisioni di classe, ma piuttosto su quelle geografiche e di status, come si accennava nei precedenti paragrafi. Cramer sostiene che siano tre gli elementi alla base della “Rural Consciousness”: “(1) la convinzione che le aree rurali siano ignorate dai decisori, compresi i decisori politici, (2) la percezione che le aree rurali non ricevano la loro giusta quota di risorse e (3) la sensazione che le popolazioni rurali abbiano valori e stili di vita fondamentalmente distinti,che sono fraintesi e non rispettati dalla gente di città.”
Phil Neel motiva questo fenomeno alla luce della difficoltà che la working class delle aree rurali incontra nel costruire un proprio programma di classe autonomo (in maniera similare al proprio corrispondente urbano). Secondo l’autore nell’hinterland profondo la contrazione dell’output industriale (le contee in cui ha vinto Trump nel 2016 producono solo il 36% dell’output nazionale) e la conseguente diminuzione del reddito tassabile avrebbe dato vita a due dipendenze: da un lato quella riguardante il lavoro, in larga parte dipendente dalle agenzie federali in una parte consistente di queste zone; dall’altro quella riguardante l’esperienza dell’espropriazione, che avviene in particolare sulle rendite dei terreni e sui diritti di sfruttamento delle miniere che competono a quelle stesse agenzie.
Ad essere particolarmente colpiti da questa doppia dipendenza sarebbero i piccolo-borghesi delle aree rurali che, schiacciati da un lato dalla competizione dell’agroindustria e di altre corporation e dell’altro dal peso della tassazione, vivrebbero un processo di impoverimento relativo, nonostante rimangano gli unici detentori di capitale su base locale. L’esperienza dell’espropriazione è però un’esperienza comune, e in questa contraddizione i settori piccolo-borghesi hanno avuto campo libero nel proporre la narrazione delle politiche di status. Si tratta in sostanza di una richiesta di autonomia locale, su cui convergono gli interessi della piccola borghesia (che vuole poter accedere a dei cicli di accumulazione propria) e di una parte della working class (che vorrebbe riconquistare una parvenza di decisionalità sulle proprie vite). Ma come sottolinea lo studioso, l’autonomia locale è illusoria e dunque ecco sorgere il trumpismo come progetto su larga scala.
E’ proprio su questa piccola borghesia rurale in sofferenza che le nuove destre ed il “trumpismo” riusciranno a costruire il nucleo duro della propria base sociale.
E per quanto riguarda le zone rurali non dipendenti immediatamente dal governo federale? La serrata campagna negazionista di Trump nei confronti del cambiamento climatico insieme alla propaganda per il re-shoring può aiutare a comprendere il trend. I Democratici già da un ventennio avevano fatto propria la crescente sensibilità ambientale e Obama aveva più volte tentato di prendere provvedimenti rispetto alla questione del cambiamento climatico, ma una parte della base di blue collars del partito era impiegata in attività ad alto impatto. In un contesto di aspettative decrescenti con la tendenza alla delocalizzazione tutt’altro che rientrata, la paura di perdere il posto di lavoro può essere stata una leva con cui il neopopulismo è riuscito ad attecchire. Alcuni think thank conservatori, come quelli legati ai fratelli Koch, lavoravano a questo deragliamento da tempo. Inoltre, la tendenza ad individuare la questione del cambiamento climatico come un’istanza polarizzante anche all’interno della working class si era già vista all’opera in parte durante la sfida elettorale tra Bush ed Al Gore. Anche in questo caso si può ipotizzare uno slittamento, dove paradossalmente una parte della working class per “salvare” la propria identità operaia si allinea nella stessa coalizione con le corporation tradizionali, che vedono nella ristrutturazione dei modi di produzione e nel mercato globale un rischio per i loro profitti ed il loro primato poltico-economico.
I paradigmi della cosiddetta “working class narrative” e dell’ “urban – rural divide”, sono solo alcune delle proposte interpretative del successo elettorale di Trump del 2016. Alcuni autori ad esempio ritengono che la “working class narrative” sia fuorviante, dato che la maggioranza dei supporters di Trump era ed è tendenzialmente benestante. E’ incontestabile che la principale base elettorale dell’ex presidente sia rappresentata dalla composizione classica del Partito Repubblicano (anche se, come si è visto, alcune roccaforti storiche del partito sono andate anch’esse verso una trasformazione nel comportamento elettorale). Si è scelto, però, di concentrarsi sul comportamento di questo frammento di working class bianca perchè si ritiene che questo sia stato il vero elemento di novità del 2016, determinante per la vittoria di Trump e ancor di più – assieme all’astensione di alcuni settori sociali – per la sconfitta dei democratici.
Ricerche più recenti pongono a critica la “working class narrative” sottolineando come il ruolo della working class bianca nell’elezione di Trump rappresenti la punta di un fenomeno di più lunga durata (almeno dal 1992), e che tutto sommato per quanto sorprendenti i dati siano in linea con i trend elettorali del passato. Gli autori sottolineano come nonostante l’adesione del proletariato bianco al Partito Repubblicano sia cresciuta nel corso del tempo, in termini generali il comportamento di voto di questi settori sia soggetto ad una grande volatilità. Ciò fa pensare che il loro voto non sia ideologico o fidelizzato, ma cambi a seconda della fase e degli attori. Da queste considerazioni si potrebbe dedurre l’ipotesi di un deficit di rappresentanza e di un comportamento elettorale “tattico” che varia a seconda della proposta politica (tra quelle del circoscritto panorama statunitense) che sembra offrire maggiore garanzia per gli interessi di questi settori.
Altre interpretazioni pongono la questione dell’ “urban – rural divide” a fianco o in contrapposizione a quella dell’ “educational divide” che sottolinea come mediamente gli elettori di Trump siano meno scolarizzati di quelli del Partito Democratico, quindi tendenzialmente meno aperti mentalmente. Se è discutibile che di per sè il grado d’istruzione rappresenti o meno un fattore di apertura mentale (senza essere affiancato ad altre condizioni), il nodo della scolarizzazione è ampiamente riconducibile al quadro delle “zone di sacrificio” (a cui si accennava prima) ed ai progressivi disinvestimenti nelle zone rurali.
E’ evidente che entrambe queste narrazioni presentano tratti di verità, ma non bisogna cadere nelle trappole che nascondono. Ad esempio una rappresentazione netta del conflitto tra urbano e rurale nasconde le dinamiche di scala del capitale con cui i due contesti sono strettamente collegati. L’implicita assunzione di questo paradigma significa che non c’è alleanza possibile tra il proletariato delle metropoli e quello dell’hinterland nelle sue diverse accezioni. Accettare questo tipo di ipotesi da un punto di vista antagonista dunque vuol dire immaginare che di per sè possa nascere un conflitto su questo vettore che non abbia caratteristiche regressive, difficile da immaginare. D’altro canto però questa narrazione ha il merito di riproporre la necessità di considerare quanto sta al di fuori delle grandi metropoli come uno spazio politico, che, altrettanto privo di autonomia quanto quello cittadino, è un campo di contesa fondamentale. Tanto quanto l’insorgenza di movimenti sociali apertamente reazionari hanno ridefinito quello spazio politico, allo stesso modo l’emergere di conflitti di massa con caratteristiche di classe potrebbe ridefinirne la stratificazione ideologica, come parzialmente si è visto in alcune aree con BLM e si sta iniziando a vedere, in termini ancora embrionali con i cicli di scioperi nelle factory e nei magazzini dell’hinterland più prossimo, che è in grado di esercitare un rapporto di forza più significativo rispetto ai contesti rurali più estremi.
In questo capitolo si è operata dunque la scelta di concentrarsi su questo frammento dell’elettorato trumpiano, perchè determinante tanto nella narrazione politica, quanto nel rivelare l’effettiva divaricazione del “doppio movimento” di cui si parlava nella prima puntata, ma non si può spiegare la coesione della coalizione trumpiana senza sottolineare quanto il suo cuore sia stato il ceto medio bianco abbiente spaventato dalla crisi.

Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.