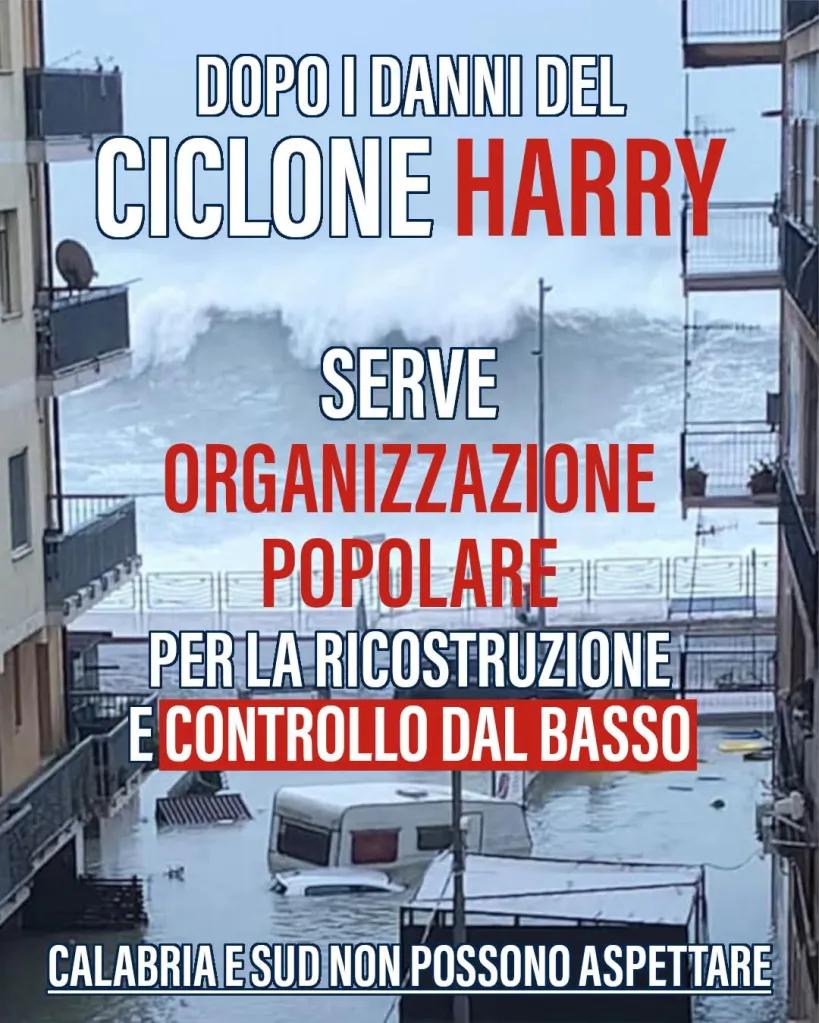Ecuador contro Texaco: la mano sporca che non vuole pagare

«Il caso Chevron-Texaco è un caso eccezionale. È un’impresa che ha speso quattrocento milioni di dollari in una campagna di diffamazione contro l’Ecuador. È un’impresa che sta facendo causa al Paese per la contaminazione da lei causata», l’accusa del vice ministro degli Esteri ecuadoriano, Leonardo Arizaga, è senza appello.
La Texaco è una impresa petrolifera che dal 1964 al 1992 ha lavorato nella foresta amazzonica ecuadoriana. A causa dell’utilizzo di una tecnologia obsoleta ed economica, in vece di metodi più sicuri ma costosi, ha versato nell’ambiente non meno di settantuno milioni di litri di residui petroliferi, e sessantaquattro milioni di greggio in due milioni di ettari di foresta. Per capire l’entità del danno Arizaga dice: «È diciannove volte peggiore dello spillover di Exxon Valdes in Alaska, e trenta volte maggiore del versamento del greggio nel Golfo del Messico», causato dalla British Petroleum, nel 2010.
Mentre loro, condannate, pagheranno. La Texaco condannata, non vuole pagare. Aveva le tecnologie necessarie per evitare la dispersione del petrolio, l’inquinamento e le conseguenti malattie per gli indigeni, ma ha utilizzato le più economiche, arrivando così a guadagni altissimi. L’articolo 46 del contratto di sfruttamento petrolifero, firmato con l’impresa statale del petrolio ecuadoriano, obbligava a sistemi di re-iniezione sicura dei rifiuti tossici nel sottosuolo. All’epoca, la Texaco Petroleum aveva brevettato tecnologie che avevano il minimo impatto sul territorio nelle operazioni di estrazione di idrocarburi, e già le usava negli Stati Uniti: non le ha mai usate in Ecuador.
(Sono più di mille le pozze di inquinamento da petrolio visibili nell’amazzonia. Ma spesso le piscine sono nascoste da uno strato di terra compatta. L’impatto è, in entrambi i casi, devastante perchè penetra in profondità.)
Dal 2001 la Texaco è di proprietà della Chevron, la seconda compagnia petrolifera statunitense, la settima nel mondo.
Arizaga, durante il colloquio con chi scrive, ha spiegato l’antefatto, la condanna della Texaco e le pressioni politiche cui è stato sottoposto poi l’Ecuador, con la messa in moto di una effettiva macchina del fango contro il suo Paese.
«Quando l’Ecuador ha scoperto che aveva il petrolio, non aveva il know how necessario per sfruttarlo. Dovevamo ospitare le compagnie internazionali del momento per vedere dov’era il petrolio, come estrarlo, come processarlo. Per questo contrattammo la Texaco. Il problema è che ha utilizzato tecniche che erano le più economiche possibili. Se andate oggi nell’Amazonilla, dopo venti anni dal ritiro dell’impresa ci sono ancora mille pozze, dove lavorò esclusivamente la Texaco».
Nel febbraio 2011, dopo diciannove anni di processi e rinvii tra New York e Nueva Loja, l’impresa è stata condannata a pagare nove miliardi cinquecentodieci milioni di dollari, con l’aggiunta delle pubbliche scuse. Nel caso non fossero state fatte, la multa si sarebbe duplicata. La Chevron si è rifiutata di scusarsi, e nel 2012 la condanna è salita a diciannove miliardi di dollari: il risarcimento più grande della storia in campo ambientale.
Ma la Chevron-Texaco non paga, anzi. Il giudizio è stato spostato, dopo i tre gradi, alla Corte costituzionale, e l’impresa ha iniziato una campagna milionaria di infangamento mediatico e politico dello Stato dell’Ecuador, con l’intento di addossargli le proprie responsabilità. Quattrocento milioni di dollari è la somma che la Chevron ha investito per screditare l’Ecuador davanti agli occhi del mondo. Otto imprese di lobbying sono incaricate di esercitare pressione politica ai membri del congresso degli Stati Uniti e del Dipartimento del Commercio per squalificare l’Ecuador e ledere i suoi interessi commerciali con gli Stati Uniti. Un esempio tra tutti è il mancato rinnovo delle preferenze tributarie concesse alle imprese esportatrici ecuadoriane. Il tutto compromettendo gli interessi economici dell’Ecuador, che ha negli Stati Uniti uno dei principali mercati d’esportazione, e creando non poche tensioni diplomatiche tra i due Paesi.
«Abbiamo avuto difficoltà nelle relazioni con gli Stati Uniti – spiega il vice ministro – qualche anno fa dichiarammo “persona non gradita” un ambasciatore americano e l’abbiamo espulso per il suo comportamento. Adesso vogliamo voltare pagina e instaurare una nuova relazione con questo Paese, basata sul rispetto reciproco. Ci sono dei temi che vogliamo riaffrontare, come il Consejo de commercio entre Ecuador y Estados Unidos. Ci interessa molto la riforma migratoria statunitense, abbiamo un milione di ecuadoriani negli Stati Uniti. Ci stiamo informando sul Facta, sul sistema di retribuzione tributaria».
La Texaco Petroleum lascia l’Ecuador nel 1992. Tra i suoi obblighi c’era quello di “rimedio ambientale”. L’anno successivo gli abitanti del Lago Agrio, nella provincia di Sucumbios, organizzano il Fronte di difesa dell’Amazzonia per denunciare i danni ambientali causati dall’azienda. Inizia la lite tra i privati cittadini e l’impresa. Il processo dura dieci anni presso la corte distrettuale di New York, mentre la Texaco insiste per lo spostamento dello stesso in Ecuador, avvenuto, poi, nel 2002. Arizaga continua: «In tutto questo processo lo Stato ecuadoriano non interviene, e l’impresa ha avuto modo di appellarsi al secondo grado e poi al terzo. Al momento si sta appellando alla Corte costituzionale, dove ha presentato ricorso nel dicembre del 2013».
«La causa era tra privati. Però, mentre si teneva questo processo, la Chevron-Texaco ha fatto capo alla corte dell’Aja, accusando l’Ecuador di non avere una giustizia trasparente, e che il processo era stato compromesso».
La lotta si divide su due fronti: quello privato tra l’impresa e i cittadini, dove gli ultimi hanno vinto, ma la Texaco non vuole pagare, e l’altro, che vede la Texaco chiamare in giudizio davanti al Tribunale internazionale lo Stato ecuadoriano.
Il Tribunale dell’Aja si dichiara parzialmente competente su due delle tre questioni sollevate dalla Chevron-Texaco. La competenza del Tribunale permanente internazionale si può esprimere sul trattato bilaterale tra Stati Uniti ed Ecuador del 1993, sull’Atto di liberazione del 1998, ma non sui danni ambientali e sull’attribuzione della colpa.
Uno dei capi d’accusa della Texaco contro l’Ecuador, infatti, fa riferimento all’Atto di nulla a pretendere che il presidente del governo di allora, Jamil Mahuad, ha firmato nel 1998, sollevando la TexPet da tutte le «responsabilità ambientali passate e future».
Il vice ministro Arizaga chiarisce: «I nostri rappresentati di Stato firmarono l’atto. Non sappiamo i motivi che hanno spinto il vecchio governo a farlo, stiamo indagando. Non avrebbero dovuto farlo».
Ovviamente, anche se il governo è cambiato, esiste continuità dello Stato, principio base del diritto internazionale. Lo Stato non può chiedere nulla alla Texaco, ma l’accordo non prevede che i singoli cittadini non possano presentare una denuncia. Di fatto, è stato il Fronte amazzonico a denunciare Chevron, e non il governo.
Ricardo Patiño, ministro egli Esteri, in un viaggio diplomatico di sensibilizzazione internazionale al problema, a Roma nel novembre 2013, ha affermato che lo Stato è accusato «di avere esercitato pressioni indebite sui giudici che hanno imposto il risarcimento alla Chevron, ma questo è falso. Quello che non viene detto è che i rappresentanti della Chevron si sono incontrati con quelli del vecchio governo dell’Ecuador, per cercare di screditarlo».
La Texaco, inoltre, giura di aver compiuto tutti i suoi obblighi di bonifica dell’ambiente. Ma non si espone sui metodi e le tecnologie utilizzate, che non erano adatti e non rispettavano gli accordi. A fine contratto la compagnia si è limitata a bonificare centosessantadue pozzi su duecentosessantaquattro. Molti altri sono stati scoperti dopo, e se ne scoprono sempre nuovi, perché l’impresa non ha mai dichiarato i luoghi delle trivellazioni. Alcune piscine sono state semplicemente coperte da uno strato di terra.
Nel suo tentativo di divincolarsi dalla giustizia, la TexPet scarica la colpa della contaminazione sull’azienda petrolifera nazionale. La Petrolecuador, che ha iniziato a lavorare il suolo dopo l’abbandono della Texaco, ha usato le tecnologie più avanzate nel rispetto del suo patrimonio forestale. L’estrazione di petrolio porta, immancabilmente, a una violazione dell’ambiente, ma lo Stato Ecuadoriano – come ha tenuto a precisare il vice ministro – tenta di mantenere questa intromissione sul territorio al minimo. «Ci sono testimoni, lavoratori, cittadini che hanno visto la contaminazione deliberata di Texaco in più di vent’anni».
Lo Stato ecuadoriano sta bonificando parte dei pozzi. Ma Arizaga spiega che alcuni sono in zone in cui ha estratto solo e unicamente la Texaco, ed è su queste zone che si basa la condanna del giudizio di Sucumbios. Questi pozzi rappresentano l’unica prova contro le accuse della compagnia statunitense. La portavoce del viceministro racconta quanto sia difficile operare nella zona interessata: «Gli abitanti dell’Amazonilla sono in perenne allerta. Ci chiedono, per favore, di non bonificare, di non toccare nulla, perché i pozzi sono prove della colpevolezza dell’impresa americana. Quello che facciamo è bonificare zone che non vanno a inficiare le prove per il processo. È un lavoro di precisione. Siccome la Texaco non ha dichiarato i pozzi, dobbiamo incrociare dati ed essere in perenne dialogo con i cittadini. La bonifica ambientale si può fare anche se necessita molto tempo e molti soldi». Si stima che per ogni barile di acqua contaminata alla Chevron costerebbe 32,25 dollari per la bonifica.
(L’acqua contaminata scaricata nel suolo senza alcun previo trattamento ha inquinato le falde acquifere, i fiumi, ha distrutto la fauna e la flora. Secondo uno studio del 1993, trenta milioni di pesci sono morti a causa delle esplosioni di dinamite lungo il corso dei fiumi.)
Altro nodo giuridico sono le quote di partecipazione. Il vice ministro spiega che la Texaco Petroleum Company, nei trent’anni di sfruttamento dell’Ecuador, era socio minoritario al 37,5 per cento in un’operazione congiunta con la ex Cepe, l’attuale Petrolecuador. Questo fattore, secondo Arizaga, non toglie la sua responsabilità dell’inquinamento, poiché l’impresa era l’unica responsabile dell’estrazione petrolifera fino al 1992, momento in cui è terminato l’investimento.
Di fronte al Tribunale dell’Aja, la Texaco ha denunciato lo Stato ecuadoriano perché non ha rispettato il trattato bilaterale degli investimenti tra il Paese e gli Stati Uniti, del 1993, documento firmato dai due Paesi e volto a proteggere gli investimenti. Questo nuovo trattato, però, è entrato in vigore nel 1997, cinque anni dopo l’uscita della Texaco dal Paese, e quattro anni dopo la denuncia da parte dei cittadini. Il trattato non ha valore retroattivo e non può essere utilizzato per impedire a singoli individui di perseguire un’azione legale. Il Tribunale si è dichiarato competente su questo punto, ordinando all’Ecuador di sospendere l’esecuzione della sentenza, cosa che non può fare perché anticostituzionale.
 (Le principali conseguenze per la salute degli indigeni sono le malattie della pelle e le deformazioni. Spesso i più colpiti sono i bambini.)
(Le principali conseguenze per la salute degli indigeni sono le malattie della pelle e le deformazioni. Spesso i più colpiti sono i bambini.)
Malformazioni, malattie della pelle, deformazioni cardiache, aborti spontanei, cancro: queste sono le conseguenze di trent’anni di Texaco nell’amazzonia nord-orientale. La portavoce di Arizaga spiega. «Prima non c’era il cancro, ma la popolazione era abbastanza ristretta. Adesso la popolazione è aumentata, ed è aumentato anche il tasso di incidenza del cancro, che è uguale ad altre zone dell’Ecuador, a volte maggiore. Purtroppo questo dato non è attendibile per creare un nesso causa-conseguenza. Invece, di sicura conseguenza della cattiva estrazione di idrocarburi, sono le malattie della pelle».
Fino ad oggi le popolazioni continuano a scoprire nuove pozze, coperte da cappe di terra, ma che ancora versano residui direttamente nelle falde di acqua dolce della zona. Gli indigeni dell’Amazzonia hanno sempre vissuto di acqua e del lavoro della terra. «Adesso sono costretti a bere acqua confezionata. Ma la gente continua a vivere lì. Chiede di non bonificare. Quando vai nell’Amazonilla e domandi “perché continuate a vivere qui?”, rispondono che quella è la loro terra, l’hanno comprata, hanno vissuto lì, hanno cresciuto i loro figli, e non vogliono andare via. Hanno perso parenti e amici per malattie dell’inquinamento. Vogliono giustizia», conclude la portavoce.
Di Roberta Benvenuto per Pop Off
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.