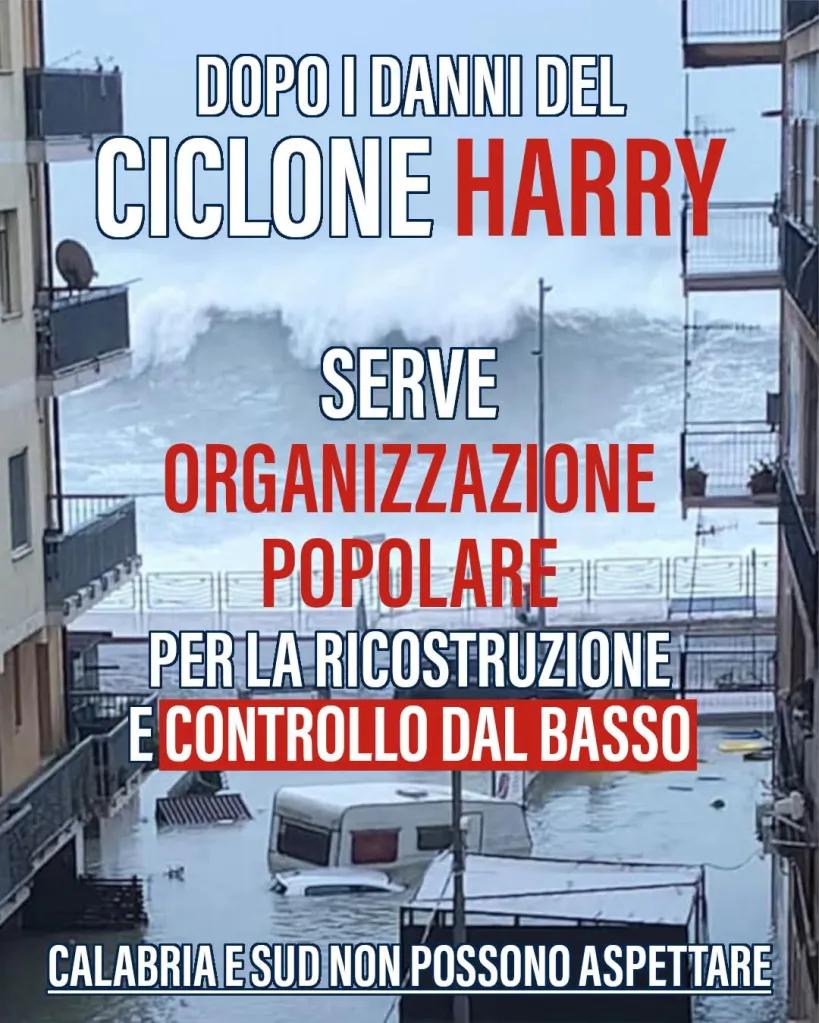Turismo, patrimonializzazione e lotte ambientali nel Mediterraneo
Recensione del libro di Elisa Tizzoni “Tra spiaggia, scoglio, fiume e collina. Turismo e ambiente nelle Cinque Terre e alla foce del fiume Magra nel secondo dopoguerra” (Unicopli, 2022).
di Daniele Valisena, da Ecologie Politiche del Presente
Foto di Chiara Arturo, Insulàrio, 2018
Cosa ci racconta la bellezza di un luogo? Come proteggere e conservare il patrimonio naturale, culturale e storico di una delle aree più intensamente toccate dal turismo? Qual è il ruolo di enti pubblici, associazioni, partiti e cittadini nel decidere del futuro di queste zone? Queste sono alcune delle domande a cui Elisa Tizzoni ha tentato di rispondere nel suo ultimo libro, uscito per l’editore Unicopli lo scorso autunno nella collana Percorsi internazionali di storia contemporanea.
Il paesaggio come “archivio a cielo aperto”
L’autrice, geografa di formazione, si muove nella sua ricerca tra storia ambientale e geografia storica seguendo la lezione delle géohistoire di Braudeliana memoria (ma ancora viva e presente in Italia in diverse declinazioni, dalla tradizione di geografia storica di Lucio Gambi agli studi di storia orale del paesaggio condotti da Antonio Canovi). “L’archivio a cielo aperto” che è il paesaggio è l’elemento centrale dell’indagine di Tizzoni, o meglio, i paesaggi, in particolare due: quello delle Cinque Terre e quello della foce del fiume Magra nella Liguria orientale, territorio di cui l’autrice è originaria. Le storia ambientale di questi territori, sviluppatisi negli ultimi due millenni in un inestricabile connubio tra attività umane ed elementi naturali, è raccontata attraverso un sapiente e attento lavoro d’archivio, che parte dall’epoca preromana e attraversa i secoli fino a giungere all’età contemporanea, costituendo una premessa storica ma anche teorica importante alla discussione delle questioni presenti: il paesaggio delle Cinque Terre e della bocca del Magra sono tanto il prodotto dell’orogenesi e dei successivi processi geologici e naturalistici quanto dell’attività umana, in particolare dell’agricoltura e dei processi di bonifica e modifica del territorio. Non c’è spazio per idee di wilderness e di conservazione del non-umano come luoghi separati dallo spazio delle persone come da tradizione anglo-americana. L’Italia è il paese del paesaggio, non della wilderness.
Questo dato è fondamentale in quanto nei successivi capitoli
Tizzoni si sofferma sui processi di modernizzazione e di patrimonializzazione del territorio e di come questi si siano intrecciati con lo sviluppo turistico, tema che ancora oggi è al centro dei processi di conservazione del territorio (le Cinque Terre sono territorio Unesco, mentre la foce del Magra è parte di un parco regionale), ma anche delle lotte politiche per il controllo dello sviluppo economico, della tutela e della patrimonializzazione di questi territori.
Tra patrimonializzazione ed héritigisation
Il tema della patrimonializzazione è centrale nel libro di Tizzoni, la quale ci spiega come il concetto, che nasce nel contesto della geografia culturale francese (héritigisation), sia stato centrale nell’accompagnare il processo di modernizzazione del Levante ligure, zona tradizionalmente meno sviluppata a livello turistico ed economico rispetto alla famosa Riviera di Ponente, già luogo di villeggiatura da parte di nobili e ricchi turisti inglesi e nordeuropei a fine Ottocento. Mentre la foce del fiume Magra aveva svolto un importante ruolo come porto in epoca romana, le Cinque Terre sono a lungo state un territorio di pescatori e agricoltori caratterizzato per la durezza della vita, dall’isolamento, e dal costante confronto tra comunità umane e l’asprezza del territorio, il cui prodotto è il caratteristico paesaggio terrazzato della zona. È stato il lavoro e la cura costante delle terrazze da parte delle comunità a costruire e a preservare il paesaggio fino all’epoca presente.
Quando negli anni Sessanta del Novecento il turismo ha iniziato ad affermarsi come la principale speranza di modernizzazione delle Cinque Terre, ma anche della foce del Magra, i processi di conservazione e patrimonializzazione del territorio hanno giocato un ruolo chiave nel produrre diverse narrazioni contrastanti con quella che vedeva nell’arrivo del cemento, delle strade asfaltate e del turismo di massa come l’unica via alla modernità per queste aree marginali della Liguria orientale.
È grazie a queste concezioni, prima trasposte in vincoli paesaggistici e limitazioni all’edificabilità, che le Cinque Terre sono riuscite nel 1997 a essere riconosciute come “paesaggio culturale patrimonio dell’umanità”. Questo processo però si è rivelato tutt’altro che semplice e molto più complesso della riduttiva visione dualistica tra progresso e conservazione lascerebbe intendere.
Quale futuro? La battaglia per la lottizzazione di Montemarcello
È in particolare attorno alla battaglia per la lottizzazione del promontorio di Montemarcello e dello sviluppo del litorale di Bocca di Magra che il ruolo dei comitati locali e di varie associazioni ambientaliste diviene centrale. Tra la fine degli anni Cinquanta del Novecento e per tutti gli anni Sessanta, in un Italia nel pieno del boom edilizio e della svendita del patrimonio costiero alla speculazione e ai privati, anche la foce del Magra sembrò vicina a divenire preda delle lobby del cemento e della turistificazione selvaggia. Senza voler rivelare troppo del libro, preme sottolineare come questa lotta per il futuro della foce del Magra e della piana rivierasca che si spinge fino alla Versilia in Toscana si sia giocata su vari livelli, in cui conservazione paesaggistica, modernizzazione, sviluppo economico ed edilizio sono stati al centro di dibattiti e discussioni il cui obiettivo era produrre narrazioni socio-ecologiche e socio-economiche in cui diversi futuri per il territorio – e diversi immaginari di abitabilità e modernità – si sono scontrati, anche in maniera aspra. Ecco che allora le contrapposizioni tra i futuri propugnati da partiti, classi sociali, culture, gruppi di potere e associazioni locali e di “nuovi residenti” toccano nel cuore i grandi dibattiti – e i grandi problemi e fallimenti storici, potremmo dire – che hanno caratterizzato l’ambientalismo italiano ma anche la politica parlamentare, opposizione compresa. Nella seconda parte del libro, emergono con forza temi quali la partecipazione dal basso da parte dei cittadini e dei residenti alle lotte per la tutela del territorio, ma anche il fallimento di queste pratiche quando queste non sono in grado di coinvolgere attivamente la più parte dei cittadini.
Le vicende narrate da Tizzoni spingono a interrogandoci sull’eredità presente di queste lotte, specialmente alla luce dei contemporanei problemi di turistificazione che affliggono tanto le grandi città d’arte quanto le piccole località balneari d’Italia.
Non basta opporsi alla turistificazione, ma servono anche nuovi immaginari e nuove pratiche partecipate e dal basso di cura dei territori. Un nuovo modo di abitare i luoghi nel quotidiano e un nuovo modo di pensare e valorizzare il “passato nel presente” di questi paesaggi in modo non consumistico e alternativo all’univocità sviluppista.
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.