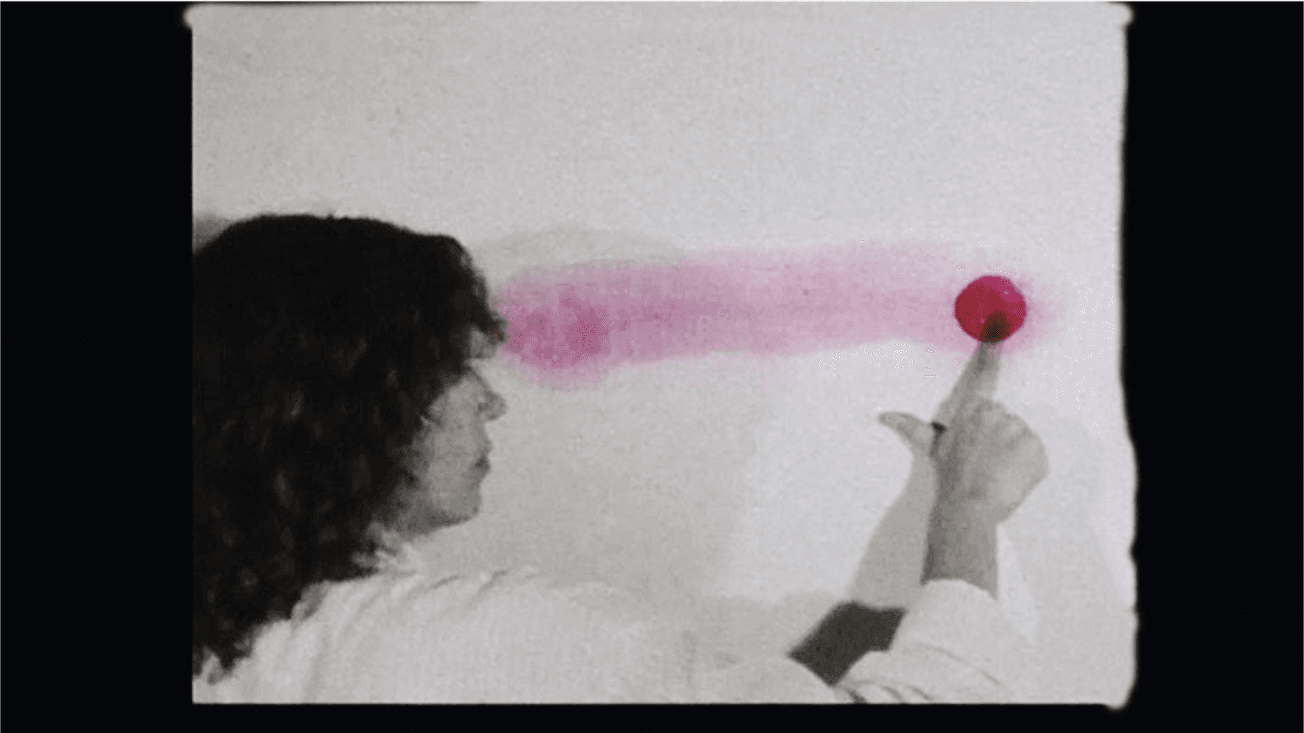Nell’anno III d.c.

di COLLETTIVO UNINOMADE
We don’t know where the economy is going to go
Ben Bernanke, audizione alla Commissione servizi finanziaridella Camera dei rappresentanti, 13 luglio 2011
Gerrard Winstanley, The True Levellers Standard Advanced, 26 aprile 1649
Intanto, la violenza del capitale finanziario si è dispiegata in Europa con devastante potenza distruttiva. Grecia, Portogallo, Italia: basta evocare i nomi di questi tre Paesi, in condizioni così diverse per quel che riguarda quelli che gli analisti chiamano i “fondamentali” dell’economia, per comprendere la dimensione generale della crisi e dell’attacco del capitale finanziario. La logica del saccheggio, come l’hanno definita in un bel libro Ugo Mattei e Laura Nader, è ben lungi dal caratterizzare solo la “preistoria” del capitale, la sua “cosiddetta accumulazione originaria”: non solo ne percorre interamente la storia, si ripresenta con inedita intensità nel tempo della finanziarizzazione del capitalismo. Ogni cosa, da un’isola dell’Egeo ai servizi sociali essenziali di interi Paesi, deve essere violentemente “recintata” per aprirla alle logiche della proprietà privata, del profitto e dell’accumulazione. Solo così è possibile succhiare nuovo valore e immetterlo sui mercati finanziari globali, garantendo la continuità del comando del capitale sul lavoro e sulla cooperazione sociale, sulla vita. La razionalità di questo comando è limpida quanto la chiarezza con cui Ben Bernanke, con le parole citate in esergo, ha disegnato alla Camera dei deputati americani gli scenari futuri dell’“economia”.
È proprio vero, come abbiamo detto e scritto in questi anni, che l’uno si è diviso in due, che profitto, accumulazione e comando del capitale possono imporsi soltanto con immane violenza sulla composizione di quella che, con Marx, continuiamo a chiamare composizione del lavoro vivo contemporaneo. Nei prossimi anni, nessuno potrà sottrarsi alla scelta della parte da cui stare. E se nel crepuscolo, nel tempo della finanziarizzazione e del capitalismo cognitivo, continuiamo a intravedere le luci dell’alba, della “cosiddetta accumulazione originaria”, ripetiamo – con l’azzardo e lo sguardo lungo che devono tornare a caratterizzare il discorso politico – le parole di Gerrard Winstanley, il capo dei diggers, uno che in quell’alba (nella rivoluzione inglese degli anni ’40 del Seicento) stava dalla parte giusta: “il vecchio mondo si sta consumando come pergamena nel fuoco”.
2. Non v’è dubbio che le parole di Winstanley abbiano una validità pressoché letterale laddove si interpreti il riferimento al “vecchio mondo” in un senso divenuto di uso comune solo molto tempo dopo di lui: laddove cioè lo si traduca con “l’Europa”. A noi pare davvero strabiliante la povertà del dibattito di queste settimane sulla dimensione europea della crisi. Si continua a leggere, sui giornali non solo italiani, di singoli Paesi (i Pigs o, da quando l’Italia è rientrata nel gruppo, i Piigs) che rischierebbero di crollare di fronte all’attacco della “speculazione”, “trascinando” con sé “nel baratro” l’intera unione monetaria europea. Come se non fosse evidente (e perfettamente documentabile) che l’attacco della finanza globale è indirizzato da mesi contro l’euro e contro l’Unione europea in quanto tale. “Persino” la Germania, si continua vaticinando, rischierebbe di essere “travolta”; da responsabilità altrui, pare di capire, magari dall’innata attitudine dissipatrice degli europei “meridionali”: come se non fosse evidente (e perfettamente documentabile) che la “prosperità” tedesca di questi anni si è fondata, oltre che su processi di accentuata “dualizzazione” del mercato del lavoro, proprio sulla moneta unica, che ha garantito le esportazioni tedesche in particolare verso i Paesi dell’Europa mediterranea (e non sarà certo casuale che nei portafogli delle banche tedesche abbondino ad esempio i titoli greci). Intanto, sotto la spinta delle rivolte nel Maghreb e nel Mashreq e a fronte della continuità delle migrazioni da quell’area, anche la libera circolazione nello spazio di Schengen (l’altro simbolo, insieme all’euro, del “successo” dell’integrazione europea) è stata messa pesantemente in discussione nei mesi scorsi. Non bastano questi scarni cenni per certificare lo stato semi-comatoso dell’Unione europea? E intanto, a fronte di una crisi globale che perfino molti economisti mainstream avevano interpretato nel segno della crisi del neo-liberalismo, la Banca Centrale Europea continua a ripetere, come un disco rotto (ma con devastanti conseguenze sociali), il mantra del monetarismo, che del neo-liberalismo ha sempre costituito l’hardcore. Il pareggio di bilancio, che il buon Tremonti vorrebbe scrivere in Costituzione (come baluardo, si suppone, per la lotta contro il “mercatismo” che ha predicato per anni), ne è la traduzione dal punto di vista delle “raccomandazioni” ai singoli governi.
Nei giorni più caldi della discussione parlamentare sulle misure di “austerità” in Grecia, un deputato del KKE (il partito comunista greco) ha tenuto un infuocato discorso, sostenendo che il suo Paese aveva ormai perso ogni “sovranità”. Nulla di strano, fin qui: colpisce invece che il discorso di quel deputato sia stato ripreso dal “Financial Times”, che ne ha lodato il “coraggio” per avere – lui solo – “detto la verità”. Ora, questa “verità” l’abbiamo sperimentata anche in Italia. Non solo, si badi, nell’entità e nella composizione della manovra varata dal governo, ma anche (verrebbe da aggiungere soprattutto) nelle posizioni che in questi giorni sono state assunte dall’opposizione. Non possiamo qui scendere nel dettaglio dei singoli provvedimenti e delle critiche avanzate a quella che Bersani è giunto a definire una “manovra classista” (ha cominciato a farlo Andrea Fumagalli). Quel che colpisce è la reverenza assoluta che viene ostentata dall’opposizione e dai suoi organi d’informazione nei confronti di figure come Giorgio Napolitano (ormai prossimo alla santificazione), Mario Draghi e Mario Monti: si è giunti a parlare di un “triangolo” composto dal Presidente, dalla Banca d’Italia e dal governo, in cui la debolezza, la corruzione (e chi più ne ha più ne metta) di quest’ultimo spiegherebbe l’attacco della “speculazione” all’Italia e il rischio default. Che questo rischio sia catastroficamente aperto, negli stessi giorni, negli Stati uniti non sembra turbare la logica di queste analisi (magari è colpa di Berlusconi pure lì!): si tratta solo di intervenire sul terzo vertice del triangolo, sostituendo Berlsuconi con un personalità “affidabile” e con forze politiche “responsabili” (che sia di nuovo il momento di Scilipoti?) e il gioco, pare di capire, è fatto.
E poi? Poi, ripetono un po’ tutti, sarà il momento dei “sacrifici”, certo equamente distribuiti per il “bene del paese”. La parola – “sacrifici” – l’ha sussurrata un paio di volte perfino il buon Vendola, a cui saranno venuti in mente i bei tempi in cui era giovane e quella parola piaceva a Enrico Berlinguer, segretario del suo partito. Quelli di noi che avevano raggiunto l’età della ragione venivano allora definiti “untorelli”: ma anche i più giovani sanno che austerity e sacrifici non hanno portato bene allo stesso Partito comunista alla fine degli anni Settanta. Erano giusto serviti a imporre (par di ricordare: con una certa violenza) quel po’ di “pace sociale” (chiamata “solidarietà nazionale”) di cui il capitale aveva bisogno per lanciare una devastante offensiva che avrebbe travolto di lì a poco lo stesso partito comunista e l’intero movimento operaio ufficiale. Come dire? Abbiamo l’impressione che le cose non andrebbero in modo molto diverso questa volta… Ma oggi il piano dello scontro si è interamente spostato al di fuori dei confini nazionali (all’interno di questi confini, come dimostrano gli sviluppi degli ultimi mesi, c’è spazio soltanto per una gestione populista e razzista della crisi da parte delle forze di destra). Hic Rhodus, hic salta, ancora una volta: o saremo in grado di conquistare un terreno europeo su cui agire la lotta e stabilire un rapporto di forza favorevole con il capitale finanziario, oppure, sotto il profilo politico, non vi sono alternative ai “sacrifici”. Ma questo significa prima di tutto attaccare l’ortodossia neo-monetarista della Banca centrale europea e il patto di stabilità su cui si fonda oggi l’euro. Occorre sfatare il tabù del default. Diciamolo chiaramente, una volta per tutte: il vincolo di bilancio pubblico è solo funzionale alla valorizzazione biopolitica del capitalismo contemporaneo. Il diritto alla bancarotta è oggi forma di contropotere contro la violenza dei mercati finanziari. Solo la crescita, l’intensificazione e la circolazione delle lotte, nei prossimi mesi, possono rendere questo obiettivo praticabile (ponendo altresì le condizioni per una rifondazione del progetto europeo): di questo occorre cominciare a parlare, e con una certa urgenza.
Abbiamo detto spesso, in questi anni, che come il movimento operaio è cresciuto storicamente attorno all’invenzione di una forma di lotta, lo sciopero, che ha permesso di fare pagare il capitale industriale, oggi si tratta di immaginare e sperimentare strumenti di lotta che costringano il capitale finanziario a pagare. Lo abbiamo detto (e lo ripetiamo) consapevoli dell’enorme difficoltà di questo compito. Sappiamo bene che sui mercati finanziari globali sono sequestrate e quotate le nostre vite, ed è su questo ricatto che si fonda la possibilità per il capitale finanziario di dettare politiche e “sacrifici” a interi Paesi. Di qui deriva la difficoltà a immaginare, in una situazione come quella greca (o come quella italiana), una politica che punti all’accelerazione e alla gestione del default: catastrofiche (si ripete con qualche ragione) sarebbero le conseguenze sociali di un fallimento dello Stato. Si potrebbe intanto ricordare che giusto dieci anni fa, una simile “catastrofe” si abbatté su un grande Paese latino-americano, l’Argentina: ma la catastrofe fu accompagnata, forzata, indirizzata da un grande movimento insurrezionale, che al prezzo di decine di morti aprì una nuova stagione politica in quel Paese. È bene ricordare quel che è successo: per mesi le lotte nutrirono straordinari esperimenti di auto-organizzazione economica, sociale e politica, che sedimentarono una nuova (e affatto materiale) realtà di cooperazione e solidarietà. Su questa realtà si innestò un governo “spurio” e tutt’altro che “rivoluzionario”, il governo di Nestor Kirchner, che attraverso ambivalenti rapporti con le lotte e i movimenti, nuove politiche e una nuova gestione dell’interdipendenza su scala continentale, ha fatto dell’Argentina il Paese che è oggi: un Paese su cui certamente non splende il “sol dell’avvenire” ma in cui altrettanto certamente si vive meglio di dieci anni fa.
Certo, in Argentina il peso era vincolato alla parità con il dollaro, ma questo non configurava in alcun modo una condizione paragonabile a quella in cui sono oggi la Grecia e l’Italia per via dell’esistenza dell’euro (e lo stesso si può dire dell’Islanda, l’altro Paese sulla cui gestione del default sarebbe utile soffermarsi). È proprio per questo che insistiamo sulla dimensione europea: e invitiamo a ragionare sullo scenario di una europeizzazione del default. Ci pare davvero l’unico scenario che, con tutte le sue enormi difficoltà, consenta di sottrarsi al ricatto del capitale finanziario e agli accigliati narratori della necessità dei “sacrifici”.
3. La consapevolezza di questa necessaria prospettiva europea vive in modo ambivalente e ancora insufficiente all’interno delle lotte da cui siamo partiti (e delle molte altre, ovviamente, che non abbiamo menzionato). Ma fortissimo è il senso di avere raggiunto un limite che occorre forzare. È in questo senso che, all’interno del seminario di Genova su “composizione di classe e organizzazione del comune”, abbiamo parlato della fine della resistenza, intendendo con questa formula l’esaurimento della caratterizzazione meramente “difensiva” delle lotte. In prima battuta, parlare di fine della resistenza ha un significato banale: si riferisce cioè alla percezione diffusa che non c’è più molto da difendere, e che comunque la postura difensiva conduce regolarmente alla sconfitta. Ma è proprio questo senso del limite che sta cominciando a nutrire a livello di massa il desiderio e il bisogno di andare oltre, di riaprire un terreno programmatico e di costruzione dell’alternativa. È su questo terreno che intende porsi con sempre maggiore decisione il lavoro di UniNomade. Senza alcuna spocchia, sia chiaro: siamo consapevoli dell’enorme ricchezza del dibattito e delle sperimentazioni che attraversano i movimenti e le lotte, così come dell’esistenza di una molteplicità di luoghi e di soggetti che si pongono su questo medesimo terreno. Con tutti intendiamo dialogare e collaborare, dando il nostro contributo. E contribuendo a identificare e sciogliere qualche equivoco. Un paio di esemplificazioni a questo riguardo, relative alla situazione italiana, possono bastare per il momento.
Dicevamo all’inizio del carattere maggioritario che hanno assunto in Italia le lotte contro il saccheggio dei “beni comuni”. La straordinaria campagna sull’acqua, coronata dal successo referendario, è stata decisiva per affermare questo carattere maggioritario. Lo scontro, tuttavia, si è subito riaperto: la manovra finanziaria ha pudicamente escluso l’acqua dalla nuova ondata di privatizzazioni, ma in compenso vi ha incluso trasporti, luce e gas colpendo duramente sul terreno della sanità. Ma anche rispetto all’acqua la partita è tutt’altro che chiusa: una volta fissato il principio della “pubblicità” dell’acqua, si tratta di individuare le forme della sua canalizzazione e distribuzione (quell’insieme di interventi, cioè, che producono perfino un “bene” apparentemente così naturale come l’acqua, rendendolo socialmente fruibile). Il referendum ha certo dato un responso univoco anche su questo piano, ma i tentativi di aggirarlo sono già in atto. E abbiamo sinceramente apprezzato un intervento di Nichi Vendola sul “Manifesto”, un paio di settimane fa, con cui ha spiegato attraverso molti dati “tecnici” quanto in profondità ormai la “mano pubblica”, anche in una regione come la Puglia, sia corrotta dalla contaminazione delle logiche e degli imperativi del capitale finanziario (per tacere di altre forme di “corruzione”). Il problema che ci pare qui emerga con chiarezza è quello che abbiamo spesso indicato con la distinzione tra il concetto di comune e quello di “beni comuni”: mentre il primo si costituisce criticamente contro la specularità di “privato” e “pubblico”, esaltando la materialità dei processi di produzione sociale che rendono perfino l’acqua qualcosa di “comune”, il secondo rischia di autorizzare l’idea che si tratti semplicemente di difendere qualcosa che esiste già; e sconta l’inevitabile prossimità, all’interno del capitalismo, tra i “beni” e le “merci”. Sappiamo bene che molti compagni e compagne che hanno costruito la campagna referendaria sull’acqua e sono impegnati nelle lotte contro il saccheggio dei “beni comuni” (pensiamo ad esempio a Ugo Mattei e Guido Viale) sono perfettamente consapevoli di questi problemi. Anche a loro ci rivolgiamo per porli al centro del dibattito politico, per cominciare a ragionare sulla costruzione di nuove “istituzioni del comune” e su come conquistare al comune istituzioni e strutture “pubbliche”.
Un ulteriore esempio delle difficoltà e degli equivoci al cui interno si sviluppano i movimenti e le lotte viene dalla straordinaria mobilitazione dello scorso autunno contro la “riforma” dell’Università voluta dal “ministro” (virgolette d’obbligo) Gelmini. Quella mobilitazione è stata straordinaria non solo per l’intensità, la durata e la partecipazione di massa: lo è stata anche perché, almeno a tratti, ha coinvolto l’intero mondo della formazione, ha parlato con un linguaggio diverso da quello dei movimenti universitari tradizionali (il linguaggio della precarietà e del lavoro cognitivo in formazione) e ha posto – almeno in alcune sue componenti non marginali – il problema di costruire una “nuova” università. Anche questo movimento, tuttavia, si è esaurito nel momento in cui la legge Gelmini è stata approvata dal Parlamento, nel momento cioè in cui si sarebbero dovuti intensificare il lavoro per la progettazione e la sperimentazione di nuove esperienze formative e un intelligente sabotaggio della legge nella sua fase applicativa. Siamo convinti che quanti hanno interpretato il movimento d’autunno come movimento in “difesa dell’Università pubblica” abbiano dato un contributo a questa smobilitazione. La proposta di un referendum abrogativo della legge Gelmini, attorno a cui hanno dibattuto per qualche settimana collettivi studenteschi, docenti democratici e strutture sindacali, è da questo punto di vista esemplare: evidentemente impraticabile (considerata in primo luogo la reputazione di cui gode l’Università nel corpo elettorale italiano), ha finito per accompagnare l’elaborazione del lutto per la sconfitta, autorizzando l’idea che nell’Università prima della “riforma” Gelmini vi fosse qualcosa per cui valeva la pena di battersi. Cosa di cui, come abbiamo spiegato altre volte, è quantomeno ragionevole dubitare. Di lì a qualche mese, in condizioni diverse, la situazione si sarebbe ripetuta con il grande investimento fatto da settori di movimento e della sinistra sullo “sciopericchio” del 6 maggio: ovvero sull’astuta operazione con cui Susanna Camusso ha inaugurato la sua stagione di segretaria della CGIL, mettendo in un angolo la FIOM, sospendendo per un paio di mesi vertenze e scioperi di settore e spianando la via per il ritorno della sua Confederazione al tavolo della concertazione per definire il nuovo sistema contrattuale.
4. L’anno III d.c. è stato anche il primo di una nuova fase della storia del collettivo UniNomade (quella che, con poca fantasia, abbiamo chiamato UniNomade 2.0). Il lancio del sito e un paio di seminari tematici (sulla Cina e sul “comune giuridico”) l’hanno in qualche modo inaugurata, mentre il seminario di giugno a Genova ha rappresentato una prima sperimentazione di intervento diretto sul terreno che abbiamo qui definito “programmatico”. A Genova ci siamo confrontati con realtà di movimento eterogenee, con laboratori di ricerca e con singoli ricercatori/singole ricercatrici, secondo un metodo che ci proponiamo di seguire anche nel corso del prossimo anno. Tre seminari, preparati con un lavoro di costruzione e inchiesta sul piano territoriale, sono già in cantiere: uno sugli scenari di un nuovo welfare (che cominciamo a chiamare commonfare), uno sulle trasformazioni dell’impresa (sulle modalità attraverso cui viene comandata la cooperazione sociale ma anche sulle “funzioni contro-imprenditoriali” che vivono dentro quella cooperazione) e uno sulla nuova realtà della costituzione (contro il feticismo costituzionale così diffuso in Italia, per analizzare la costituzione materiale emergente e per cominciare a immaginarne una “fondata sul comune”). Da subito, coerentemente con quanto abbiamo scritto, collocheremo questi seminari all’interno di una dimensione europea (consolidando i molti rapporti che abbiamo allacciato quest’anno e costruendone di nuovi, in particolare in quella sponda sud del Mediterraneo che oggi più che mai rappresenta per noi un tassello fondamentale di ogni ragionamento sull’Europa). E cercheremo di dare un contributo alla costruzione di reti e momenti di discussione a livello europeo. È un programma straordinariamente impegnativo per un collettivo come quello di UniNomade: eppure ne avvertiamo pienamente la radicale insufficienza. A quanti condividono con noi questo senso di insoddisfazione per quello che sono e per quello che fanno, a quanti continuano a sognare l’assalto al cielo e il “sogno di una cosa” chiediamo, banalmente, di darci una mano.
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.