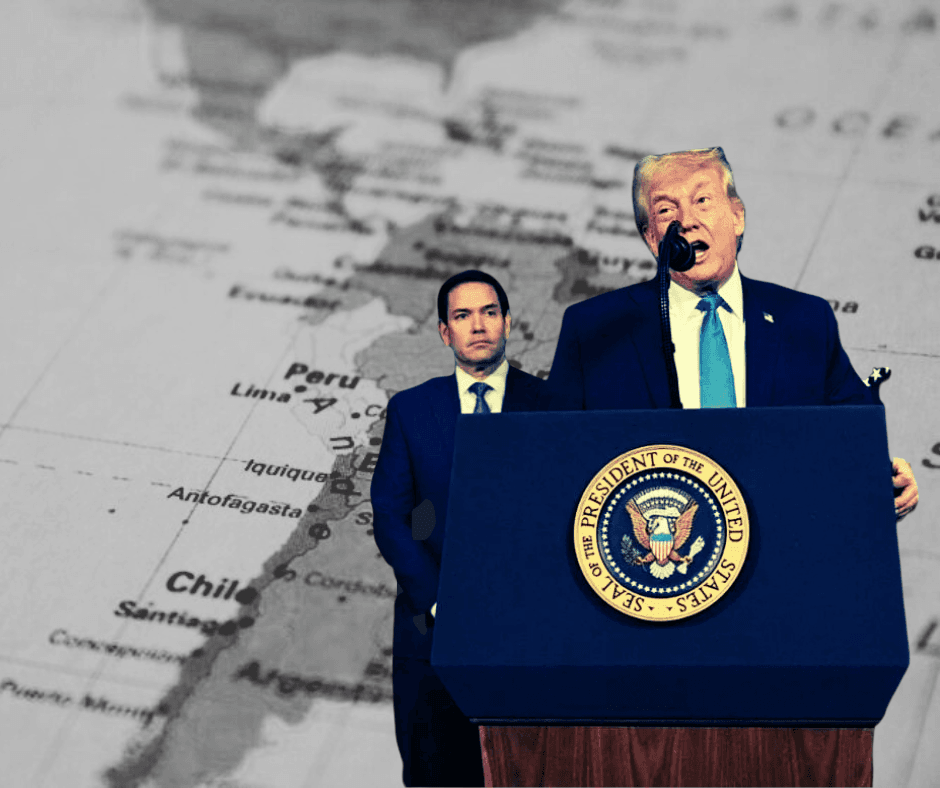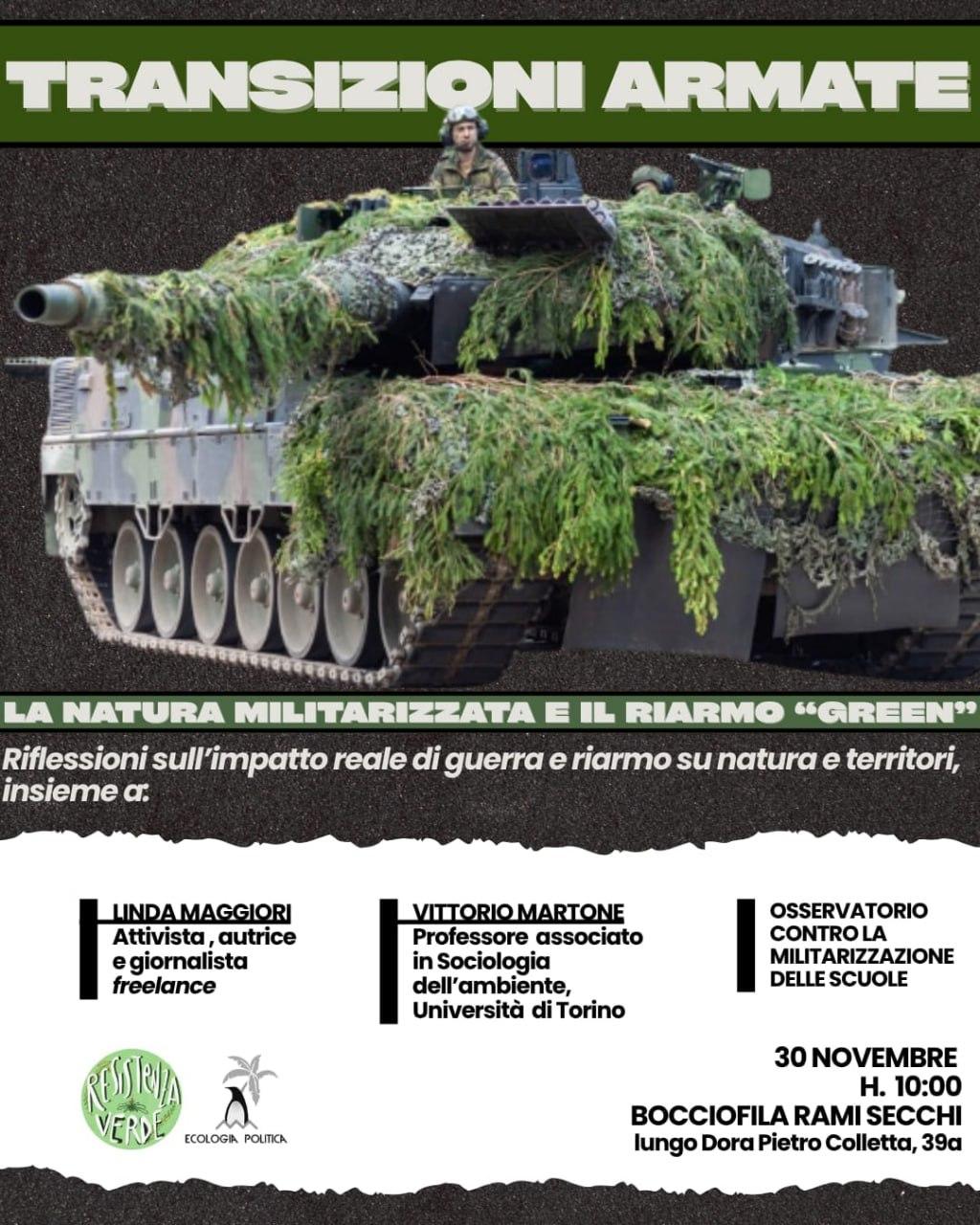Per affrontare la siccità dobbiamo prosciugare la sete di profitto

Quando si parla della siccità che sta colpendo il nostro paese e in particolar modo la pianura padana ed alcune aree del centro-nord, bisogna fare una premessa: questo non è un fenomeno contingente, ma un fatto che diventerà strutturale.
Non siamo più da tempo ormai nella fase in cui la materializzazione dei cambiamenti climatici sarà uno scenario a venire, ne siamo totalmente immersi. Il riproporsi di fenomeni metereologici estremi prima localizzati e ora sempre più generali in sequenze di tempo ravvicinate non lascia dubbi.
Non si tratta dunque di una siccità straordinaria, come viene descritta dai media, ma di qualcosa che diventerà la norma, magari con un processo non propriamente lineare, ma che modificherà radicalmente e nel breve periodo la realtà a cui siamo abituati.
Fare questa premessa, per quanto scontata per alcuni versi, è necessario per ragionare su una proposta antagonista dentro la crisi climatica. Ciò significa che dobbiamo necessariamente renderci conto che combattiamo su due fronti, uno che è quello battuto finora, cioè la necessità di invertire la rotta sulle emissioni per mitigare sul lungo periodo quelli che potrebbero essere gli effetti più nefasti della crisi climatica. L’altro che è immediatamente collegato al primo, ma che richiede una strategia propria è quello di misurarsi con gli effetti qui ed ora del cambiamento climatico.
Con questo doppio sguardo ci tocca guardare questa vicenda della siccità. Da un lato è un effetto strutturale del cambiamento climatico, ma il modo in cui questo effetto sarà affrontato definirà ulteriormente l’approfondirsi della crisi climatica oppure aprirà delle possibilità per mitigarla ed attraversarla in maniera degna e giusta per tutt*.
Se questo non è un fenomeno straordinario, ma diverrà la norma è importante dunque discutere su come esso va affrontato a livello strutturale. E’ evidente ancora una volta come le istituzioni del nostro paese sono arrivate totalmente impreparate di fronte all’emergenza: uno dei temi che emerge con forza è infatti quello dell’inadeguatezza dell’infrastruttura idrica nel paese. Per fare un’esempio, secondo i dati ufficiali la rete idrica di Torino ha una dispersione pari al 24%, ed è considerata una di quelle con le performance migliori in Italia. La media nazionale indica che 42 litri di acqua ogni 100 immessi nella rete idrica vengono persi a causa di tubi vecchi e rotti.
Per anni siamo stati abituati alle sicumere sulle inefficenze delle reti idriche nel Sud del paese, come se queste fossero un problema connaturato alla cosidetta “arretratezza meridionale”, ma in realtà esposti ad una condizione di stress gli acquedotti di tutto il paese mostrano gli stessi limiti, che si fanno più significativi in quei territori provinciali e periferici in cui le amministrazioni locali si misurano con il progressivo taglio di fondi degli ultimi decenni. Un ulteriore capitolo riguarda la privatizzazione delle reti idriche, che nonostante i risultati del referendum, ha visto quasi ovunque l’avvento di partecipate basate sul modello aziendalista ed orientate al profitto per cui la manutenzione delle reti rappresenta un costo, da commisurare ai benefici in termini di entrate. E’ evidente che la gestione privatistica di una risorsa fondamentale come l’acqua produce distorsioni strategiche che provocano contraddizioni persino all’interno dello stesso tessuto dell’economia capitalista. La lotta sul tema della siccità dunque non può che partire da una contesa sul tema delle risorse e di come esse vengono impiegate e per cosa. Da quanto è dato sapere al momento è stato stanziato appena un miliardo per l’adeguamento degli acquedotti, briciole se si fanno i conti su quali sarebbero le reali necessità, e se si confrontano questi investimenti con quelli dedicati alle grandi opere inutili o al riarmo.

Abbiamo la necessità in questo senso di costruirci un sapere tecnico, ma immediatamente politico, perché è chiaro che sempre di più il tema di come, ed a chi verranno distribuite le acque in un’epoca di possibile razionamento di massa è immediatamente politico.
Si perché già ad oggi se poco è stato fatto per limitare la dispersione delle acque, in termini generali il consumo delle famiglie in alcune aree del paese è andato diminuendo. Diminuzioni dei salari, buone pratiche ambientali, progressivo spopolamento, difficile capire quali fattori abbiano determinato questo fenomeno, ma sicuramente la scarsità di acqua non è attribuibile in maggior parte ai comportamenti individuali.
Per la Fao nel 1992 in Italia il consumo d’acqua era di 738,8 metri cubi (circa 738mila litri) a testa per tutti gli utilizzi, adesso il consumo d’acqua si attesta sui 563,5 metri cubi.
Il primo settore per consumo di acqua in Europa è naturalmente l’agricoltura, intorno al 40%. In Italia il consumo d’acqua per i campi, le attività forestali e la pesca ammonta a 14,6 milioni di metri cubi. In questo siamo secondi nell’Unione europea, dietro la Spagna.
Al secondo posto sempre a livello europeo vi è la produzione di energia (il 18,2%) che si divide tra il raffreddamento delle centrali ad energia nucleare (alla faccia degli ambientalisti pro-nuke) e di quelle a combustibili fossili, oltre che per la produzione di energia idroelettrica.
Il primato che invece possediamo come Italia è quello dell’utilizzo dell’acqua per “attività minerarie, manifattura e costruzioni”(4,2 milioni di metri cubi).

Questa breve ricognizione di dati ci mostra la portata del problema della siccità, che sta avendo sicuramente effetti devastanti sul comparto agricolo, ma che molto probabilmente, a cascata sta colpendo il settore energetico già sotto forte stress e quello manifatturiero, estrattivo e delle costruzioni.
E’ chiaro che quanto sta accadendo dovrebbe interrogarci su cosa produciamo, come lo produciamo e a che scopo, ma a livello istituzionale la priorità assoluta è quella di tutelare i profitti e le sigle di categoria dei vari comparti coinvolti invece di comprendere la necessità di un ripensamento radicale dei rapporti di produzione ripongono le loro speranze nei sostegni pubblici e nel soluzionismo tecnologico.
Per quanto riguarda l’agricoltura la sfida con cui ci misuriamo è chiara, da un lato c’è il rischio che la produzione agricola vada verso un’ulteriore concentrazione agroindustriale: la ristrutturazione necessaria per produrre a queste condizioni vuol dire avere banalmente il capitale da investire in nuove tecnologie, in invasi di acque privati (e quindi in tendenza anche alla privatizzazione delle acque per usi agricoli, come abbiamo visto in scenari distanti da noi come quello cileno, con la sottrazione di risorse a tutto il resto della popolazione), in nuovi impianti agricoli che si adattino alle nuove condizioni climatiche. I piccoli e medi produttori si misureranno con una competizione ancora più violenta che progressivamente, anche grazie alla Mano Visibile dello Stato che favorirà il processo, li sbatterà fuori da un mercato già molto complicato.
Paradossalmente l’effetto sarà quello di privilegiare ulteriormente le produzioni più idrovore. Se si prende l’esempio del Piemonte ad essere particolarmente critiche sono le coltivazioni di mais e riso che richiedono un enorme fabisogno di acqua. Il primo viene coltivato non tanto per il fabisogno alimentare degli umani, quanto per fornire il mangime ai grandi allevamenti ed il carburante per le centrali a biomasse, decantate come presunta fonte di energia green.
Per quanto riguarda il riso la situazione è un po’ più complessa, infatti si tratta di una delle poche produzioni su cui il nostro paese è autosufficiente. A livello nazionale sono complessivamente coltivati a riso 227mila ettari (dati 2020). Di questi il 51% sono in Piemonte (115mila ettari con in prima fila Vercelli e Novara) e il 43% in Lombardia (provincia pavese, Lomellina e provincia di Milano). Secondo i dati dell’Ente Risi la produzione italiana è di 1,1 milioni di tonnellate, di queste circa 100mila sono esportate (con principali mercati Turchia, Usa e Svizzera. Rimane il fatto che la produzione di riso richiede un’enorme quantità di acqua tanto che a più riprese è stata tentata la strada di costruire nuovi invasi appositi nel biellese.
Negli ultimi anni, sempre in una configurazione agroindustriale, si è diffusa la pratica della coltivazione dei risi “in asciutta”, cioè evitando l’allagamento delle risaie almeno in una prima fase, ma ci sono stati risultati altalenanti. Questa tecnica permette alle grandi produzioni un risparmio in termini di lavoratori e mezzi di produzione.
Il problema di aver disegnato intere aree del territorio a livello industriale fin dall’ottocento intorno ad una monocoltura oggi potrebbe avere un costo molto salato.
Tra l’altro la meccanizzazione delle produzioni ha progressivamente diminuito la richiesta di manodopera per queste attività. Per cui a volte ci si trova in territori che mostrano una incredibile forbice della ricchezza tra chi vive di queste produzioni egemoniche e chi ne è lasciato ai margini.
Questi sono solo alcuni esempi, ma una lettura complessiva del rapporto tra agricoltura e scarsità idrica meriterebbe un’analisi ben più approfondita.

Ciò su cui non vi è dubbio è che questo modello di produzione agricola deve cambiare, ma la direzione verso cui lo farà dipende dalla capacità di costruire delle lotte a partire dai bisogni delle comunità e di quei contadini che rischiano di perdere tutto a causa di questi processi. Si tratta di ragionare su dei processi di demercificazione di questo settore, dove l’utilità delle produzioni è basata sulle necessità delle popolazioni e la filiera viene accorciata radicalmente.
Ancora più netto è il discorso per quanto riguarda le produzioni industriali, i settori estrattivi che fanno largo consumo di acqua e le costruzioni. Si pensi ai dati sulla dispersione derivata dal tunnel geognostico del Tav Torino – Lione o quanto successo al Mugello. La tendenza in Italia è guardare all’acqua dal punto di vista di una risorsa inesauribile, quindi che sarà mai una falda svuotata o un’area desertificata in confronto con il “progresso” (per pochi)? Il paradosso è che la voracità qui ed oggi del capitale ormai distrugge possibilità di “valorizzazione” per il capitale stesso sul lungo e medio periodo ad una velocità impressionante, speciamente in un paese come il nostro dove il culto dell’estrazione, del cemento e del tondino è un dogma quasi intoccabile.
Il Piemonte è una delle regioni più colpite dalla siccità, dove gli invasi sono ai minimi storici, con una riduzione in media del 50% e le acque del Po mai così basse da 70 anni. Senza contare che le sorgenti di montagna stanno registrando tra il 50 e il 90% in meno di portata d’acqua. L’allerta riguarda 145 Comuni soprattutto nel Novarese e nell’Ossolano, dove il Lago Maggiore è sceso di un metro. Nonostante si tenda a paragonare questa situazione con altre siccità “straordinarie” che si sono presentate nella storia recente la condizione attuale è totalmente differente poiché non si tratta solo di una scarsità di acqua corrente, ma ad essere progressivamente intaccate sono le riserve idriche naturali rappresentate dai ghiacciai.

Qui dunque si apre un altro capitolo fondamentale, cioè quello dello spazio montano come spazio di vita da preservare invece che come fonte di messa a valore e speculazione. Torniamo al ragionamento iniziale, uno sguardo sulle cause e uno sugli effetti. Come è emerso chiaramente dalla boutade sulla copertura dei ghiacciai con i teli riflettenti non esistono soluzioni tecnologiche per salvare queste riserve idriche dalla scomparsa, non esistono scorciatoie, ma l’unica maniera per impedire l’approfondirsi del disastro è abbassare le emissioni, cioè una vera transizione ecologica radicale. Questo vuol dire anche ripensare l’approccio alla montagna dei grandi eventi, delle infrastrutture dannose e del turismo coloniale.
Una battaglia per demercificare i territori, il lavoro, l’acqua ed il cibo ci attende nei tornanti della crisi climatica, ciò richiede uno sforzo incredibile nell’individuazione di alleanze, soggetti e progetti comuni. Ma le crisi sono feconde di disastri quanto di possibilità, mettiamoci in cammino.
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.