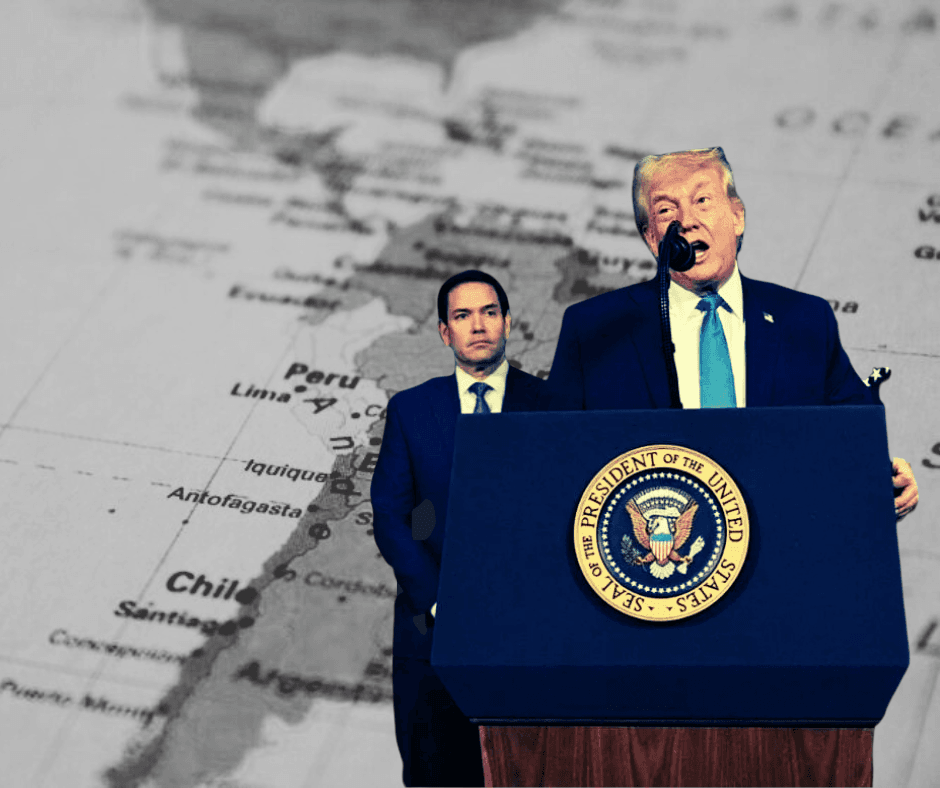Transizioni democratiche: tra tamburi di guerra e barricate per la pace
Mentre due navi da guerra americane si dirigono verso le coste libiche la strategia atlantica delle transizioni democratiche subisce l’ennesimo duro colpo. Con l’assalto all’ambasciata americana in Libia si approfondisce la crisi del tentativo di dirigere (per normalizzarli) i processi rivoluzionari intorno al Mar Mediterraneo da parte delle potenze occidentali. Che si tratti del patto con l’islamismo liberale o che si tratti delle pressioni politiche e militari per precipitare i processi rivoluzionari in guerre civili, l’apparato di cattura finanziario, mediale, morale e politico del “regime change” non riesce a consolidarsi. Da una parte si scontra e trova una straordinaria resistenza nell’estensività attuale dei processi rivoluzionari e dell’altra ha a che fare con un rigurgito dello scontro di civiltà che ancora oggi mobilita nelle piazze delle capitali arabe qualche migliaio (ma non per questo poco agguerrito e politicamente influente) di islamisti radicali (che nei prossimi giorni potrebbero anche aumentare di numero). Si tratta di una presenza politica e culturale che nello scorso anno se ne è stata o a guardare alla finestra la piazza rivoluzionaria in compagnia delle fazioni moderate in attesa che la transizione democratica gli aprisse le urne elettorali (come in Tunisia ed in Egitto) oppure a funzionare da agente corruttore ai “margini” dei movimenti contro i regimi (in Libia come in Siria ad esempio). Due modalità di governo della crisi nel mar mediterraneo sollecitate dagli Stati Uniti, dalla UE e dalle monarchie del petrolio per battere e disorientare le piazze rivoluzionarie nel loro percorso di liberazione dalla condizione di povertà. Il termidoro islamista con la sua ossessione per i corpi e l’urgenza di riattivare un dispositivo di paura contro i governati, la provocazione e la corruzione ai margini e dentro i movimenti di piccole ma ben attrezzate fazioni islamiste radicali tentano di suonare i tamburi di guerra contro i movimenti. D’altronde, al di là della retorica dell’Obama all’Università del Cairo, alle elites è chiaro che per reagire all’insorgenza proletaria contro la crisi che si distende tra le coste atlantiche fino ed oltre il Bahrain è la guerra che va fatta funzionare. Non c’è e non vogliono New Deal… tutt’altro!
Mentre assistevamo con orrore ai bombardamenti sulla Libia ci chiedevamo il perché dell’assenza di un movimento contro la guerra. A mio avviso però non trovavamo risposte soddisfacenti perché non rovesciavamo la domanda: “in che modo i lavoratori e le lavoratrici, i giovani proletari stanno lottando ora per la pace?”. Ancora troppo legati alla cultura del movimento per la pace e contro la guerra infinita di Bush forse immaginavamo l’istanza pacifista mostrarsi unicamente nella forma di un grande movimento d’opinione che nel rifiuto etico, giusto e intransigente, al massacro attuato dalla Casa Bianca e dai suoi soci contro la popolazione irakena e afgana, tentava di sabotare la guerra mobilitando anche milioni di persone in tutto il mondo. Forse anche per questa ragione, non coglievamo che tra le barricate intorno piazza Tahrir, nella Casbah di Tunisi, a piazza Syntagma, a Plaza del Sol, nei pressi di Zuccotti Park a farsi largo c’è il bisogno e il desiderio di pace, qui ed ora. Una istanza di pace non più disincarnata dai processi sociali e mantenuta lassù in una sfera ideale, ma ben saldata nella lotta contro la miseria e la povertà. In assenza e nell’indisponibilità di un New Deal, anzi nell’interesse capitalistico di sfasciare ciò che resta del welfare, in quella violenza distruttiva ed espropriatrice di ogni forma di vita c’è il carattere radicalmente belligerante della crisi. Ed è da questo punto di vista che i movimenti nelle città insorgenti del mediterraneo hanno affermato l’urgenza della pace in termini di riappropriazione delle ricchezze sottratte da una vita. Nella lotta per la dignità e la giustizia sociale in Tunisia come in Grecia si dice “dégage” ai regimi della guerra. Questo eccezionale sforzo dei movimenti in Nord Africa si è caratterizzato anche nella rottura dell’ordine della guerra infinita, delle crociate e delle jihad, provocato da un proletariato giovanile che si è immediatamente riconosciuto nei volti degli studenti e delle studentesse che a Londra davano l’assalto a Tower Hill o inondavano Roma il 14 dicembre del 2010. E quale orrore devono aver provato le elites quando scoprivano che quegli uomini e quelle donne non si rivolgevano più all’islam politico per risolvere i problemi della propria vita di quotidiana miseria! Che orrore devono aver avuto nell’ascoltare centinaia di migliaia di persone gridare “non abbiamo più paura” davanti alla polizia di Ben Ali e Mubarak! Contro questo eccezionale sforzo non potevano che tentare di riattivare il dispositivo della paura contro i governati, tramite l’uso dell’islamismo liberale in alcuni casi o tramite la costruzione di condizioni politiche e sociali legittimanti i bombardamenti dei “volenterosi”, in cui “l’agente corruttore” dell’islamismo più radicale sta giocando un ruolo dirimente. Eppure questa strategia, su cui ha investito soprattutto la Casa Bianca e alcuni paesi dell’Europa, di reazione e normalizzazione che caratterizza le transizioni democratiche, vacilla ed è in crisi fin dal suo principio, incalzata dai movimenti o\e scossa dalla sue stesse costitutive contraddizioni interne.
Su questa debolezza va tenuto aperto ed approfondito il dibattito nei movimenti a partire dalla questione della pace e delle sue possibili forme di costruzione che mai come oggi sono saldate alle prime e importanti allusioni di alternative alla crisi capitalistica. E non mi riferisco a ipotesi frontiste che nel migliore dei casi hanno come slogan “si salvi chi può!” in qualche rincorsa elettorale, ma parlo dei processi organizzativi delle lotte e dell’autonomia politica dei movimenti capaci di darsi una propria temporalità e spazialità destituente e costituente. E’ importante continuare a divenire “hub” tra una sponda e l’altra del mediterraneo e aumentare le forme di reciprocità delle lotte contro la precarietà, la povertà e la miseria. Se non aggiungiamo la parola “pace”, alla koinè dialektos, al dialetto insorgente dei movimenti il rischio è di lasciarsi andare a immaginazioni catastrofiste e impotenti. Se non riconosciamo nelle barricate di Piazza Syntagma, nelle forme di mutualismo sociale in Spagna, nelle lotte e rivolte tra la Tunisia, l’Egitto, il Bahrain, nelle prime occupazioni e autogestioni di fabbriche e servizi l’ipotesi antagonista della pace, c’è il rischio di proiettarsi in una “pacifica guerra” dove gli attori sono sempre gli stessi proprio come le vittime, a volte incatenati tra jihad e crociate, altre rinchiusi nella solitudine dell’individualismo neoliberista, e dove il no alla guerra risuona lassù in un rifiuto ideale. Al contrario mai come oggi le lotte sembrano indicare la possibilità di pace quanto mai concreta… d’altronde è da mesi che tra le barricate in fiamme o sotto i palazzi del potere si grida “dégage” ai regimi della crisi e dell’austerità, i regimi della guerra.
FM
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.