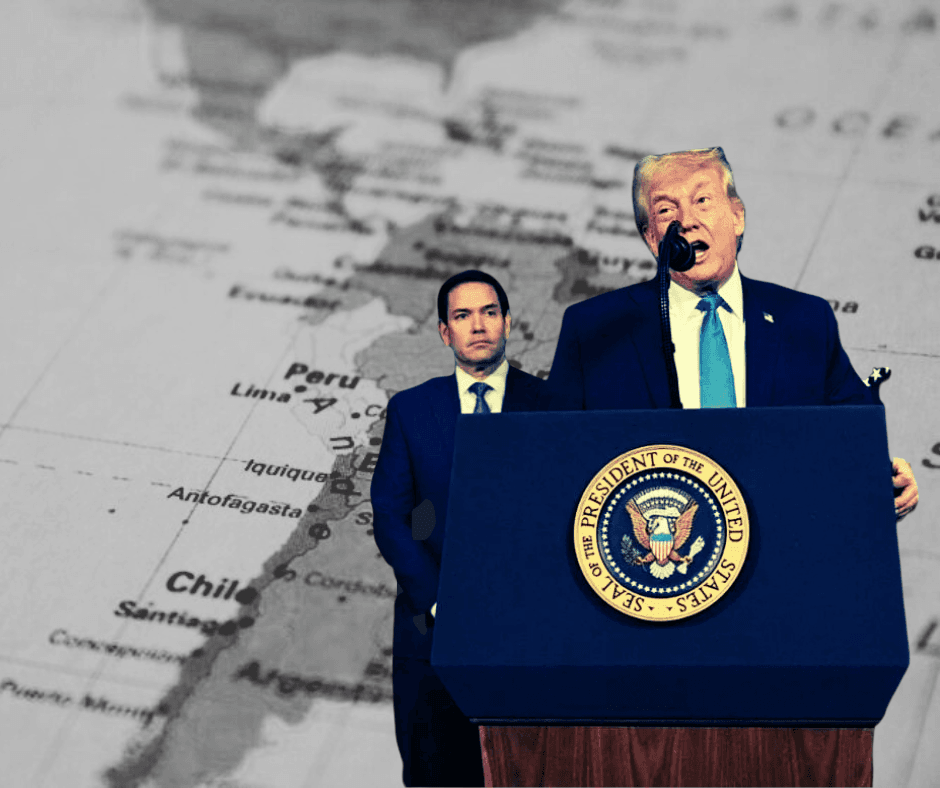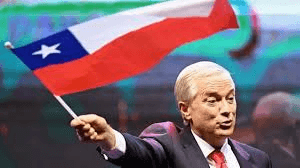Il “voto triste”, canto del cigno della democrazia
Oggi non si vota più per qualcosa, ma contro qualcosa, e non si sa in nome di cosa. La stragrande maggioranza degli elettori di Hollande non ha scelto Hollande, ma ha votato unicamente per cacciare Sarkozy: lo mostra, se ce ne fosse bisogno, la quantità di elettori diventati socialisti al secondo turno, che erano stati fascisti al primo. La confusione regna sovrana nella psicologia di masse prive di prospettive per i prossimi anni, ma una sola cosa è chiara: la politica istituzionale è qualcosa da cui bisogna difendersi, sfruttando anche il voto. Chi ha votato la miriade di formazioni di sinistra in Grecia, la maggior parte delle quali non ha superato la soglia del 3%, o le formazioni di sinistra più conosciute, che hanno fatto incetta di voti, o ancora gli Indipendenti, o anche qui i fascisti, ha votato contro il protocollo imposto dalla Troijca, e contro il governo che l’aveva accettato. In Italia il successo del Movimento 5 Stelle è un voto contro il sistema dei partiti, che da Berlusconi a Di Pietro, da Vendola a Bersani perdono consensi ogni giorno che passa. L’astensione, infine, rappresenta una protesta nella protesta: incarna l’idea che anche protestare non serva più o, in alternativa, che il voto non sia uno strumento di protesta adeguato; in ogni caso, non è espressione di consenso al modello attuale di decisione collettiva.
Non bisogna sottovalutare questa inclinazione squisitamente negativa del processo “democratico” contemporaneo, né fraintenderla. Il processo sociale di critica all’esistente sedimenta attraverso ben altri percorsi, ma ciò non significa che esso debba ignorare ciò che avviene sul piano delle forme sancite di partecipazione, semmai comprenderlo da un punto di vista antagonista. Il voto negativo, di protesta o di rifiuto, detto “antipolitico” o “populista” (non senza una certa superficialità) non costituisce in alcun modo la premessa di un processo di liberazione politica e sociale, pur esprimendone, a suo modo, uno dei presupposti. Si tratta di prendere atto che, in questa forma, il voto è sempre meno specchio o cartina di tornasole di ciò che alberga nelle teste di chi abita nella società (non lo è stato mai in forma esaustiva, ovviamente) ed è sempre più manifestazione del problema del non poter esprimere, in senso politico, quelle istanze che abbiano qualche sbocco. È ciò che era avvenuto già alle passate elezioni francesi, con il voto socialista nelle banlieues, che aveva espresso l’ostilità per (e la paura di) Sarkozy, più che l’approvazione per le politiche o i programmi di quel partito.
Ciò che abbiamo di fronte agli occhi è l’esaurimento storico del meccanismo per cui un complesso istituzionale, quello “democratico” di stampo occidentale, ha svolto una funzione, sia pur difficoltosa, di incanalamento di una più o meno confusa, più o meno ideologizzata sensibilità politica, anche popolare. In un’epoca remota, l’elettore pensava di scegliere un modello sociale con la sua croce. Già dagli anni Ottanta nessuno era più convinto di questo; ma allora, agli albori del neoliberismo, qualcuno pensò che ad essere scelti, nell’epoca del tramonto delle ideologie, sarebbero stati modelli differenti di amministrazione dello stesso esistente o, nel linguaggio impreciso dei professori, una branca del liberalismo tra le molte possibili. Oggi anche questa illusione è cessata: non si sceglie, pur all’interno del dogma capitalista, ma si condanna; non ancora il capitalismo, e non un partito o un’ideologia, ma l’amministrazione fattiva della società, incarnata in chi ha comandato negli ultimi quattro, cinque anni. Questo comportamento contiene già, in nuce, una forma di critica del sistema istituzionale nel suo complesso (pensato come “sistema dei partiti”): il voto negativo del 2012 è un “voto triste”, esattamente come quelli passati e quelli immediatamente futuri, perché già prevede i suoi involontari effetti “positivi” (la delega a nuovi leader) e quindi il carattere opposto, ma speculare, del voto negativo del 2015 o del 2016.
Questo stato di cose rende necessaria una valutazione storica. Il diritto di voto era stato concepito, inizialmente, come una conquista strappata ai detentori di una sovranità (di classe, di genere, di “razza”: operai, donne, afroamericani, ecc.): con esso una parte della possibilità di scelta sembrava essere sottratta all’arbitrio del dominante e trasferita all’uomo della fabbrica, o all’uomo della strada, alla donna, al nero, in alcuni casi anche all’immigrato. Questo provocò notevoli sconvolgimenti e non poche preoccupazioni in chi temeva cambiamenti sociali: non a caso questo parziale diritto a scegliere dei rappresentanti era stato annullato o fortemente limitato dai fascismi che sorsero in quegli anni o dagli stati democratici in guerra (diverso era il caso dell’URSS, che era nata fin dal principio nel nome di una critica della democrazia rappresentativa come modello istituzionale non libero, e per la sperimentazione di nuove forme di diffusione del potere). Il suffragio universale successivo al macello mondiale 1939-1945 (in parte causato dagli effetti complessi delle dinamiche di partecipazione di massa alla politica, di cui il voto fu una delle tante espressioni), rappresentò al tempo stesso l’apogeo del diritto di voto e l’inizio della sua crisi.
La messa in discussione del protagonismo delle masse alla vita politica, però, non poteva passare nuovamente per la negazione di un diritto acquisito, e al tempo stesso occorreva disinnescare le potenzialità destabilizzanti di quel protagonismo, anche in senso elettorale. Fu quindi conservato quel diritto ma, pur estendendo la sua portata formale, venne limitata quella reale: furono cioè riconosciuti limiti precisi, “costituzionali” – non per questo “democratici”– al ventaglio della scelta politica elettorale (in Italia fu bandito il partito fascista, in Germania ovest e negli USA furono estromessi dalle elezioni i partiti comunisti, e in generale i partiti vennero ammessi al voto se rinunciavano esplicitamente all’avventura della rivoluzione). La politica ufficiale si è unita nelle sue diverse componenti, dal dopoguerra, con il battesimo di un giuramento di fedeltà costituzionale, che impediva l’idea stessa della rivoluzione. Questo elemento trovava una complessa corrispondenza nella coesistenza pacifica internazionale: stati ispirati da ideologie apparentemente incompatibili trovavano soluzioni di compromesso alle questioni geopolitiche, attraverso la contrattazione nei consessi internazionali nati dopo il 1948).
Due volte (malvolentieri) concesso e due volte sostanzialmente negato – la prima volta in modo “dittatoriale” (1919-1945) la seconda in modo “democratico” (1945–…) il diritto di voto non ha retto, infine, alla rappresentazione scenografica del suo trionfo, nell’epoca dell’affermazione liberale mondiale (1989-2008): è in quell’epoca che, ridotto alla selezione di burocrati di servizio (paradossalmente simili nel loro ruolo di finti rappresentanti del “popolo” a quelli, sconfitti alla fine del secolo, di matrice socialista orientale), proni alle decisioni di organismi internazionali non più “politici” in senso accademico, ma economico-finanziari, ossia politici in senso pregnante. Il voto ha perso così, in questi tre decenni, qualsiasi senso e qualsiasi richiamo simbolico come strumento di delega e di scelta di una progettualità politica, reale o immaginaria che fosse, sia pure per interposta persona.
Questo è un fatto che, al netto delle ipotesi storiche, è ritenuto evidente dalla stragrande maggioranza degli abitanti del pianeta, ed anzitutto di quelli che hanno partecipato ad elezioni “democratiche”; ed è evidente che la protesta contro questo stato di cose – contro l’impossibilità di scegliere – si esprime anche, anche se non principalmente, nell’uso negativo dello strumento che le era stato deputato, votando per all’unico scopo di votare contro, o non votando affatto. Imparare a leggere i risultati elettorali non come espressione di cosa vogliono gli elettori, e neanche di cosa non vogliono semplicemente ma, piuttosto, della loro impotenza di fronte a una condizione che non li mette in condizione di esercitare un potere reale, è compito di un’intelligenza antagonista. Il voto negativo non annuncia che siamo arrivati al termine del sistema democratico. Significa, semmai, che una forma storica secolare di esercizio del potere è giunta al termine nella sostanza, anche se non ancora nella forma; e che a dirigere l’epoca futura saranno forze in grado di interpretare non soltanto il cambiamento che verrà, ma anche quello che, in forma più sottile e sotterranea – anche se tutt’altro che silenziosa – è già avvenuto.
Redazione Infoaut
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.