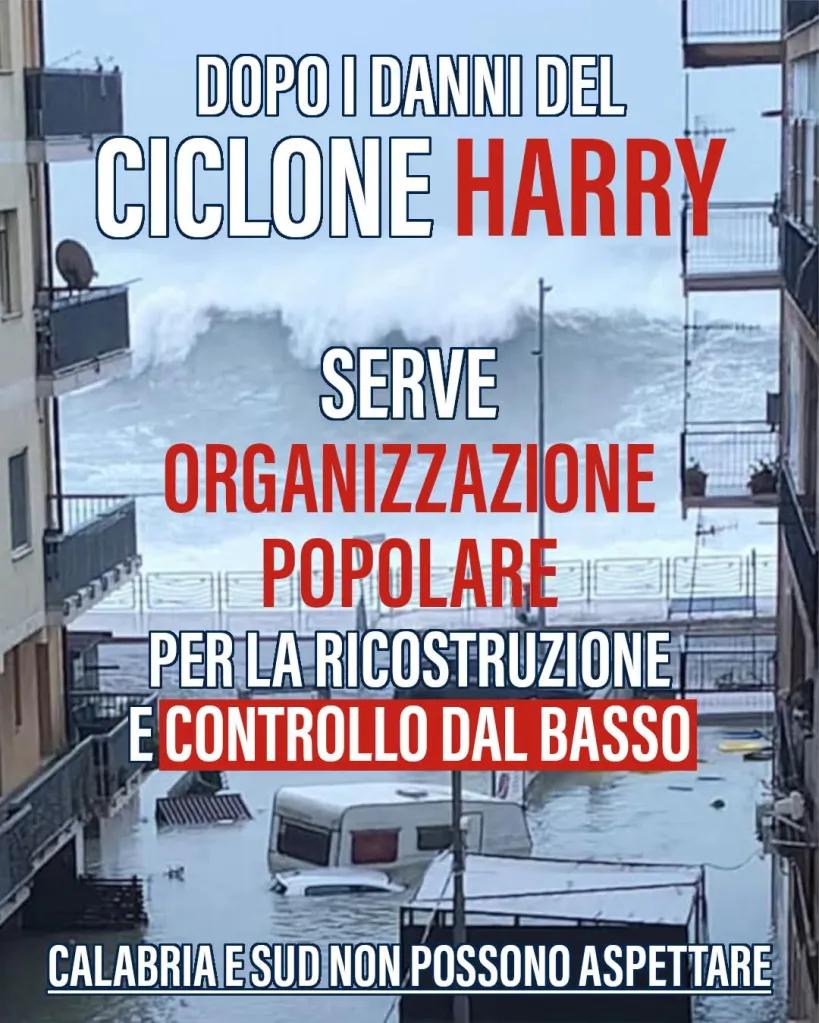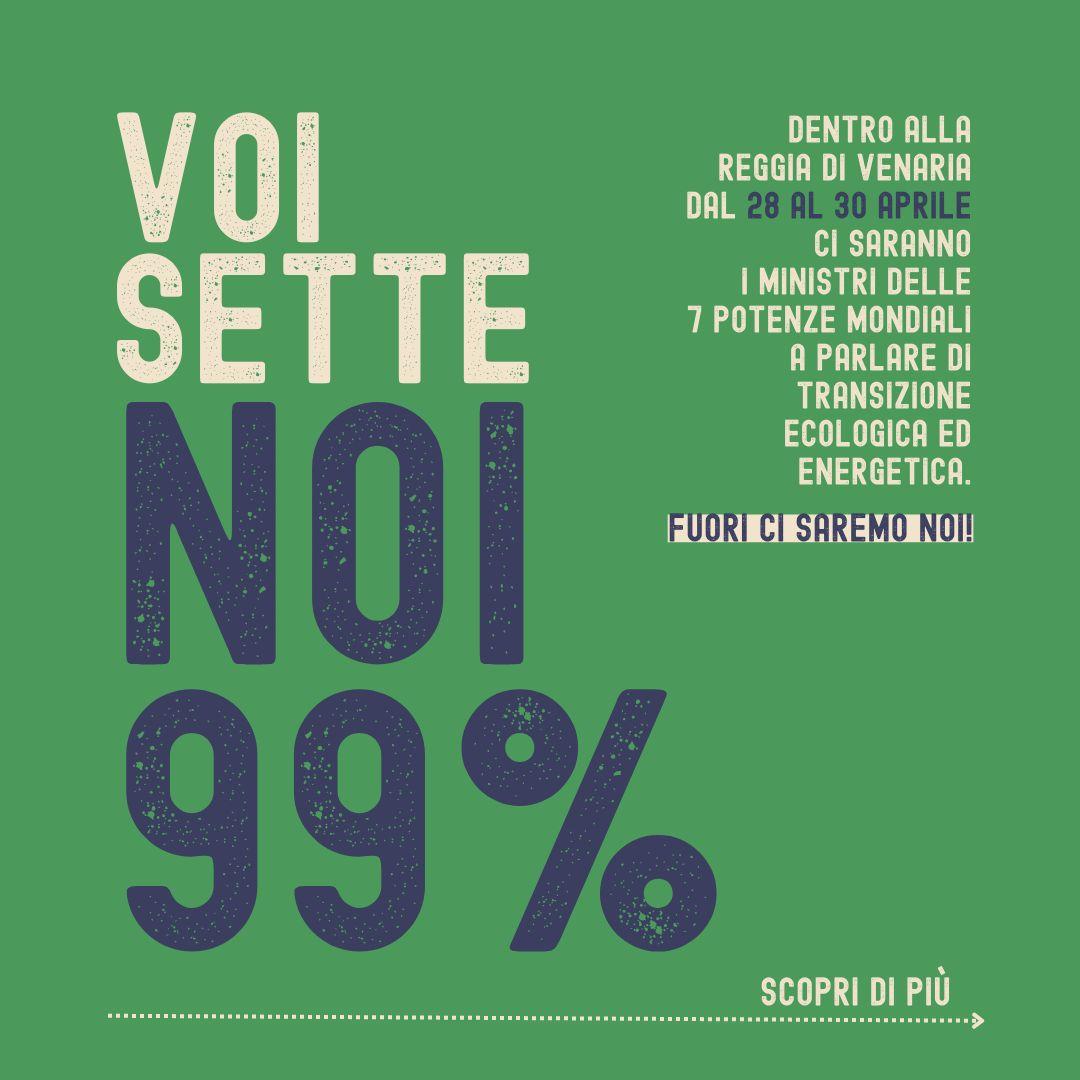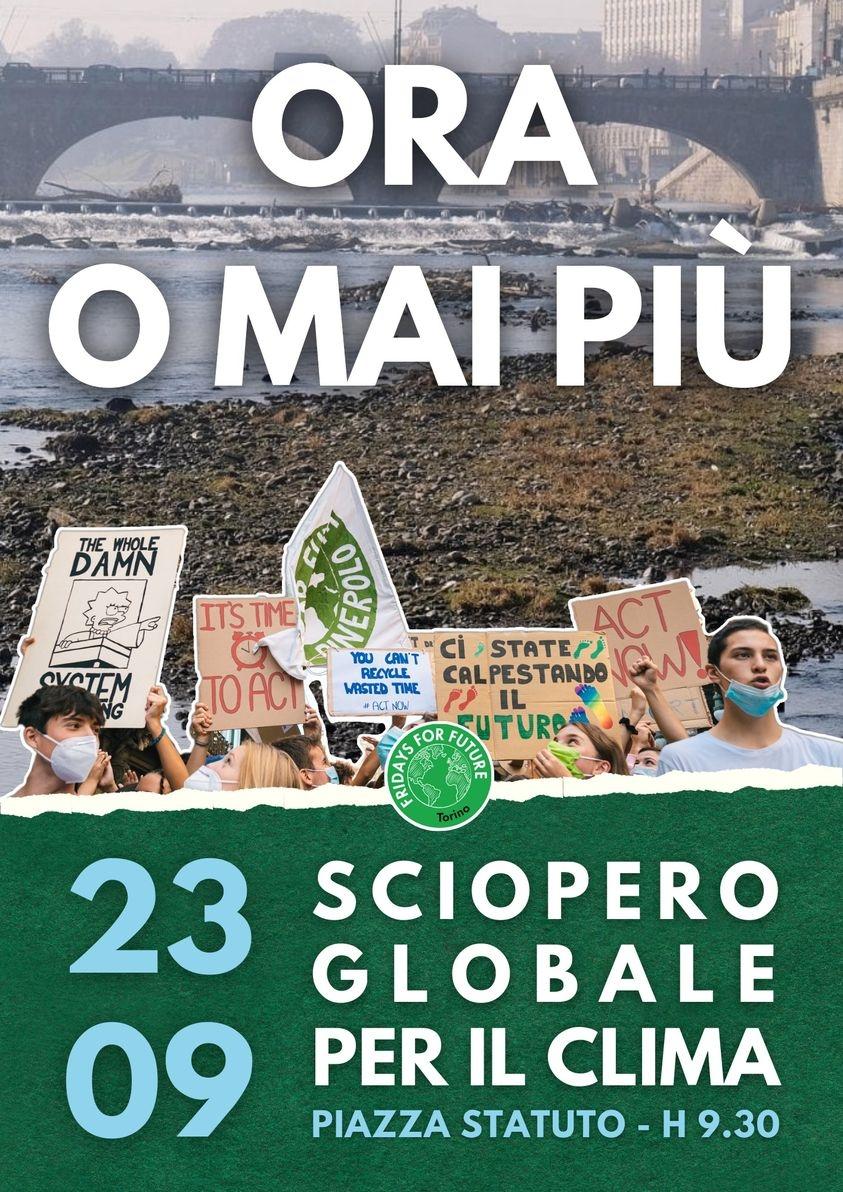Il mito dell’Antropocene

di Andreas Malm
[Dopo il successo dell’ultimo Climate Strike di settembre e in direzione dello sciopero per il clima di domani, continuiamo a proporre contributi dal dibattito internazionale sulla lotta contro il cambiamento climatico, a partire dalla necessaria attribuzione delle responsabilità effettive di questo fenomeno macroscopico e globale. Lo facciamo proponendo questo agile testo con cui l’autore – docente nel Dipartimento di Geografia Umana dell’Università di Lund e autore del monumentale «Fossil Capital. The Rise of Steam Power and the Roots of Global Warming» – si inserisce nel dibattito accademico e politico sulla problematicità del concetto di «antropocene». _ ndt]
L’anno scorso [2014] è stato il più caldo mai registrato. Ciononostante, gli ultimi dati ci dicono che nel 2013 la fonte che ha fornito più energia nuova all’economia mondiale non è stata né il solare né l’eolico, nemmeno il gas o il petrolio, ma il carbone. La crescita delle emissioni globali di gas a effetto serra – dall’1% degli anni ’90 al 3% odierno – è sconvolgente. Questo aumento va in parallelo con il sapere crescente che andiamo accumulando sulle conseguenze dell’uso dei combustibili fossili.
Chi ci conduce al disastro?
Una risposta radicale affermerebbe: la dipendenza dei capitalisti dall’estrazione ed utilizzo delle energie fossili. Ma certuni preferiscono identificare altri colpevoli. La terra, ci viene detto, è entrata oggi nell’«antropocene»: l’epoca geologica dell’umanità. Molto popolare – accettato anche da molti ricercatori marxisti – il concetto di antropocene considera l’umanità come una nuova forza geologica che trasforma il pianeta in modo spettacolare, principalmente per mezzo della combustione di quantità inaudite di carbone, gas naturale e petrolio. Secondo questi ricercatori, questa degradazione è il risultato delle attività compiute dagli umani per predisposizione innata, destino ineluttabile di un pianeta sottomesso al tran tran della produzione economica umana (business-as-usual). Di fatto, i sostenitori di questa tesi non possono sostenere il contrario, perché se questa dinamica fosse di natura un po’ più contingente, la narrazione d’una specie che nella sua interezza avrebbe raggiunto la supremazia della biosfera sarebbe difficile da difendere.
La loro storia si concentra su un elemento classico: il fuoco. Solo la specie umana può manipolare il fuoco, è dunque lei a distruggere il clima; quando i nostri antenati hanno appreso come dar fuoco alle cose, hanno acceso la miccia della crescita infinita. È in questo che risiede, come scrivono gli eminenti scienziati e specialisti del clima Michael Raupach e Josep Canadell, «il principale innesco evolutivo dell’Antropocene1» che ha condotto l’umanità alla «scoperta che l’energia poteva essere prelevata/sviluppata non solo dal carbone biotico detritico ma anche dal carbone fossile detritico, e in primo luogo dal carbone».
La «ragione principale» dell’attuale combustione di energie fossili è che «ben prima dell’era industriale una specie particolare di primati ha appreso a sfruttare le riserve energetiche stoccate nel carbone detritico». Come dire che l’aver imparato a camminare ad un anno sarebbe il motivo per cui oggi ballo la salsa; quando l’umanità ha dato fuoco al suo primo albero morto, ciò non poteva che condurre, un milione di anni dopo, che alla combustione di barili di petrolio. O ancora, secondo le parole di Will Steffen, Paul J. Crutzen e John R. McNeill: «la padronanza del fuoco da parte dei nostri antenati ha fornito all’umanità un potente mezzo di monopolio inaccessibile alle altre specie, mettendoci saldamente sulla via dell’antropocene». Secondo questa narrazione l’economia fossile corrisponde letteralmente alla creazione dell’umanità, o «della scimmia-fuoco, Homo pyrophilus», come espresso nella volgarizzazione del pensiero dell’antropocene operata da Mark Lynas, nell’opera non a caso intitolata «La specie divina» (The God Species).
Più in la nel tempo, la capacità di manipolare il fuoco avrebbe senz’alcun dubbio rappresentato una condizione necessaria alla combustione massiccia di energia fossile cominciata in Gran Bretagna agli inizi del XIX secolo. Ma ne era essa anche la causa? La cosa importante da sottolineare è qui la struttura logica della narrazione-antropocene: è un tratto universale della specie ad influenzare l’epoca geologica che gli è propria, altrimenti non si parlerebbe che di una sotto-categoria della specie. Ma la storia della natura umana può assumere molte forme, tanto nel genere antropocene che in altri discorsi sul cambiamento climatico.
Nel suo contributo all’opera collettiva Engaging with Climate Change2, lo psicanalista John Keene propone una spiegazione generale per comprendere come mai gli umani inquinano il pianeta e si rifiutano di smettere. Nella prima infanzia l’essere umano evacua i propri rifiuti corporei senza limiti, imparando presto che una madre piena di attenzioni pulirà quello che sta tra le sue gambe, cancellando le tracce di cacca e di pipì. Ne consegue l’abitudine degli esseri umani nel degradare l’ambiente in cui vivono: «credo che questi ripetuti confronti abbiano contribuito alla convinzione che il pianeta altro non sia che una “toilette-madre” capace di assorbire i nostri prodotti tossici all’infinito». Ma dove è la prova del legame necessario tra combustione delle risorse fossili e defecazione infantile? Che dire allora di quelle generazioni di umani che fino al XIX secolo padroneggiavano le due arti senza esaurire i depositi di carbone dalla terra per abbandonarli nell’atmosfera: erano forse sfinteri e bruciatori che attendevano semplicemente di realizzare il loro pieno potenziale?
È facile prendersi gioco di certe forme della psicanalisi, ma tentare di attribuire lo sviluppo industriale (business-as-usual) alle proprietà della specie umana è votato all’idiozia. Ciò che esiste ovunque e da sempre non può spiegare perché una società diverga dalle altre e sviluppi qualcosa di nuovo – come è il caso dell’energia fossile, emersa da soli due secoli ma radicatasi al punto tale che oggi la consideriamo come l’unico mezzo con cui l’umanità può produrre.

All’occorrenza il discorso dominante sul clima è totalmente impregnato di riferimenti al genere umano in quanto tale, alla natura umana, all’impresa umana, all’umanità come cattivo pilota che si è impadronito del treno. In The God Species3 possiamo leggere quanto segue: «La potenza divina è sempre più esercitata da noi stessi. Siamo i creatori della vita, ma possiamo anche esserne i distruttori». È questo il tropo più comune di questo discorsi: siamo noi, io e voi, che abbiamo creato questo disastro e che lo peggioriamo ogni giorno.
Ecco giungere allora Naomi Klein che, ne Una rivoluzione ci salverà4, disvela abilmente i molteplici modi in cui l’accumulazione del capitale in generale, e la sua variante neoliberale in particolare, gettano benzina sul fuoco consumando il sistema terrestre. Dando poca importanza ai discorsi sulla nocività universale dell’uomo, ella scrive: «siamo intrappolati perché le azioni che ci permetterebbero di evitare la catastrofe – che beneficerebbero a una vasta maggioranza – sono estremamente minacciose per quella élite che ha il controllo sulla nostra economia, il processo politico e la maggior parte dei grandi media».
Come gli rispondono i critici?
«Klein descrive la crisi climatica come un confronto tra capitalismo e pianeta» replica il filosofo John Gray dalle pagine del Guardian. «Sarebbe più corretto descrivere la crisi come un grande conflitto tra domande sempre più grandi dell’umanità e un mondo finito5». Gray non è il solo questo scisma sta diventando il grande clivaggio ideologico nel dibattito sul clima e i partigiani del consenso dominante contrattaccano. Sulla London Rewview of Books, Paul Kingsnorth, uno scrittore britannico che ha a lungo sostenuto che il movimento ambientalista dovesse dissolversi e accettare lo sprofondamento totale come comune destino, attacca: «il cambiamento climatico non è un qualcosa che un piccolo gruppo di cattivi ci ha imposto»; «alla fin fine siamo tutti implicati». E aggiunge: «è certo un messaggio meno piacevole di quello che vede il feroce 1% rovinare il pianeta e il nobile 99% opporvisi, ma è più vicino alla realtà6».
Più vicino alla realtà? Sei semplici fatti dimostrano il contrario.

La nostra epoca geologica non è quella dell’umanità ma del capitale. Certamente, una economia fossile non è necessariamente capitalista: l’Unione Sovietica e gli stati ad essa satelliti avevano i loro propri meccanismi di crescita legati a carbone, petrolio e gas. E non erano meno sporchi, inquinanti o responsabili di emissioni – forse anzi di più – dei loro avversari durante la Guerra Fredda. E allora, perché concentrarsi sul capitale? Perché indagare la questione del potere distruttore del capitale, quando gli Stati comunisti agivano in modo altrettanto tremendo?
In medicina, ci si potrebbe porre una questione simile: perché concentrare gli sforzi della ricerca sul cancro piuttosto che sul vaiolo? Entrambi possono essere fatali. Ma la Storia ha chiuso la parentesi del sistema sovietico e oggi siamo tornati al punto di partenza, laddove l’economia fossile coesiste col modo di produzione capitalista – su scala mondiale.
La variante stalinista merita una specifica inchiesta ad essa dedicata, nei suoi propri termini (essendo i suoi meccanismi di crescita di un tipo particolare). Ma noi viviamo più nell’epoca del gulag minerario di Vorkouta degli anni ’30. La nostra realtà ecologica, quella che ci riguarda tutti, è quella del mondo fondato sul capitale alimentato a vapore, mentre un socialismo eco-responsabile potrebbe intraprendere vie alternative. Il capitale, quindi, non l’umanità in quanto tale.
Malgrado il successo di Naomi Klein e le recenti mobilitazioni di piazza, questo punto di vista resta però marginale. La scienza del clima, la politica e i discorsi continuano ad essere formulati a partire dalla narrazione-antropocene: il pensiero della specie (species-thinking), la denigrazione dell’umanità, l’autoflagellazione collettiva indifferenziata, l’appello ai consumatori a correggere le loro attitudini e altre piroette ideologiche non servono ad altro che a nascondere le responsabilità di chi comanda.
Presentare taluni rapporti sociali come proprietà naturali della specie non ha nulla di nuovo. De-storicizzare, universalizzare, eternizzare e naturalizzare un modo di produzione specifico di un’epoca e di luoghi dati, tutte queste sono strategie classiche di legittimazione ideologica, che bloccano ogni prospettiva di cambiamento. Se il produttivismo (business-as-usual) è il risultato della natura umana, come potremmo mai immaginare qualcosa di differente? È perfettamente logico che i partigiani dell’antropocene e modi di pensare ad esso associati sostengano false soluzioni atte ad evitare la rimessa in questione del capitale fossile – come la geo-ingegneria8 di Mark Lynas9 e Paul Crutzen10, inventore del concetto di antropocene – o predichino la disfatta quando non la disperazione, come nel caso di Kingsnorth. Secondo quest’ultimo «è oggi evidente che è impossibile fermare il cambiamento climatico» – e, ovviamente, costruire un parco eolico è altrettanto nefasto che aprire l’ennesima centrale a carbone, perché entrambe sfigurano il paesaggio.
Senza antagonismo, non può esserci alcun cambiamento nelle società umane. L’utilizzo della categoria di specie (species-thinking), relativamente al cambiamento climatico, porta alla paralisi. Perché se tutti sono da biasimare, allora nessuno lo è.
_______
*
da: https://www.jacobinmag.com/2015/03/anthropocene-capitalism-climate-change/
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.