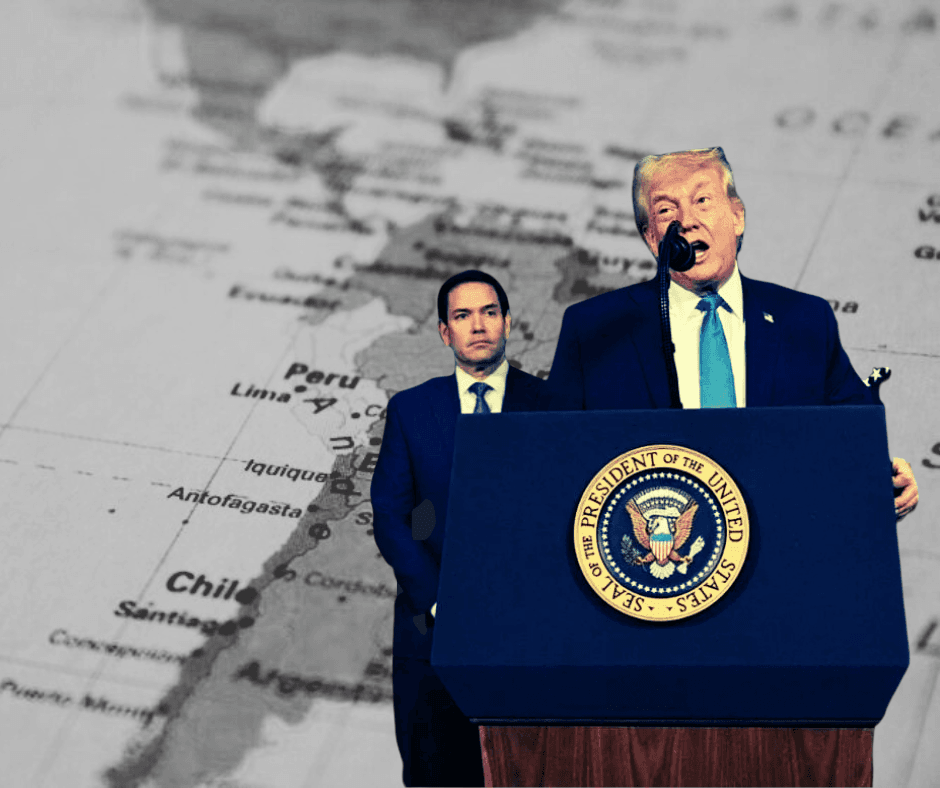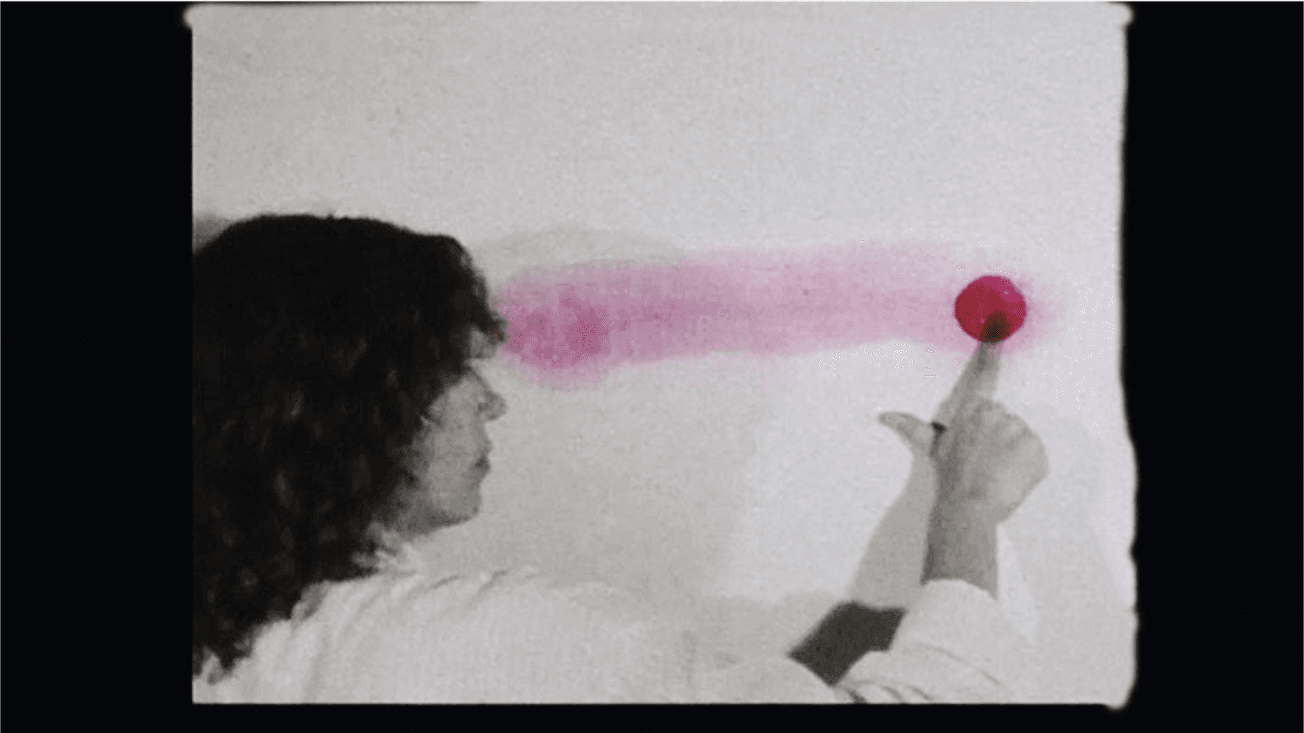Farli neri
La notizia corre sugli schermi di tutta Italia, prima sui social, poi su giornali on-line infine alla televisione: una signora si è data fuoco all’INPS. Concetta lavorava al Befed brew pub di Settimo torinese, un locale in franchising a metà tra un fastfood e una birreria dove faceva le pulizie da dieci anni. A gennaio però l’azienda decide di esternalizzare il servizio, appaltandolo a un’agenzia specializzata, e Concetta resta a casa. Inizia a combattere contro l’amministrazione, bolli, carte, certificati, nel frattempo le spese che deve sostenere rimangono le stesse. Solo il primo giugno le versano la mensilità del sussidio di disoccupazione, ma non gli arretrati. Martedì arrivata negli uffici dell’ente previdenziale davanti all’ennesimo temporeggiare dell’impiegato tira fuori dell’alcol e si dà fuoco. Tutti scappano tranne un signore marocchino, disoccupato con cinque figli, che prende un estintore e spegne le fiamme. Poi le polemiche, i 17 miliardi messi a disposizione alle banche venete pochi giorni prima (“non c’erano alternative” secondo il ministro Padoan), i messaggi sulla bacheca di Concetta, Luigi di Maio che pubblica uno status su FB, la chiamata di Laura Boldrini.
“Avevo troppi debiti. Che ne sapete voi per dirmi che non ne vale la pena?” sembra siano le poche parole raccolte prima dell’arrivo dell’ambulanza. Poco importa se siano state effettivamente pronunciate da Concetta, non ci sembra difficile immaginare che quando si perde ogni accesso al reddito le bollette si accumulano e le rate anche. Ciò che importa capire è che i salari di sussistenza e l’erosione costante della ricchezza accumulata dalle famiglie degli anni ’80-’90 hanno portato a un rapporto completamente stravolto tra debito, salario e consumo rendendoli di fatto indistinguibili. Il salario, per tantissimi lavoratori e soprattutto lavoratrici, è oggi solo pagamento di un debito pregresso. Ogni utenza, ogni spesa, ogni rata sono già stati consumati e pretendono ora di essere pagati. È qui che risiede la subordinazione totale, l’impossibilità di sottrarsi al rapporto di sfruttamento, l’equilibrio che si rompe non appena viene a mancare il salario mandando tutti sull’orlo di una crisi di nervi. Questo rapporto di dipendenza, questa filiera cortissima tra salario e consumo mediata dal debito, questo reddito just-in-time non è un effetto perverso della flessibilità e neanche la sua faccia cattiva: è il suo obiettivo. Sembra che Concetta avesse una vertenza sindacale aperta sul suo licenziamento e proprio per questo avesse avuto difficoltà a farsi riconoscere la disoccupazione. Anche qui che il fatto sia vero o meno in questa contingenza è accessorio. Ma è necessario interrogarsi anche su quanto il fiato corto influenzi la possibilità di lottare. Non ci si può fermare neanche un secondo, neanche quando se ne ha il coraggio.
Molto si è detto sulla precarietà del lavoro, al punto che la sua natura riprovevole fa oggetto oggi di un molle consenso che va da Confindustria agli editorialisti di Repubblica. Ma la precarietà ha di per sé un segno neutro e può persino rappresentare un’arma. Basta chiederlo ai facchini della logistica o agli interinali protagonisti delle uniche lotte operaie espansive in questa lunga crisi. È il rapporto di dipendenza che determina la subordinazione prima e la disperazione poi. Il sistema del welfare, che prende la forma pubblica della NASPI o le vie degli enti caritatevoli privati in cui investono sempre più massicciamente le fondazioni bancarie, deve mantenere questo rapporto. Il mito fantozziano dell’entropia burocratica è semplicemente grottesco. Chi, tra chi ha avuto a che fare con gli enti previdenziali, non si è mai detto: allora meglio lavorare? L’ottenere aiuto dev’essere anche esso un lavoro, proprio perché solo nella lavorizzazione dell’aiuto si mantiene il rapporto di subordinazione. Perché la subordinazione non scoppia mai, la subordinazione può solo implodere. È questo che fa più male. Una signora che esce di casa e scrive su Facebook che li farà neri ma poi a fine in ospedale nera bruciata ci finisce lei.
Lavorava in un pub, scrivono inizialmente i giornali. Basta cercare e viene fuori che si tratta di una grande azienda in franchising con decine di sedi in Italia. Una di quelle imprese del food che ci dicono essere l’orgoglio dell’Italia farinettiana, tutta entusiasmo e simpatia, un “binomio perfetto fra il mangiar bene e la voglia di divertirsi” per usare le parole uno degli imprenditori che l’hanno fondata. In Italia il 97% delle aziende hanno meno di 15 dipendenti, i soli settori che assumono sono quelli delle cooperative magari di multiservizi proprio come quella che sta sostituendo Concetta nel suo vecchio lavoro al Befed brew. Qui si gioca la partita e quindi qui bisogna rompere l’isolamento. Niente frasi retoriche, niente mai-più-come-Concetta perché sarebbero fanfaronate da mitomani o promesse da social network. È inutile ragionare in termini di grandi e piccole aziende, in questo sistema economico tutto è interconnesso in un gioco di appalti e subappalti, intermediari e caporali fatto per spremerci fino all’ultimo, per tenerci lo sguardo basso, le mani occupate e le teste preoccupate. Non lo diciamo per annacquare le responsabilità nella genericità del capitalista collettivo. Lo diciamo per nominare il campo di uno scontro già in atto.
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.